BLOG
Snake oil salesmen (and saleswomen)
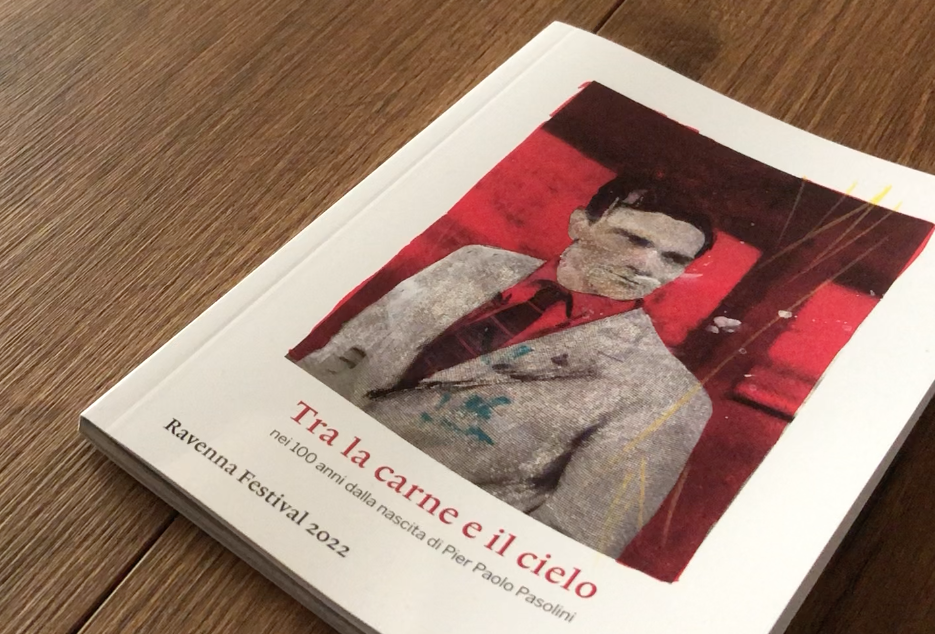
Is poetry of any use? There are those who measure necessity solely on basic needs, and, in the short time we are allowed, accumulate an inordinate amount of objects of no use. There are those who prophesy that we will all die without them, but this has not yet been disproved. And there are those who try, but need a ball of thread not to get lost in the labyrinth of verses. But the Minotaur is always lurking there, and it is called “narrative reason”: where is the history of poetry? It is called school—years spent studying poetry only to abandon it for good. It is called procrastination—always finding an easy verse to quote when necessary, with no need for a book at home. And yet...
Yet, in the difficult moments of life, there is nothing like poetry to inspire us to brave, desperate, passionate action. Or to resistance. It is no coincidence that, besides music, which has always accompanied armies to the front, our other ally in the absurdity of armies has always been poetry. Poetry is not a candid object; it is, rather, an incandescent, pyromaniacal one. Poetry inflames, disrupts, and also comforts. Prayers are poems, too. Verses are amulets that can protect as well as cast curses. They are cigarettes that burn the skin, and poets are the sorcerers who roll them.
Which is why Costantini’s portraits are permanently shrouded in smoke. The men and women authors he has selected are connected with each other, linked by a material vapour that suggests they belong in the lineage of wizards and witches. These faces, made impervious to time by the clear line that makes their forms a synthesis, also compose the emotional and literary atlas of the artist, who gives us his Decalogue, his personal ball of thread to guide us through the thick forest of poetry without getting lost. This combination of lines and words, which implies the concrete absence of the subject portrayed, composes an autobiographical mosaic of the artist, as well as a viaticum for the viewer or reader, an antidote, an exorcism through visual poetry. Or a lucid vision—in Burroughs’s words, “until the bare lies shine through.”
Elettra Stamboulis

Venditori e venditrici di fumo
Ma la poesia serve a qualcosa? C'è chi misura la necessità unicamente sui bisogni primari, e acquisisce nel tempo breve che ci è concesso uno smisurato numero di oggetti di nessuna utilità. C'è chi vaticina che senza moriremo tutti, ma ancora non è stato smentito. E c'è chi ci prova, ma ha bisogno di un gomitolo per non perdersi nel labirinto dei versi. Ma il Minotauro è sempre lì in agguato, e si chiama ragione narrativa - dov'è la storia della poesia?. Si chiama scuola - anni a studiare poesia per sempre abbandonarla. Si chiama procrastinazione - trovare sempre un versetto facile da citare in caso di necessità senza bisogno di avere manco un libro a casa. Eppure.
Eppure nei momenti difficili della vita niente come la poesia ci spinge a fare azioni coraggiose, disperate e passionali. Oppure a resistere. Non a caso, oltre alla musica che sempre ha accompagnato gli eserciti al fronte, l'altra alleata dell'insensatezza delle armate è sempre stata lei, la poesia. Che non può essere considerata come un oggetto candido, ma è anzi incandescente e piromane. La poesia incendia, scompone e anche conforta. Anche le preghiere sono poesie. I versi sono amuleti che possono proteggere, ma anche lanciare maledizioni. Sono sigarette accese sulla pelle e i poeti sono gli stregoni che le preparano.
Ecco perché i ritratti di Costantini sono avvolti da questo fumo continuo. Gli autori e le autrici che ha selezionato sono in unione tra loro, legati da questo vapore oggettuale, quello che mostra che sono della schiatta dei maghi e delle fattucchiere. Questi volti, resi insensibili al tempo dalla linea chiara che rende le loro forme una sintesi, costruiscono anche l'atlante emotivo e letterario del disegnatore, che ci consegna il suo decalogo, il suo personale gomitolo per addentrarsi nel folto bosco della poesia e non perdersi. Questo insieme di linee e parole, che presuppone la concreta assenza del soggetto ritratto, costruisce un mosaico autobiografico dell'artista, ma anche un viatico per che guarda o legge, un antidoto, uno scongiuro mediante poesia visiva. O anche una lucida visione , fin quando la nuda menzogna non vi splenda attraverso, per citare Burroughs.
Elettra Stamboulis
Uno sguardo afrofuturista

Uno sguardo afrofuturista.
di Elettra Stamboulis
L'afrofuturismo è nato ieri, ma ha come orizzonte solo il domani. L'aspetto peculiare di questo poliedrico movimento estetico, nato sostanzialmente negli anni '70 e '80 tra gli afroamericani, ma divenuto ben presto un prisma comune alla diaspora africana nera in generale, è l'indagine sul tempo. Movimento composito, fatto di artisti visivi, musicisti (da Sun Ra ai Public Enemy), teorici e attivisti/e, ha nel suo DNA l'immaginare una giustizia più vasta e una più libera soggettività nera nel futuro. Futuro che può essere anche distopico: l'aspetto però che non manca mai in questo tipo di sguardo è la messa in discussione della temporalità lineare. Il termine fu coniato da Mark Dery nel 19941, che esordiva citando Orwell "chi controlla il passato, controlla il futuro: chi controlla il presente, controlla il passato". Dery partiva da un quesito formale, perché gli intellettuali afroamericani non fanno science fiction? Non immaginano il futuro? E per rispondere, interrogava una serie di importanti testimoni, per scoprire che non c'è un unico modo di porre quesiti sul futuro. Victor Fotso Nyie è sicuramente un artista che interpreta il mondo utilizzando gli occhiali afrofuturisti. Lo fa utilizzando una tecnica antichissima, primordiale, che Cavalli Sforza2 considera provenire dall'Africa Sahariana come i geni, i popoli, le lingue, circa 100.000 anni fa. Proprio il genetista di Stanford, che utilizza diffusamente dati genetici, la mappatura del DNA, l'archeologia e la linguistica, definisce la cultura come il più valido strumento di adattamento biologico. Nelle figure antropomorfe di Victor, che evocano nelle forme qualcosa di profondamente arcaico, sopito nel nostro subconscio archetipico, lì dove alberga la percezione della nostra comune specie, c'è un elemento ironico, che rompe la prevedibilità della forma, inserendo una possibile "futurità", a partire dai due gemelli (un elemento prettamente autobiografico, sono la rappresentazione dei suoi fratelli minori) che reggono un vassoio patrimoniale dorato. Oggetti scomposti e anacronistici, che portano il passato del patrimonio africano naufragato e saccheggiato, ad una tavola imbandita di futuro. "Che cosa se ne potrebbero fare di una restituzione ora del patrimonio de-identificato e sottratto al suo tempo i miei fratelli?", si chiede l'artista. Certo, la memoria ha gole profonde, ristagna e forme pozze dove meno ce l'aspettiamo, in attesa che la corrente riprenda. Non ha un andamento lineare, ci dice l'afrofuturismo. E così il ragazzo dormiente, con la copia di un'opera originale tradizionale tra le mani, immagina un futuro possibile, ma ancora che rimane onirico.
Il sogno è un elemento ricorrente e trasparente in questa serie di lavori: da Rêve lucide in cui il sogno lucido porta ad una possibilità di allattamento dorato a Suivre ses rêves in cui l'aspetto autobiografico si connette alle aspettative di un continente. Il mondo inconscio culturalmente inesplorato di generazioni diventa terra tra le mani ed è forgiato dal giovane camerunense con estrema maestria tecnica unita ad uno sguardo acuto, un Regard passioné per citare un altro titolo, ironico, ma anche determinato e non subalterno.
La figura inquieta di Vue céleste che guarda spietatamente lo spettatore che si riflette negli occhi incavati e dorati ci ricorda quanto il sacro ci riporti alla nostra limitatezza, al nostro limite materiale e visivo, al nostro sguardo che spesso ha orizzonti supinamente post coloniali.
La graine qui germe è quindi una promessa, una scommessa, un intento civile e artistico. Il seme che può germogliare dalla riconnessione con la propria storia culturale potrebbe costituire un parto intellettuale nuovo, dorato, sorpreso. E Victor ci ricorda che questo cambiamento è possibile.
1 M. Dery, “Black to the Future: Interviews with Samuel R. Delany, Greg Tate, and Tricia Rose.” In Flame Wars:
The Discourse of Cyberculture. Edited by Mark Dery, 179–222. Durham, NC: Duke University Press, 1994.
2 L.L. Cavalli Sforza, Geni, popoli e lingue, Adelphi, Milano - 1997 (ed. or. 1996)
La Cina (non) è vicina BADIUCAO – opere di un artista dissidente

Il Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei, presieduta da Francesca Bazoli e diretta da Stefano Karadjov, presentano per la prima volta in Italia un nuovo progetto espositivo dell’artista dissidente cinese, residente in Australia, Badiucao (Shangai, Cina, 1986): la mostra La Cina (non) è vicina. BADIUCAO – opere di un artista dissidente, a cura di Elettra Stamboulis, si terrà dal 13 novembre 2021 al 13 febbraio 2022 negli spazi espositivi del Museo di Santa Giulia di Brescia.
La mostra rappresenta l’evento di punta del Festival della Pace, organizzato dal Comune e dalla Provincia di Brescia dal 12 al 26 novembre 2021. L’evento, giunto alla sua IV edizione, vanta ad oggi il Patrocinio del Parlamento Europeo e di Amnesty International.
L’esposizione La Cina (non) è vicina. BADIUCAO - opere di un artista dissidente è la prima personale dedicata a Badiucao, pseudonimo dell’artista-attivista cinese noto per la sua arte di
protesta, attualmente operante in esilio in Australia. Il percorso espositivo ripercorre l’attività artistica di Badiucao, dagli esordi alle opere più recenti che sono nate in risposta
alla crisi sanitaria innescata dalla pandemia di Covid-19.

Badiucao, spesso conosciuto come il Banksy cinese, si è affermato sul palcoscenico internazionale grazie ai social media, coi quali diffonde la propria arte in tutto il mondo – il suo account twitter @badiucao è seguito da più 80 mila persone –, e sfida costantemente il governo e la censura cinese. La sua vocazione artistico-politica nasce nel 2007, quando, studente di Legge all’Università di Shanghai vede il documentario The
Gate of Heavenly Peace, un girato clandestino diretto da Carma Hinton e Richard Gordon sulle proteste di Piazza Tienanmen. L'artista sviluppa una ferma decisione di esprimersi in prima linea contro ogni forma di controllo ideologico e morale esercitato dal potere politico, a favore della trasmissione di una memoria storica non plagiata. Il suo impegno politico si realizza, infatti, nella creazione di campagne partecipative, affissioni in luoghi pubblici, illustrazioni e attività online, spesso costruite con un linguaggio visivo che evoca ironicamente lo spirito pop della propaganda comunista, ricalcandone lo stile grafico, i colori e i toni.
Grazie al suo blog, ai social media e a campagne di comunicazione organizzate, Badiucao dall’Australia ha portato avanti la propria attività di resistenza, diventando l’unico canale non filtrato dal controllo governativo capace di trasmettere i racconti dei cittadini di Wuhan durante il lockdown del 2020.
Nel 2020 gli è stato conferito dalla Human Rights Foundation il Premio Václav Havel Prize for Creative Dissent, destinato ad artisti che creativamente denunciano gli inganni delle dittature.

Elettra Stamboulis, curatrice della mostra, commenta: “Il lavoro di mappatura degli artisti dissidenti, attivisti politici e visualmente militanti, continua con questo progetto espositivo: al centro la poetica dell’artista cinese che collabora con i movimenti del tè al latte. Il Milk tea Alliance è formato da Net Citizen che operano ad Hong Kong, Taiwan, Thailandia e Birmania. Sono tra gli artefici e promotori delle più importanti manifestazioni per la democrazia e i diritti umani in Estremo Oriente, e Badiucao è il loro artista”.
Tanti i temi affrontati dalla mostra nelle diverse sezioni che verranno allestite. Dalle opere pittoriche e multimateriali che testimoniano le violazioni dei diritti umani, alla censura inflitta ai cittadini cinesi sul tema Covid-19, dalla repressione del dissenso in Myanmar durante il colpo di stato militare del 2021 al tema dell’assimilazione culturale forzata degli Uiguri, fino al dettagliato racconto in chiave artistica delle proteste degli ultimi anni che hanno visto la popolazione di Hong Kong battersi per contrastare la linea politica governativa a Hong Kong.
“La Fondazione Brescia Musei sta preparando in queste settimane un nuovo importante evento espositivo, dedicato al rapporto tra arte contemporanea e diritti”, afferma Stefano Karadjov, direttore della Fondazione Brescia Musei. “Questa volta la mostra dedicata al dissidente cinese Badiucao, esule in Australia da una decina di anni e mai esposto in Occidente, sarà una vera e propria rivelazione fatta di installazioni multimateriali, tele, opere grafiche e cartoon. Ciò che rende davvero importante questo impegno è che l’artista stesso è presente a Brescia per l’allestimento delle proprie installazioni e per il fitting del set up agli spazi che sarà particolarmente originale visto che l’arte di Badiucao attraversa i generi e ammicca alla iconografia della propaganda rivelando però un’ironia tagliente espressa nei colori e nei toni pop e in uno stile grafico incredibilmente moderno. Una vera rivelazione, che aspetta da metà novembre il pubblico italiano a Brescia nuovamente al centro della discussione attorno ai temi del contemporaneo”.

Con questo nuovo progetto Fondazione Brescia Musei, insieme al Comune di Brescia, prosegue il percorso iniziato nel 2019 con la mostra Avremo anche giorni migliori. Zehra Doğan. Opere dalle carceri turche, nella quale l’artista curda, attraverso l’esposizione di una sessantina di opere inedite, ha intersecato e intrecciato la propria vicenda personale con i drammatici eventi politici della più stringente attualità, evidenziando la relazione tra opere contemporanee e diritti umani. Dopo il successo di Brescia, una selezione di opere di Zehra Doğan sono state esposte nel 2021 al PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano.
Un format espositivo dedicato alla narrazione del contemporaneo attraverso l’arte, un dialogo grazie al quale vengono interpretati i più significativi fenomeni storici attuali. Arte contemporanea e diritti umani trovano quindi un punto di sintesi nella rivelazione di artisti dissidenti e attivisti, per lo più inediti in Occidente.

“Fondazione Brescia Musei ha intrapreso un paio di anni fa un percorso dedicato alla comprensione dell’arte contemporanea quale forma di espressione particolarmente forte e simbolica delle sofferenze vissute nei contesti in cui la libertà di parola, di espressione, di movimento è limitata o fortemente violata”, dichiara Francesca Bazoli, presidente della Fondazione Brescia Musei. “Questo format, che ci permette ogni anno di esporre un artista che opera in quadranti geopolitici impegnativi, consente alla nostra istituzione di definire al meglio una voce autonoma e autentica nel panorama italiano dell’arte contemporanea. Sono dunque particolarmente felice che ci accingiamo a replicare l'esperienza estremamente positiva già avviata con Zehra Doğan nel 2019, con un altro artista nuovamente giovane, inedito in occidente e colmo di passione civile e coraggio”.
“A ormai solo poco più di un anno dal 2023, quando Brescia – assieme a Bergamo – avrà l’onore e l’onere di mostrarsi a tutto il Paese e oltre come Capitale Italiana della Cultura, appare non
solo giusto ma direi doveroso che la nostra città prosegua, con la mostra dedicata a Badiucao, quel percorso iniziato con la mostra di Zehra Dogan e teso a sottolineare l’indissolubile legame tra
arte e libertà”. Così afferma la Vicesindaco e Assessore alla Cultura Laura Castelletti, aggiungendo che “la libertà di creare è un diritto fondamentale come quello di
parola, di cui non è che una diversa forma espressiva. In questo senso, va accudita e tutelata in quanto risorsa per ogni democrazia e per le comunità. Brescia non vuole solo essere capitale
della cultura, ma capitale di culture, aperte, libere, plurali. Accogliere e conoscere più da vicino l’opera di Badiucao ne è una straordinaria conferma”.
“La mostra dedicata a Badiucao è il secondo momento di un percorso, iniziato con Zehra Dogan, con un profondo significato”, commenta Roberto Cammarata, Presidente del Consiglio del Comune di Brescia. “Il Festival della Pace, questa sarà la IV edizione, ha travalicato i confini di Brescia proprio grazie alla forza comunicativa dell'arte di Zehra Dogan. Ora, con Badiucao, daremo ancora una volta spazio, voce, riconoscimento e visibilità a chi vede i propri diritti violati, a chi ha perso la sua libertà, ma ha tanto da dire anche a noi. Il lavoro di Zehra passa nelle mani di Badiucao come un testimone e, allo stesso modo, la nostra voce si fa testimonianza per permettere a questo messaggio di diffondersi, facendo arrivare lontano la voce di tutti coloro che non possono parlare. A questo proposito, il nostro pensiero non può che andare a Patrick Zaky: durante il Festival verrà assegnato per la prima volta il premio Brescia Città della Pace, che quest'anno sarà dato proprio a lui. Non potendolo ritirare personalmente perché incarcerato in Egitto, riceverà il premio Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia”.
La schiena di Zehra e le altre. Prigione n°5

Piegati, amore, finché non passa la tempesta
Mi sono piegata così tanto che la mia schiena è diventata un arco. Quando scoccherai la tua freccia?
(Allunghi le mani e trovi una manciata di farina)
Piegati, amore, finche non passa la tempesta
Mi sono piegata così tanto che la mia schiena è diventata un ponte. Quando lo attraverserai?
(Cerchi di spostare il piede, ma il ferro non si sposta)
Piegati, amore, finché non passa la tempesta
Mi sono piegata così tanto che la mia schiena è diventata un punto interrogativo. Quando risponderai?
(L'agente che conduce l'interrogatorio mette un disco pieno di applausi).
Mahmud Darwish,
Diario di ordinaria tristezza, in Una trilogia palestinese, Milano 2014, p. 57
Darwish, insieme a Edward Said, è la voce che testimonia l'esistenza della cultura palestinese, il popolo senza patria per eccellenza, dicono. Dicono perché la terra che loro abitavano è stata concessa ad altri come risarcimento per il grande male che l'Europa aveva commesso verso di loro. Anche i curdi sono un popolo senza patria, ma non essendo legato questo spoglio, almeno direttamente, alle mani delle potenze occidentali, spesso sono dimenticati nell'elenco dei senza terra. C'è però un'altra ragione: il nostro ondivago oblio, che si ricorda dei curdi quando diventano utili alleati on the ground per dirimere conflitti in cui anche gli eserciti più forti della terra si trovano in difficoltà, è rinforzato dall'assenza delle voci di questo popolo, dalla insipienza nostra verso questa specifica cultura. Zehra Doğan si è trovata ad essere la voce più autorevole, la sintesi iconica di queste molte voci silenziate. E non è un caso che sia una donna.
L'assertività del percorso artistico, politico ed intellettuale di Zehra e delle altre si basa su un presupposto ideologico importante, che viene ripreso anche in questa importante Graphic Memoir, ovvero la gineologia (in curdo jineolojî) messa a punto dal prigioniero politico zero dell'odierno regime turco, Öcalan. Nel testo Liberare la vita - La rivoluzione delle donne pubblicato in inglese nel 2013, che comprende suoi testi precedenti al rapimento e all'arresto del 1999, l'ideologo curdo analizzava il processo antropologico che ha portato alla costruzione del patriarcato, riflettendo sull'esperienza socialista e sui suoi limiti rispetto ai processi liberatori, facendolo concludere che senza un processo completo di liberazione del femminile la libertà non può essere conseguita pienamente.
Le sue teorie si sono tradotte in pratiche di governo e di istruzione in Rojava e anche nelle città che sono state guidate da sindaci e sindache curdi, ma soprattutto si sono innestate in una cultura, che come tutte subisce processi di trasformazione sociale che partono dalla narrazione culturale, e sono divenute una delle componenti fondamentali del pensiero politico connesso al processo di emancipazione del popolo curdo.
La Scienza delle donne, come la definisce il leader del PKK, è il presupposto che sta alla base di questo libro, dell'esperienza di Zehra e delle molte altre detenute politiche e non, nelle carceri turche, ma anche siriane. Lo è nel senso che senza questa forte determinazione a prendere la parola, a dirsi protagoniste della propria vita e del cambiamento, non si capirebbe da dove emerge questa assenza profonda di vittimismo, questo ribaltare i ruoli tra vittima e carnefice. Molti commentatori l'hanno definita determinazione alla speranza, che è anche una virtù teologale connessa con la fede nella felicità eterna, ed è quindi una categoria utopistica e che pone fuori dal portato politico l'orizzonte della felicità. Non rappresenta quindi in modo corretto lo sguardo delle attiviste curde, schiettamente femministe e impegnate a costruire in questo mondo una realtà diversa.
Da quando la conosco e curo il suo lavoro d'artista, ho potuto notare quanto questa intrinseca connessione tra identità politica e fare artistico mettesse in difficoltà i suoi interlocutori
occidentali. Joyce Lussu, la straordinaria mediatrice tra noi e Nazim Hikmet, scriveva di lui: Vita e poesia, azione e parola, erano legate in modo così organico e solare, che è illuminante
per conoscere la sua poesia, conoscere le sue vicende. Lo stesso si può dire di Doğan, parafrasando però la parola vicende con "la cultura politica del femminismo curdo". E anche questo
libro ne è testimonianza.
Siamo di fronte ad un testo dallo straordinario valore storico, antropologico, artistico. Che si inserisce ovviamente nel filone della letteratura carceraria (che da Boezio a Marco Polo ci è nota), passando attraverso l'egiziana Nawal El Saadawi, che reclusa da Sadat nel 1981 a seguito delle sue critiche alle politiche governative non solo non smise di scrivere - Il pericolo ha fatto parte della mia vita da quando ho preso in mano una penna e ho scritto. Niente è più pericoloso della verità in un mondo che mente - ma lo fece usando qualsiasi cosa fosse a portata di mano, come ha fatto Zehra in carcere. Lo fece soprattutto senza dimenticare le altre, perché come scrive Zehra "senza le altre sei perduta" e quindi Nawal appena uscita fondò l'Associazione Arab Women Solidarity. Chiaramente c'è nella narrazione sull'enorme prigione turca sempre come riferimento Nazim Hikmet e il suo Poema dal carcere. C'è quindi un mondo di rimandi e sottili emersioni di questa linea rossa della letteratura umana reclusa che è tutta humus per questo fumetto, scritto sul retro delle lettere ricevute da un'amica attivista turca naturalizzata francese, durante il periodo di prigionia.
C'è però una peculiarità che va subito riconosciuta e circoscritta, ed è che si tratta del primo fumetto realizzato in un carcere in diretta, fatto "evadere" come le opere dell'artista attraverso una rete di attivisti, realizzato quindi in stretta collaborazione con le altre e in forma mista, disegnata e scritta. C'è infatti anche una certa tradizione del fumetto carcerario, cito ad esempio In prigione del giapponese Hanawa, o Pericolose in cui la protagonista della storia Zezè è stata coadiuvata da Hermans nel renderla una Graphic, o il più letterario ma ugualmente forte e diretto Una metamorfosi iraniana di Mana Neyestani, in cui gli autori e autrici sono anche testimoni diretti dell'esperienza carceraria narrata. Tuttavia qui siamo di fronte a qualcosa di diverso, perché in tutti gli altri casi menzionati si tratta di una rielaborazione personale dell'esperienza di reclusione fatta ex post, una volta fuori dalle mura. Qui invece abbiamo il "privilegio" di entrare nelle celle della prigione 5, e in quella di Tarso, nel momento in cui Zehra disegna e scrive. Siamo di fronte a un documento storico, oltreché artistico.
Mi soffermo un attimo anche su quest'ultimo aggettivo, perché anche in questo c'è un post quem, una unicità. Si tratta infatti di di un fumetto di un'artista, che al momento dell'arresto era piuttosto conosciuta per la sua attività di giornalista, per la quale aveva ricevuto il prestigioso premio Metin Göktepe nel 2015 per il suo lavoro di indagine sul campo sulle donne yazide. Il premio, ricevuto a soli 26 anni, viene conferito in memoria del giornalista omonimo, morto sotto la custodia della polizia nel 1988 e in un certo senso fu una sorta di profezia che in parte si è auto avverata. Comunque arrestata e condannata per un disegno, formata all'Accademia di Belle Arti della sua città di origine, con all'attivo alcune mostre realizzate in luoghi militanti, Zehra è diventata un'artista contemporanea in carcere attivando le sue risorse più profonde, grazie alla palestra di formazione che è la prigionia delle detenute politiche, al lavoro collettivo, a quella che ha definito "la lotta contro la pigrizia della reclusione". Appena è stata liberata, dopo aver scontato tutti i giorni previsti dalla sentenza, è dovuta andare in esilio volontario e a Londra la aspettava una istallazione alla Tate Gallery. Nel giro di poco tempo è stata acclamata come una dei 100 artisti più influenti al mondo.
Conosciamo l'intrinseco senso di colpa che il modo del fumetto e dei fumettisti si portano addosso da sempre, per il quale è sempre opportuno puntualizzare che malgrado facciano fumetti, sono artisti, oppure che "ricordiamoci che il fumetto è arte", e via dicendo. Ecco, il libro di Zehra spiazza per questo, perché non si tratta come spesso è successo di un passaggio dal fumetto all'Arte (spesso senza ritorno, vedi ad esempio Marjane Satrapi oppure per rimanere in ambito italiano, Marcello Jori) perché il ritorno all'arte sequenziale viene visto come una condanna. Non voglio con questo dimenticare la stagione che va dai Metal Hurlant a quello che Francesca Alinovi definì il nuovo fumetto italiano, un momento di inestricabile energia e di ricerca che ancora non ha dissipato le sue particelle atomiche. Che sembrano tutte esplodere nelle pagine di questa Graphic, che non a caso esce in contemporanea in Francia e in Italia, creando come una saldatura di vicende artistiche che sembrano trovare una sintesi in questa opera. Doğan intuisce quello che è stato, pur non conoscendolo materialmente, provenendo da un paese che ha una importantissima tradizione di fumetto popolare, alternativa e di ricerca, che ha seguito però strade sostanzialmente proprie. Raccoglie queste intuizioni, creando pagine che sembrano combaciare con quanto sempre Alinovi scriveva proprio di Jori su Flash Art nel 1982, quando parlava di penetrazione, attraverso cunicoli ramificati come arterie di sangue, dentro al grembo della terra-utero materno. Una definizione che sembra perfetta per queste pagine.
Vorrei aggiungere infine un'ultima osservazione: questo libro è pieno di nomi e cognomi, di chi ha attraversato per colpa delle proprie idee, le porte della galera. Credo non sia un caso che sia edito proprio da Becco Giallo che è stata la prima casa editrice a dedicare una finestra importante, utilizzando il fumetto, alle vite e quindi ai nomi e ai cognomi di chi si è dedicato alla verità e giustizia. Così, come si fa nel primo giorno di primavera con Libera e che coincide con il Newroz, il capodanno curdo, ripetiamo questi nomi insieme al libro, in una forma di liturgia laica che preservi il senso di queste e questi testimoni dimenticati. La schiena di Zehra e le altre è una freccia, un ponte e un punto interrogativo per tutte noi.
Zehra Doğan’ın çizgi romanı “5 No’lu cezaevi”, iki dilden yayınlandı

Courbe-toi, mon amour, le temps que passe la bourrasque.
Je me suis tellement penché que mon dos est devenu un arc. Quand vas-tu tirer ta flèche ?
(Tends la main et trouve une poignée de farine)
Courbe-toi, mon amour, le temps que passe la bourrasque.
Je me suis tellement penché que mon dos est devenu un pont. Quand le traverseras-tu ?
(Tu essaies de bouger ton pied, mais le fer ne bouge pas)
Courbe-toi, mon amour, le temps que passe la bourrasque.
Je me suis tellement penché que mon dos est devenu un point d’interrogation. Quand vas-tu répondre ?
(L’agent qui mène l’entretien fait un record d’applaudissements).
Mahmud Darwish
Journal d’une tristesse ordinaire.
Darwish’in, Edward Said ile birlikte, vatansız Filistinlilerin kültürlerinin varlığına tanıklık eden ses olduğu söylenir. Öyle ki yaşadıkları toprakların Avrupa’nın işlediği büyük kötülüğün tazminatı olarak başkalarına verildiğini söylüyorlar.
Aynı şekilde Kürtler de vatansız bir halk olsalar da, Batılı güçlere bu şekilde direkt olarak bağlı olmadıkları için, çoğunlukla topraksızlar listesinde unutuluveriyorlar. Ancak başka bir neden daha var: sarsak hafızamız. Dünyanın en güçlü ordularının bile zorlandığı çatışmaları çözmek için sadece sahada yararlı müttefikler haline geldiklerinde Kürtleri anımsayan hafızamız. Bu halkın seslerini duymayışımızla, bu kültüre karşı olan umursamazlığımızla birleştiğinde daha da sarsaklayan hafızamız.
Zehra Doğan, bu sessizleştirilen seslerin ikonik bir sentezi olan en yetkili ses olduğunu gösterdi. Bu sesin kadın olması tesadüf değil.
Zehra’nın ve diğerlerinin iddialı sanatsal, siyasi ve entelektüel yolculukları bu önemli Graphic Memoir’da (Grafik Hafıza) da görülebileceği üzere Türkiye’de siyasi mahkum olan Öcalan’ın geliştirdiği jineolojî gibi önemli bir ideolojik temele dayanıyor. Kürt ideolog, 1999 yılında kaçırılma ve tutuklanmasından önce kaleme aldığı 2013 yılında İngilizce olarak yayınlanan Liberating Life: Woman’s Revolution (Özgür Yaşam – Kadınların Devrimi) metninde, ataerkilliğin inşasına yol açan antropolojik süreci analiz ediyordu. Sosyalist deneyim ve özgürleştirici süreçlere ilişkin sınırlar hakkında derinlemesine incelemeleri onun, kadının özgürleşme süreci olmadan özgürlüğün tam olarak elde edilemeyeceği sonucuna varmasına neden oldu.
Teorileri, Rojava’da ve diğer Kürt belediye başkanları tarafından yönetilen illerde, yönetim ve eğitim uygulamalarına dönüştü. Ancak her şeyden önce, tüm kültürel anlatılardan yola çıkan toplumsal dönüşümlerde olduğu gibi kültürün içine enjekte oldular. Böylece, Kürt halkının özgürleşme süreciyle bağlantılı olan siyasi düşüncenin temel bileşenlerinden biri haline geldiler.
PKK liderinin tanımladığı şekliyle Kadın Bilimi, Zehra’nın ve Türkiye’de ya da Suriye’de, diğer birçok siyasi ve siyasi olmayan mahkumun deneyimlerinin yanı sıra aynı zamanda bu kitabın altında yatan temel varsayımdır. Bu varsayımı anlamadan, kadınların kendi hayatlarının ve değişimin baş kahramanları olduklarını söylemek için bu güçlü kararlılığın, kurban ve cellat rollerini altüst ederek kurban olmayı reddeden anlayışın nereden geldiğini göremeyiz. Pek çok eleştirmen bunu sonsuz mutluluk inancıyla bağlantılı teolojik bir erdem olan, bu nedenle mutluluğun ufkunu siyasi erişimin dışına çıkaran ve ütopik bir kategori olan umut kararlılığı olarak tanımladı. Bu, sonuna kadar feminist olan ve bu dünyada farklı bir gerçeklik inşa etmeye kararlı olan Kürt aktivistlerin bakışlarını doğru bir şekilde temsil etmiyor.
Onu ilk tanıdığım zamandan ve bir sanatçı olarak çalışmalarıyla ilgilendiğimden beri, siyasi kimlik ile sanatsal davranış arasındaki bu içsel bağlantının Batılı muhataplarını ne kadar zor durumda bıraktığını fark ettim. Nazım Hikmet ile aramızdaki olağanüstü aracı Joyce Lussu onun hakkında şunları yazmıştı: “Hayat ve şiir, eylem ve söz öylesine organik ve parlak bir şekilde birbirine bağlıydı ki hikayelerini bilmek sırlarını anlamak için aydınlatıcı oluyordu”. Hikaye sözcüğünü “Kürt feminizminin siyasal kültürü” ile değiştirirsek Zehra için de aynı şey söylenebilir.
Ve bu kitap tam da buna tanıklık ediyor.
Olağanüstü tarihsel, antropolojik ve sanatsal değeri olan, hapishane edebiyatı (Boethius’tan Marco Polo’ya), türünde bir eserle karşı karşıyayız. 1981’de Sadat tarafından hükümet politikalarına yönelik eleştirilerinin ardından hapsedilen Mısırlı Nawal El Saadawi’nin “Tehlike, elime bir kalem alıp yazdığımdan beri hayatımın bir parçası oldu. Yalan söyleyen bir dünyada hiçbir şey gerçeklerden daha tehlikeli değildir” diyerek eline geçen herhangi bir şeyle yazmaya devam ettiği gibi Zehra da aynı şekilde hapishanede üretmeye devam etti. Her şeyden önce diğerlerini unutmadan yaptı, çünkü Zehra’nın yazdığı gibi “diğerleri olmadan, kaybolursun”. Nawal da dışarı çıkar çıkmaz Arap Kadınları Dayanışma Derneği’ni kurdu.
Büyük Türk hapishanesiyle ilgili anlatılarda genellikle referans olarak Nazım Hikmet ve onun hapishanedeki şiiri vardır. Zehra’nın da hapishane döneminde Fransız vatandaşlığına geçmiş bir Türk aktivist arkadaşından aldığı mektupların arkasında bu çizgi romana zemin hazırlayan zindan edebiyatının kırmızı çizgisinin çapraz referansları ve ince yayılımları var.
Bununla birlikte, bu eserin hemen söylenmesi gereken türünün tek örneği, kendine has bir özelliği var: sanatçının çalışmalarının aktivistler ağı aracılığıyla “kaçırılmak” üzere hapishanede canlı olarak yapılan, dolayısıyla diğer kadınlarla beraber, yakın işbirliği içinde yaratılan ilk çizgi roman olması.
Aslına bakılırsa, buna benzer bir hapishane çizgi roman geleneği de var. Alıntılamam gerekirse Hanawa, “Hapishanede” veya “Tehlikeliler” (Pericolose) eserinde olduğu gibi hikayenin kahramanı Zezè’nin bir çizgi romana dönüştürülmesi için Hermans’tan yardım almıştır, ya da aynı derecede güçlü ama daha edebi bir eser olan ve yazarlarının aynı zamanda anlatılan hapishane deneyiminin doğrudan tanıkları olduğu Mana Neyestanı’nın “Bir İran Başkalaşımı” adlı eseri örnek verilebilir.
Yalnız, burada farklı bir şeyle karşı karşıyayız, çünkü bahsi geçen diğer tüm örneklerde mahkumiyet deneyiminin kişisel olarak yeniden işlenmesi dışarıya çıktıktan sonra yapılmıştır. Burada ise Zehra yazıp çizerken Tarsus’taki 5 No’lu cezaevinin hücrelerine girme “ayrıcalığına” sahibiz. Karşımızda sanatsal bir eserin ötesinde tarihi bir belge bulunmakta.
Bu son kullandığım sıfat üzerinde bir an için duruyorum, çünkü bunda bile bir milat tarihi, eşi benzeri olmayan bir durum var. Aslında, tutuklandığı sırada gazeteci olarak faaliyet göstermesiyle tanınan ve 2015 yılında Ezidi kadınlarıyla ilgili saha çalışmasından dolayı prestijli Metin Göktepe ödülünü almış bir sanatçının çizgi romanı. 26 yaşında aldığı bu ödül, 1995 yılında polis nezaretinde hayatını kaybeden aynı isimdeki gazetecinin anısına verildi ve bir nevi kısmen gerçekleşen bir kehanet oldu. Kendi şehrindeki Güzel Sanatlar Akademisinde aldığı eğitim sonrası yaptığı resim nedeniyle tutuklanıp hüküm giyen Zehra, siyasi tutukluların oluşturduğu formasyon, kolektif çalışma, ve “hapis tembelliği ile mücadele” çabaları sayesinde en derin kaynaklarını harekete geçirerek cezaevinde çağdaş bir sanatçı haline geldi. Tahliye edilir edilmez, cezanın öngördüğü tüm günleri bitirdikten sonra, gönüllü sürgüne gitmek zorunda kaldı ve Londra’ya gittiğinde Tate Galerisi’nde bir enstalasyon onu bekliyordu. Kısa sürede dünyanın en etkili 100 sanatçısından biri olarak kayıtlara geçti.
Çizgi roman ve karikatürist dünyasının her zaman taşıdığı içsel suçluluk duygusunu biliyoruz, bunun için çizgi roman yapmalarına rağmen sanatçı olduklarını veya “çizgi romanın sanat olduğunu hatırlayalım”.
Zehra’nın kitabı bu yüzden hayrete düşürüyor, çünkü daha çok karşılaştığımız çizgi romandan sanata geçiş söz konusu değildir (genellikle geri dönüşü yoktur, örneğin Marjane Satrapi böyledir veya İtalya’dan bir örnek olarak Marcello Jori düşünülebilir) çünkü ardıl sanat bir ceza olarak görülür. Bununla, Metal Hurlant ile başlayan ve Francesca Alinovi’nin yeni İtalyan çizgi romanı olarak adlandırdığı döneme uzanan, içinden çıkılmaz bir enerji ve henüz atomik parçacıklarını tamamıyla dağıtmamış araştırmayı unutmak istemem.
Bu çizgi romanın sayfalarında patlama yaşıyormuş gibi görünen, ve hiç de tesadüf olmayan bir şekilde aynı anda Fransa ve İtalya’da ortaya çıkması sanatsal olayların kombinasyonlarının bu çalışmada bir sentez bulmuş olduğunu gösteriyor.
Zehra tüm bu bahsedilenlerle materyel olarak tanışmamış bile olsa, kendi yolunu izleyen alternatif ve araştırmacı bir popüler çizgi roman geleneğine sahip bir ülkeden geldiği için tüm bunları seziyor. Zehra da önsezilerini derlediği bu eseri, sanki Alinovi’nin 1982’de Flash Art‘ta Jori hakkında yazarken, “kan damarları gibi dallanmış tüneller aracılığıyla doğanın ve ana rahmine penetrasyonunu” anlattığı sayfalarla uyuşurcasına yaratıyor. Bu sayfalar için mükemmel görünen bir tanım.
Son olarak, nihai bir gözlemi de eklemek isterim: Bu kitap, düşünceleri nedeniyle hapishane kapılarından geçenlerin isim ve soyisimleriyle dolu. Çizgi romanlar aracılığıyla hayatlarını hakikat ve adalete adamış olanların ad ve soyadlarına önemli bir yer ayıran ilk yayınevi olarak Becco Giallo tarafından yayınlanması tesadüf değil diye düşünüyorum.
Böylelikle, Kürtlerin Yeni Yılı Newroz’la çakışan Libera ile ilkbaharın ilk gününde yapıldığı üzre, bu isimleri, unutulmuş kadın ve erkek tanıkların taşıdığı anlamı koruyan seküler bir ayın biçiminde kitapla birlikte tekrarlıyoruz.
Zehra’nın sırtı ve diğerleri hepimiz (tüm kadınlar) için bir ok, bir köprü ve bir soru işaretidir.
Çeviri Orkide
Zehra Doğan • La prison N°5, dessins évadés

Courbe-toi, mon amour, le temps que passe la bourrasque.
Je me suis tellement penché que mon dos est devenu un arc. Quand vas-tu tirer ta flèche ?
(Tends la main et trouve une poignée de farine)
Courbe-toi, mon amour, le temps que passe la bourrasque.
Je me suis tellement penché que mon dos est devenu un pont. Quand le traverseras-tu ?
(Tu essaies de bouger ton pied, mais le fer ne bouge pas)
Courbe-toi, mon amour, le temps que passe la bourrasque.
Je me suis tellement penché que mon dos est devenu un point d’interrogation. Quand vas-tu répondre ?
(L’agent qui mène l’entretien fait un record d’applaudissements).
Mahmud Darwish
Journal d’une tristesse ordinaire.
Darwish est, avec Edward Said, la voix qui témoigne de l’existence de la culture palestinienne, le peuple sans patrie par excellence, disent-ils. Ils disent que c’est parce que la terre qu’ils habitaient a été accordée à d’autres, en compensation du grand mal que l’Europe avait commis à leur égard.
Les Kurdes, eux aussi, sont un peuple sans patrie, mais comme cette dépossession n’est pas liée, du moins pas directement, aux mains des puissances occidentales, ils sont souvent oubliés dans la liste des sans-terre. Mais il y a une autre raison : notre oubli errant, se souvenant des Kurdes lorsqu’ils deviennent des alliés utiles sur le terrain pour régler des conflits dans lesquels même les armées les plus fortes de la planète se trouvent en difficulté, est renforcé par l’absence de voix entendues de ce peuple, par notre insipidité envers cette culture spécifique. Zehra Doğan s’est trouvée être la voix la plus autorisée, la synthèse iconique de ces nombreuses voix réduites au silence. Et ce n’est pas un hasard si c’est une femme.
L’affirmation du parcours artistique, politique et intellectuel de Zehra et des autres, repose sur une prémisse idéologique importante, qui est également reprise dans cet important Mémoire graphique, à savoir la ginéologie (en kurde jineolojî) développée par le prisonnier politique zéro du régime turc actuel, Öcalan. Dans le texte Libérer la vie – La révolution des femmes, publié en français en 2013, qui reprend ses textes antérieurs à son enlèvement et à son arrestation en 1999, l’idéologue kurde a analysé le processus anthropologique qui a conduit à la construction du patriarcat, en réfléchissant à l’expérience socialiste et à ses limites par rapport aux processus libératoires, ce qui l’amène à conclure que sans un processus complet de libération du féminin, la liberté ne peut être pleinement atteinte.
Ses théories ont été traduites en pratiques de gouvernement et d’éducation, au Rojava, et aussi dans les villes qui ont été dirigées par des maires et des mairesses kurdes, mais surtout, elles ont été greffées dans une culture, qui, comme toutes, subit des processus de transformation sociale qui partent du récit culturel, et sont devenues l’une des composantes fondamentales de la pensée politique liée au processus d’émancipation du peuple kurde.
La science des femmes, telle que la définit le leader du PKK, est le présupposé qui est à la base de ce livre, de l’expérience de Zehra et de celle des nombreuses autres prisonnierEs politiques et non politiques dans les prisons turques et syriennes. Elle l’est dans le sens où, sans cette forte détermination à prendre la parole, à dire qu’il/elles sont les protagonistes de leur propre vie et du changement, nous ne comprendrions pas d’où émerge cette absence profonde de victimisation, cette inversion des rôles entre victime et auteur. De nombreux commentateurs l’ont défini comme une détermination à espérer, qui est aussi une vertu théologique liée à la foi dans un bonheur éternel, et qui est donc une catégorie utopique qui place l’horizon du bonheur en dehors de la sphère politique. Il ne représente donc pas correctement la vision des militants kurdes, qui sont ouvertement féministes et engagées dans la construction d’une réalité différente dans ce monde.
Depuis que je la connais et que je m’intéresse à son travail d’artiste, j’ai remarqué à quel point ce lien intrinsèque entre identité politique et création artistique pose des difficultés à ses interlocuteurs occidentaux. Joyce Lussu, l’extraordinaire médiatrice entre nous, avec Nazım Hikmet, a écrit à son sujet : “La vie et la poésie, l’action et la parole, étaient liées de manière si organique et solaire qu’il est éclairant de connaître sa poésie, de connaître ses histoires”. On peut cependant dire la même chose de Zehra Doğan, qui paraphrase le mot vicissitudes par “la culture politique du féminisme kurde”.
Et ce livre en témoigne également.
Il s’agit d’un texte d’une valeur historique, anthropologique et artistique, extraordinaire. Évidemment, il s’inscrit dans la mouvance de la littérature carcérale (que l’on connaît de Boèce à Marco Polo), en passant par l’Égyptienne Nawal El Saadawi, qui a été emprisonnée par Sadate en 1981, suite à ses critiques des politiques gouvernementales, et qui, non seulement n’a pas cessé d’écrire – Le danger fait partie de ma vie depuis que j’ai pris un stylo et écrit. Rien n’est plus dangereux que la vérité dans un monde qui ment – mais l’a fait en utilisant tout ce qui lui tombe sous la main, comme Zehra l’a fait en prison. Elle l’a fait surtout sans oublier les autres, car, comme l’écrit Zehra, “sans les autres, on est perdu” et c’est ainsi que Nawal, dès qu’elle est sortie, a fondé l’Association de solidarité des femmes arabes.
Il est clair qu’il y a, dans la narration de l’énorme prison turque, toujours comme une référence à Nazim Hikmet et son Poème de la prison. Il y a donc un monde de références et de subtiles émergences de cette ligne rouge de la littérature humaine carcérale, qui est tout l’humus de cette BD, écrite pendant la période d’emprisonnement au dos de lettres reçues d’une amie turque militante, naturalisée française.
Il y a cependant une particularité qu’il faut immédiatement reconnaître et circonscrire. Il s’agit de la première bande dessinée réalisée en direct d’une prison, “échappée” comme le fait l’artiste à travers un réseau d’activistes, réalisée donc en étroite collaboration avec les autres, et sous forme mixte, dessinée et écrite.
En effet, il existe également une certaine tradition de bandes dessinées de prison, par exemple Dans la prison du japonais Hanawa, ou La ballade des dangereuses dans laquelle la protagoniste de l’histoire, Zezè, a été assistée par Hermans pour en faire un livre graphique, ou encore Une métamorphose iranienne de Mana Neyestani, plus littéraire, mais tout aussi forte et directe, dans laquelle les auteurs sont également des témoins directs de l’expérience carcérale racontée.
Cependant, nous sommes ici face à quelque chose de différent, car dans tous les autres cas mentionnés, il s’agit d’une ré-élaboration personnelle de l’expérience de l’emprisonnement faite après coup, une fois hors des murs. Ici, au contraire, nous avons le “privilège” d’entrer dans les cellules de la Prison N°5, et dans celle de Tarse, au moment où Zehra dessine et écrit. Nous sommes face à un document historique, ainsi qu’à un document artistique.
Je vais m’attarder un instant sur ce dernier adjectif, car il y a là aussi un post quem, une singularité. Il s’agit en fait d’une bande dessinée réalisée par une artiste, qui, au moment de son arrestation, était plutôt connue pour son travail de journaliste, pour lequel elle avait reçu le prestigieux prix Metin Göktepe en 2015 pour son travail de terrain enquêtant sur les femmes yézidies. Ce prix, reçu alors qu’elle n’avait que 26 ans, est décerné à la mémoire du journaliste du même nom, mort en garde à vue en 1988 et, d’une certaine manière, il s’agissait en partie d’une sorte de prophétie auto-réalisatrice. Pourtant, arrêtée et condamnée pour un dessin, formée à l’Académie des Beaux-Arts de sa ville natale, avec quelques expositions organisées dans des lieux militants, Zehra est devenue une artiste contemporaine en prison, activant ses ressources les plus profondes, grâce au gymnase de formation qu’est l’emprisonnement des prisonniers politiques, au travail collectif, à ce qu’elle appelle “la lutte contre la paresse de l’emprisonnement”. Dès qu’elle a été libérée, après avoir purgé tous les jours prévus par la sentence, elle a dû s’exiler volontairement et, à Londres, une installation à la Tate Gallery l’attendait.
En peu de temps, elle a été acclamée comme l’une des 100 artistes les plus influentEs du monde.
Nous connaissons le sentiment intrinsèque de culpabilité que le monde de la bande dessinée et des dessinateurs a toujours porté, pour lequel il est toujours opportun de rappeler que, malgré le fait qu’ils fassent de la bande dessinée, ils sont des artistes, ou le “rappelons-nous que la bande dessinée est un art”, etc.
C’est pourquoi le livre de Zehra est si surprenant, car il ne traite pas, comme cela a souvent été le cas, du passage de la bande dessinée à l’art (souvent sans retour, voir par exemple Marjane Satrapi ou, pour rester dans la sphère italienne, Marcello Jori) car le retour à l’art séquentiel est perçu comme une condamnation. Je ne veux pas avec cela oublier la saison qui va de Métal Hurlant à ce que Francesca Alinovi a défini comme la nouvelle bande dessinée italienne, un moment d’énergie inextricable et de recherche, qui n’a pas encore dissipé ses particules atomiques.
Tous semblent exploser dans les pages de ce livre graphique, qui ne sort pas par hasard en même temps en France et en Italie, créant comme une soudure d’événements artistiques qui semblent trouver une synthèse dans cet ouvrage.
Zehra Doğan, dans son rapport à la BD, en a la perception, même si elle ne le sait pas matériellement, venant d’un pays qui a une très importante tradition de caricature populaire, alternative et de recherche, qui a cependant suivi ses propres chemins. Elle reprend ces intuitions, créant des pages qui semblent correspondre à ce qu’Alinovi écrivait sur Jori dans Flash Art en 1982, quand il parlait de pénétration, à travers des tunnels ramifiés comme des artères de sang, dans le ventre de la terre mère. Une définition qui semble parfaite pour ces pages.
Je voudrais ajouter une dernière observation : ce livre est rempli de noms et de prénoms, de ceux qui, à cause de leurs idées, ont franchi les portes de la prison. Je pense que ce n’est pas un hasard s’il est publié par Becco Giallo, qui a été la première maison d’édition à consacrer une fenêtre importante, par le biais de la bande dessinée, à la vie et donc aux noms et prénoms de ceux qui se sont consacrés à la vérité et à la justice.
Ainsi, comme nous le faisons le premier jour du printemps avec Libera et qui coïncide avec le Newroz, le nouvel an kurde, nous répétons ces noms en même temps que le livre, dans une forme de liturgie séculaire qui préserve le sens de ces témoins oubliés.
Le dos de Zehra et des autres est une flèche, un pont et un point d’interrogation pour nous touTEs.
(Quasi) tutto Max Klinger.

In mostra a Bagnacavallo 11 dei 14 cicli di incisioni di Max Klinger nell'esposizione più ampia dedicatagli in Italia. Stampe amate da Brahms, costituiscono uno degli esempi più importanti della grafica d'arte pre avanguardie. E furono molto amate da De Chirico.
“La memoria è del passato” scriveva Aristotele. E sembra che Klinger, aiutato da Freud e dal clima a cavallo tra XIX e XX secolo, ne abbia fatto una sorta di metodologia poetica. Se la memoria è del passato, quello che noi vediamo e rappresentiamo è su una sottile linea del presente che guarda ad un futuro carico di responsabilità. L'incisore, poeta, pittore e musicista originario di Lipsia affonda la sua inconfondibile arte grafica proprio nella carne inesplorata del processo memoriale, pieno di capitomboli, cadute e sviste.
Per chi ha amato la famosa serie de “Il guanto”, la mostra di Bagnacavallo, forse la più completa mai realizzata in Italia, è sicuramente un'ottima occasione per vedere tutte insieme ben 11 dei 14 cicli di incisioni realizzate in varie tecniche (acquaforte, acquatinta e bulino) dall'artista tedesco. Continua così l'esplorazione che il piccolo museo civico, ricco di un'importante collezione di stampe, dedica al mondo della grafica artistica, dopo la mostra su Goya e Chagall, sempre curate dal direttore Diego Galizzi in coppia con uno storico d'arte.
L'evoluzione del lavoro visivo dell'artista, amatissimo da De Chirico, è sotto la lente di questa importante antologica: diventa quindi chiara l'ambigua identificazione dell'artista tra idealismo e realismo, ben delineata da Patrizia Foglia, cocuratrice di questa esposizione: “Nel dibattito tra realismo e ideale, l'artista di Lipsia propose una mediazione tre le due posizioni, anzi una fusione che ritenne possibile nelle diverse forme di espressione artistica”. Uno stilo perfetto, una rivendicazione dell'arte del disegno come autonoma e non schiava delle arti maggiori, un'attenzione quasi spasmodica alla purezza delle forme, sulla falsa riga della tradizione di Dürer, fanno di Klinger uno snodo fondamentale del moderno.
L'opera d'arte totale si interseca con la ricerca musicale di Brahms, anticipa Freud, ma rimane anche ancorata, come mostra la serie “Un amore” dedicata a Böcklin, a questioni anche sociali, trattate con lo stilo “classico romantico” che lo contraddistinguono. Così ne “I drammi” in cui sono presentati sei tragici eventi di cronaca nera, con una particolare sensibilità narrativa riesce a sintetizzare in una sola tavola il senso della storia, senza però eludere lo sviluppo della storia nel tempo.
Una piccola grande mostra quindi, che vale la pena di una visita nel borgo della campagna ravennate che con la sua piazza Nuova, a forma di ellissi, non potrà che incantarvi, rimemorando le immagini oniriche dell'artista tedesco.
Max Klinger. Inconscio, mito e passioni alle origini del destino dell’uomo.
Dal 15 settembre 2018 al 13 gennaio 2019
A cura di Diego Galizzi e Patrizia Foglia
Museo Civico delle Cappuccine
via Vittorio Veneto 1/a a Bagnacavallo (RA)
Orari: martedì e mercoledì: 15-18; giovedì: 10-12 e 15-18; venerdì, sabato e domenica: 10-12 e 15-19. Chiusa il lunedì e post-festivi.
Aperture serali speciali (fino alle 23.30) dal 27 al 30 settembre.
Ingresso gratuito.
Pubblicato su Artribune con il titolo "Le incisioni di Max Klinger. A Ravenna"
il 29 settembre 2018
La memoria del mondo alla biblioteca Malatestiana di Cesena

Una parte della memoria del mondo è custodita dalla biblioteca Malatestiana di Cesena. L'Unesco l'ha certificato nel 2005, ma gli studiosi, i bibliofili, gli amanti dell'Umanesimo già lo sapevano. Fondata nel 1452 da Domenico Malatesta,detto Novello, ha veramente non solo la consistenza, ma anche la struttura del tempio della cultura. L'allora signore di Cesena, che aveva come simbolo della casata un elefante – che già Plinio il vecchio considerava l'animale più vicino all'uomo, quello che tra le varie qualità ha la memoria – diede l'incarico ad un discepolo di Leon Battista Alberti di realizzare l'edificio che ha avuto la meravigliosa e insperata sorte di attraversare i secoli sostanzialmente inalterato.
La pianta basilicale a tre navate ci porta veramente in un altro tempo: siamo di fronte alla semplicità classica del primo Rinascimento, ma anche al cuore dell'amore filologico degli umanisti. Malatatesta non solo segnò il territorio inserendo il motto Elephas indus culices non timet (lett. "L'elefante indiano non teme le zanzare": parlava forse dei vicini ravennati?) e il simbolo araldico dell'animale che sarà amato anche da Leonardo, ma commissionò anche la copiatura di numerosi testi. Questi manoscritti costituiranno il cuore pulsante del patrimonio che oggi ammonta a 250.000 volumi. Furono 120 i libri copiati nell'arco di un ventennio: non dobbiamo dimenticarci questi numeri. All'epoca era un'operazione mastodontica, ora sono le uscite giornaliere in Italia (in realtà sono di più secondo i dati del 2015, ovvero 178 al giorno!). Ora i manoscritti in greco, latino, ebraico conservati sono 340, a cui si aggiungono i fondi, archivistici, fotografici, i manoscritti moderni... E fu così grande la passione di Novello per questa sua creatura che si fece seppellire nel perimetro del Chiesa di S. Francesco, il convento che era il custode della biblioteca, dopo essere nato 600 anni fa a Brescia.

Ricorre quindi questo importante anniversario, che non ha lasciato indifferente l'amministrazione cesenate. Ad ottobre numerose iniziative, mostre, convegni, conferenze, saranno
l'occasione per riaccendere l'attenzione sulla figura di Malatesta e del suo straordinario periodo. Dalla presenza ebraica a Cesena alla miniatura, dalle architetture segrete della biblioteca
alle ricerche sui resti ipotetici di Novello... Perché sì, c'è un mistero da svelare.
Difatti la Chiesa conventuale dove il signore fu sepolto non esiste più e già nel 1811 quando cercarono i suoi resti per seppellirli dentro la biblioteca in segno di ossequio alla sua memoria, si scoprì che nel luogo deputato non c'era nulla. Partì così la caccia all'uomo, o meglio a ciò che restava dell'uomo. Fu trovata una cassa che sembrava potesse appartenere al fondatore della biblioteca, e si tumulò nella sala Nuti con sopra l'originale lastra. Ma è veramente Malatesta? Oggi la scienza ce lo potrà dire, ed è stato incaricato Francesco Maria Galassi, un giovane medico ricercatore e paleopatologo (cioè studia la storia delle malattie) che a soli 28 anni è stato nominato da Forbes come uno degli studiosi under 30 che cambieranno l'Europa.
Galassi è un santarcangiolese che si è laureato a Bologna, si è perfezionato tra Oxford e l'Imperial College, e ha deciso di coniugare la sua passione per la Medicina con quella per il latino, il greco e la Storia: il suo obiettivo è migliorare le diagnosi attraverso lo studio dell'evoluzione delle malattie. E forse anche lo sfortunato Malatesta, morto dopo una lunga malattia senza eredi, ci potrà dire qualcosa. Se poi è lui... ma questo si scoprirà solo il 27 ottobre quando saranno rivelati i risultati dell'indagine condotta dal team dell'Università di Zurigo guidato appunto dal medico di Santarcangelo. Ma tutti gli appuntamenti sono veramente di altissimo livello.
E la quotidianità fuori dagli anniversari? Quella vede un luogo che si è evoluto nel tempo, cambiando, ampliandosi, evolvendosi, continuando sempre a proteggere come uno scrigno il tesoro dell'unico esempio di biblioteca umanistica “perfettamente conservata” al mondo. Oggi si può visitare ovviamente la parte antica, ma soprattutto si può vivere quella moderna. Che ospita lo spazio ragazzi (erede della storia biblioteca già attiva dal 1982), l'ala Graphic Novel e mediateca, l'emeroteca, la “piazzetta”, uno spazio relax con postazioni, libri sempre a scaffale, e poi un ricco calendario di eventi, incontri attività. Quindi 6.000 metri quadrati polifunzionali che hanno permesso all'istituzione un trend controcorrente, ovvero di mantenere un rapporto prestiti / abitanti di 1,60. Che vuole dire un prestito e mezzo per ogni abitante... una cifra veramente molto alta. L'indice di prestito, come viene chiamato, valuta l'efficacia della biblioteca e la sua capacità di promuovere le proprie raccolte. Ma valuta anche, come ci insegnano gli osservatori inglesi, indirettamente e direttamente (cioè c'è un rapporto non di causa effetto, ma proprio di dipendenza vicendevole) la ricchezza di un territorio. Non a caso, l'indice di prestito ci racconta anche il reddito medio pro capite di un territorio. E Cesena con i suoi 21.711 euro medi nel 2015 guida la Romagna (subito dopo c'è Ravenna con 17.527 euro... un certo distacco). Nei fatti, dove si legge c'è più ricchezza, in particolare dove circolano i libri delle biblioteche. Certo, gli imprenditori italiani non se ne sono ancora accorti, ma i numeri non mentono. Dove si legge, si cresce. Non solo in ricchezza spirituale, ma anche materiale.
Quel lascito davvero nobile da cui nacque la biblioteca Gambalunga

Non avere figli può essere un bene per la comunità: questo può essere l’epilogo ricavabile dal testamento di Alessandro Gambalunga, il quasi nobile che donò la propria dimora e il proprio materiale librario alla città di Rimini nel 1617, permettendo così l’apertura di una delle prime biblioteche pubbliche e laiche dell’Europa controriformistica. Fu quindi in una delle città della periferia, che tale era Rimini all’inizio del XVII secolo, parte da poco della periferica Legazione pontificia di Ravenna. Qui nacque questa biblioteca civica che, dopo 400 anni, vede ogni giorno circa 500 persone al giorno entrare ed uscire dalle sue porte per leggere, vedere, ascoltare. Gambalunga era un arrivé, il figlio di un commerciante di ferro che si era arricchito grazie alle doti delle quattro mogli e che grazie a questo patrimonio aveva comprato il titolo nobiliare: non gli era bastato per essere ammesso nel cerchio dorato del Consiglio dei Cento, anche se aveva sposato una Diotallevi, ovvero una erede di casata pluristemmata. Ma si sa, non basta la fede per rifarsi il pedigree, in particolare nella piccola provincia che tutto ricorda.

Ma Gambalunga si è fatto ricordare molto più a lungo dei suoi concittadini sprezzanti. Amava le lettere e si faceva mandare dalla bisbetica Venezia, che aveva ignorato il dispotico Papa Paolo V, libri a stampa pregiati che costituiranno il nucleo della sua donazione. Non aveva avuto figli. E i suoi amati libri, e anche i manoscritti dei quali rimane il codice con le Metamorfosi di Ovidio, sono lasciati insieme all’edificio alla città che non l’aveva voluto nel consesso dei consiglieri. “È sotto la protezione del cielo chi costruisce la casa”, dice la scritta in latino all’ingresso: potremmo parafrasare che è sotto la protezione del cielo chi costruisce la casa con i libri e la dona. Che oggi nessuno si ricorda degli altri nobilotti dell’epoca, ma il cuore della città pulsa nel cantiere della Biblioteca Gambalunga, che sicuramente fu anche un prerequisito della stagione visiva del Seicento riminese. Un altro esempio di fulgente energia della periferia del potere.

E oggi? L’anatema del donatore verso coloro che sottraggono libri non sembra turbare i 148.324 adulti e 32.400 ragazzi che l’hanno frequentata nel 2017. Il pubblico è nettamente giovane, anche nelle indagini degli anni precedenti: il 53% è tra i 16 e 25 anni e, come succede in moltissimi casi, il 60% è donna. Nel corso di questi quattro secoli lo spazio si è modificato, lasciando però intatte le sale del Seicento, allestite subito dopo la morte del proprietario, in cui si possono ammirare gli originali scaffali: fate attenzione a quelli chiusi da una grata metallica. Erano quelli per i libri “proibiti”, non pochi durante gli anni dell’Indice. Nel testamento era stato espressamente chiesto di: “far fare un armario appartato... et ivi rinchiuderli sotto chiave”. Nelle tre sale di questo periodo c’è anche una porticina segreta, proprio come si vede in tanti film d’ambientazione storica. La sala del Settecento, in elegante abete e decorata in colori chiari, custodiva un’altra opera proibitissima, l'Encyclopédie, che poteva essere consultata da chi avesse il permesso di lettura, ma doveva essere comunque preservata da mani e sguardi indiscreti… Diciamo che l’accesso al proibito aveva coloriture diverse in questi secoli.
Infine, nella Sala del Vergers, siamo catapultati nel mondo e immaginario librario di un ricercatore dell’Ottocento, un eclettico studioso e viaggiatore affascinato dalla enigmatica etruscologia. Il nobile parigino aveva acquisito la villa dei Diotallevi a San Lorenzo a Correggiano sulle colline riminesi, che ancor oggi porta però il suo nome. La villa, una piccola Versailles, oggi è sostanzialmente un luogo per cerimonie nuziali, ma se si vuole odorare per un momento l’humus intellettuale che alimentò il grande etruscologo (contribuì agli scavi di Populonia e Vulci) e arabista, è in questa sala che dovete cercare la sua anima.
Certo, oggi la biblioteca ha un respiro molto più vasto: è anche il luogo in cui si fa formazione per gli adulti, presentazione di libri e ricerche di alto profilo, ma anche workshop di filosofia per ragazzini … “Qui le persone cambiano” scrivono provocatoriamente nella nota stampa i curatori delle rassegne della più antica biblioteca pubblica italiana. È un rischio che si deve correre, quello del cambiamento. Un luogo aperto al pubblico è un luogo di incrocio e contatto. E come i fondi hanno alimentato e ancora alimentano il cambiamento è sostanzialmente la traccia degli incontri che cominciano in aprile, con Piero Meldini, lo scrittore e saggista che è stato direttore della biblioteca dal 1972 al 1998. Esisteva un tempo in cui si poteva diventare direttore di un’istituzione culturale e avere trent’anni… ma non è questo il nostro tema, piuttosto si può scoprire guidati dallo storico direttore come nei cataloghi, nelle memorie, nei trattati ci siano i semi con cui preparare il romanzo.
La rassegna, “Voci dai fondi”, proseguirà fino a giugno e fa parte delle numerose azioni che per questo compleanno, che in realtà dura tre anni, ha programmato la biblioteca Gambalunga, un luogo che se si vuole scoprire Rimini e la storia della conoscenza nel nostro paese non si può tralasciare.
Petite Jérusalem | Editions Rackham

par Elettra Stamboulis & Angelo Mennillo
Quelques jours après la chute du Mur de Berlin, un homme revient dans la ville qui l’a vu naître… et que peut-être il n’a jamais quitté. Il en arpente les rues dans un périple sans fin et ne s’arrête que pour écrire des courtes lettres à sa grand-mère, sans pourtant en attendre une réponse. Le passé refait lentement surface et ses souvenirs se fondent aux récits entendus de la bouche de ses proches… Il est entouré par des ombres qui se dessinent sur les murs ; les façades fatiguées des immeubles lui renvoient l’écho de langues désormais oubliées. Les fantômes des anciens habitants, que le XXe siècle finissant a emporté avec lui, l’entourent mêlant leurs voix avec celles des hommes et des femmes, ceux-ci bien réels, qui les ont remplacés.
En redonnant vie et forme à ses souvenirs familiaux, Elettra Stamboulis brosse par petites touches un portrait intime de Salonique, trait d’union entre l’Orient et l’Occident, ville à l’histoire millénaire et aux multiples facettes séfarades, valaques, arméniennes, pontiques, albanaises ; ville emblématique d’un pays à l’identité hybride, la Grèce. Le récit d’Elettra Stamboulis en parcourt l’histoire récente : l’Occupation allemande, l’extermination presque totale de sa communauté juive, la Guerre civile qui l’a divisée et ensanglantée, comme le pays tout entier. La plume d’Angelo Mennillo redouble la dimension poétique du texte de Stamboulis et forge une clé de lecture puissante et originale de l’histoire en noir et blanc qui a été, et continue d’être, celle de la République hellénique.
Editions Rackham,
http://www.editions-rackham.com
ISBN 9782878272192
COLLECTION LE SIGNE NOIR
FORMAT 20 X 28 CM.
88 PAGES EN NOIR ET BLANC
BROCHÉ
PARUTION FÉVRIER 2018
16,00€
Archeologia del contemporaneo. La fotografia di Georgios Katsagelos a Salonicco

Pubblicato in Artribune
il 27 agosto 2017
Georgios Katsagelos è un fotografo navigato e molto noto nel panorama non solo ellenico. Artista “sociale”, come ama definirsi, ha seguito con il suo obiettivo ‒ per tutti i mesi in cui è stato in attività il campo improvvisato a Idomeni, ai confini con la Repubblica macedone che aveva sigillato le frontiere ‒ i volti degli ospiti, il lavoro dei volontari, gli incontri e scontri con le autorità. Dopo un anno, quando ormai il luogo sembrava tornato a una apparente normalità, ha deciso di tornare e vedere cosa restava di quei giorni, nel ricordo di chi si è trovato ostaggio del passaporto. Come un vero archeologo del contemporaneo, ha scavato, cercato e raccolto oggetti di vita quotidiana, giochi, scarpe e indumenti di chi, in fretta e furia, è dovuto salire titubante sui pullman scortati dalle forze dell’ordine greche a metà del 2016. Continua
Scrivere con la vita - quando le parole diventano #libertà

La biblioteca comunale "Luigi Varoli" propone il laboratorio di scrittura "Madame Bovary sono io: tra biografismo e presenza - come raccontare storie a partire da sé", tenuto
dalla docente Elettra Stamboulis, che si terrà in biblioteca nelle giornate di sabato 6, 20 e 27 maggio dalle 10.00 alle 12.00.
6 maggio: In prima o terza persona. Chi è il narratore delle vite non tue?
20 maggio: Giocare con le voci: dialoghi.
27 maggio: La mappa della vita: iniziare e finire.
Il laboratorio si propone come seguito del percorso "Scrivere per imparare a nominare e a condividere le emozioni", iniziato lo scorso novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e coadiuvato dallo scrittore Antonio Ferrara.
In esso verranno esplorati i possibili approcci alla propria autobiografia come miniera di storie nascoste, decentrandosi, raccontando sotto falso nome ed esponendosi per arrivare, attraverso molteplici strade, ad una storia credibile.
È possibile partecipare anche ad un solo incontro.
Per informazioni ed iscrizioni: 0545 908874 / varoli@sbn.provincia.ra.it
Il laboratorio è gratuito ed aperto a tutti.
Promosso dall'Assessorato alle Pari opportunità di Cotignola.
Itinerari di guerra alla ricerca della pace - Officina del macello

Itinerari di guerra alla ricerca della pace
Associazione per la Pace, ANPI, SPI-CGIL, Unione degli Universitari,
Rete degli Studenti Medi, ACS, Centro Studi Ettore Luccini, Donne in Nero
vi invitano alla presentazione del libro a fumetti:
“Officina del macello”
1917 la decimazione della Brigata Catanzaro
un libro di Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini
edito da Eris Edizioni
al Sala "Peppino Impastato" della Banca Etica
venerdì 17 marzo, ore 17.30
1917 – L'anno di Caporetto
Continuiamo le nostre riflessioni per ricordare il centenario della prima guerra mondiale.
Il nostro obiettivo è quello di far uscire questo anniversario dalla retorica sul completamento del Risorgimento e sulla conclusione del processo unitario del nostro paese per affrontarlo, invece, dal punto di vista dell’immane macello che ha sconvolto l’Europa in quegli anni, mettendo anche in risalto le forme di opposizione alla guerra che ci sono state su tutti i fronti e cercando di capire e comprendere il punto di vista dei cosiddetti "nemici".
Altro obiettivo che abbiamo è quello di attualizzare le problematiche che quella tragedia non ha risolto ma ha lasciato insolute, tanto è vero che, vent'anni dopo, è scoppiato un nuovo conflitto mondiale ed ora la guerra sembra sempre più estendersi a livello globale.
La presentazione di questo libro vuole anche appoggiare la richiesta di un intervento legislativo che riabiliti e restituisca dignità e memoria ai soldati italiani uccisi per fucilazione e decimazione durante il primo conflitto mondiale.
Museo interreligioso di Bertinoro

Siamo tutti pronipoti di Mosè. E forse più che delle differenze, sarebbe il caso di tornare a parlare di analogie, luoghi e valori comuni, percorsi fatti insieme.
Il Museo interreligioso di Bertinoro ci invita nel suo nuovo allestimento, rivisitato nel 2015 al cui centro c'è l'esperienza del monoteismo, a riflettere su ciò che ci unisce, piuttosto che su quello che divide. Il monoteismo inteso nelle sue tre espressioni: l'ebraismo, il capostipite, il cristianesimo,ovvero il figlio che vuole essere padre e che si emancipa, ma senza un interesse alle sue numerose accezioni, l'islam, come nipote tardivo, ma non per questo meno vicino. Il termine interreligioso è proprio la chiave di volta di questo particolare luogo, ospitato nella cisterna del '500 e nelle segrete medioevali della Rocca non lontana da Cesena. Un luogo inusuale: non è un museo di Storia delle religioni, non è neanche un museo che nasce da una collezione di oggetti sacri, da una esperienza in qualche modo della tradizione. È invece una scommessa innanzitutto del mondo accademico. L'idea nacque nel 1995 da un accordo tra atenei: Bologna, Thessaloniki, Tunisi, Ankara, Heidelberg, Gerusalemme, la Pontificia Università Gregoriana e l’Università Pontificia Antonianum. Era l'epoca, che sembra ormai lontana, in cui uno dei leit motiv era ricreare un asse del Mediterraneo, favorire il dialogo e la collaborazione sul bacino del Mar Bianco, come viene chiamato dagli arabi e dai turchi. Ovviamente ci fu anche un sostegno politico importante, in particolare del senatore dell DC Leonardo Melandri, a cui ora il Museo dedica un premio. Poi ci furono i tempi per fare maturare idea, luogo, progetto, e nel 2004 aprì i battenti. Ora, in tempi sicuramente cambiati per la percezione della questione della fede, tempi in cui convivono due Papi, per dire, questo luogo è sicuramente cruciale come contesto di riflessione, come accesso alle questioni nodali. Quesiti e risposte che si incrociano e che allo stesso tempo dividono, ahimè, gli uomini e le donne di fedi diverse.

Serigne Mbacké, un cosiddetto marabutto, della confraternita sufi senegalese dei Murid, ha vinto il premio nel 2012 e dell'esperienza del museo ha detto: “Durante i miei numerosi viaggi in tutto il mondo, come musulmano ho camminato sulle orme dell’ebreo e del cristiano, alzando la bandiera della condivisione, ma in nessun altro luogo ho trovato tante testimonianze artistiche che ripercorrono, nei tempi e in un piccolo spazio, l’incrollabile volontà degli uomini di vivere un destino comune.”
E destino comune è sicuramente la traccia che ha seguito chi ha pensato questo originale percorso espositivo, che si apre sulla ricostruzione del Sancta Sanctorum, in cui si può vedere una copia dell'arca dell'allenza e sentire l'odore dell'incenso, in un'esperienza multisensoriale che permette, attraverso gli approfondimenti multimediali, di chiarire dubbi e fugare paure e pregiudizi. Oltre alle ricostruzioni della sezione Radici storiche, c'è la parte Monographica, in cui dalle origini comuni si passa agli elementi che costituiscono l'ideantità di ciascuna comunità. È sicuramente la parte più interessante dal punto di vista artistico, con l'acquaforte di Rembrandt e il Sarcofago dogmatico, un interessante sepolcro dell'epoca costantiniana, che mette su pietra i dettami del dogma di Nicea. Questa cassa in pietra calcarea, divoratrice di cadaveri (è il significato etimologico della parola sarcofago...) ci racconta dell'inizio del cristianesim, di come nasca la Chiesa con una guida non più fatta di elementi singoli, comunità a volte poco accettate o addirittura perseguitate, ma come una religione che si struttura su regole gerarchiche, su interpretazioni non più discutibili. E infine la sezione Monoteismo in cui, attraverso la ricostruzione delle figure di Mosè, Gesù e Maometto gli allestitori si pongono l'obiettivo di “affrontare la questione della presenza di Dio nella storia”. Un quesito hegeliano direi...

Certo, per noi agnostici, atei e miscredenti, lo spazio sembra limitato: la parola Verità coniugata a quella di esperienza siedono vicine in questo luogo. E certo per chi non ha mai trovato risposte in un percorso di tipo religioso l'eco di questo museo può apparire flebile. Forse che non credere al politeismo egizio rende meno coinvolgente una visita al Museo di Torino? È proprio nella conoscenza e nell'incontro che si fonda il principio del relativismo, che non significa rinuncia alla conoscenza dell'altro. Paul Veyne sosteneva “che il mestiere dello storico consiste nel dare alla società in cui vive il senso della relatività dei suoi valori”. Per un occhio non legato a nessuna della fedi monoteistiche di cui si sperimentano visioni, testi, simboli, questo è il risultato primario. Ma ancor più interessante è forse l'esito per chi pensa di conoscere la propria fede, dimenticando le altre. In tempi di oscurantismo e propaganda violenta, in cui il massimo che si può auspicare è il buon senso, bisogna ritornare alla profonda conoscenza che può essere uno schermo protettivo verso le derive fondamentalistiche di ogni genere. Far conoscere le storie, le esperienze, i contesti religiosi che hanno determinato la storia di questa Europa zoppa e di questo Mediterraneo al cui centro oggi c'è un muro, potrebbe senz'altro contribuire a togliere qualche muro dentro di noi.
Il cambio della pittura - Intervista ad Andrea Chiesi

Forse non molti sanno che dall'anno scorso la cattedra di Pittura all'Accademia di Belle Arti di Ravenna è stata affidata ad Andrea Chiesi, un pittore e un intellettuale che attraversa la fine del novecento e le sue inquietudini, arrivando all'oggi con una spirituralità zen che si vede nei tempi lunghi delle sue creazioni. Proviene dall'esperienza emiliana di confine, dove l'ossessione di assoluto per dirla con Tondelli, porta al post punk dei CCCP, con cui Andrea ha collaborato anche poi nel passaggio a CSI. Ha esposto a New York, a Berlino, e recentemente in Cina, eppure rimane sostanzialmente radicato profondamente nel modenese.
Si tratta di piccoli miracoli dello sguardo pedagogico: in così poco tempo gli studenti sono cresciuti di numero e molti hanno deciso di biennalizzare la materia, come ci ha raccontato lui stesso.
E: Che cosa ti ha spinto a insegnare? Non l'avevi mai fatto prima credo...
A: Esatto. Un po' come la pittura, ci sono arrivato tardi. In fondo è una continuazione nella pratica di un metodo che applico da tempo, quello maieutico intedo. Far nascere da dentro, farti scoprire quello che già c'è. È in un certo senso il mio modo di guardare al mondo che credo si veda anche dalla mia pittura.

E: E quindi il tuo metodo didattico immagino non consista nel far ricopiare il tuo stile...
A: (Ride) Scherzerai... Certo, esiste la tecnica e va appresa. C'è chi ce l'ha già tra le mani, c'è chi la deve mettere a punto. Ma quello che conta è il pensiero... Se c'è una cosa su cui insisto è sul fatto che il pittore è un intellettuale. Non può essere altro, non è una mano che disegna, ma è uno che mette sulla tela un pensiero. Quindi è nel dialogo che il pensiero si crea, è quello il luogo vero del mio metodo.
E: La trovi un'attività noiosa o faticosa?
A: A dire il vero sono talmente preso da questa esperienza che mi dimentico di fare la pausa pranzo. Non ce la faccio. Quando siamo lì e lavoriamo tutti insieme mi sembra che qualcosa accada e come fai ad interromperlo? È sicuramente un'esperienza affascinante, perlomeno per me.
E: La tua esperienza di pittore comincia anche essa piuttosto tardi direi...
A: Anche in questo caso è il frutto di un percorso di sedimentazione: ho cominciato disegnando, facendo fumetti e illustrazioni. Avrei voluto essere un rocker (sorride), ma riuscivo meglio in altro... Forse è stata anche l'eredità del lavoro di mio padre, scomparso da poco, che faceva il restauratore.
E: In effetti credo anche io che il rapporto di trasmissione generazionale, soprattutto familiare, sia uno strumento necessario di sintesi e trapasso del fare artistico.
A: Allo stesso tempo fu necessaria anche una cesura, quando lui lasciò l'attività io non la continuai. Feci un salto nel buio con la pittura, che nel frattempo si era fatta più materica. Avevo scoperto la necessità del colore e non più solo della grafite. Non ho però mai abbandonato il disegno.
Non è stato facile e i risultati sono venuti anch'essi con il tempo. Con l'ascolto nel tempo di ciò che mi sembrava necessario. Sicuramente sono stati importanti il Premio Cairo e il Premio Terna. Ma per me dipingere è una forma di meditazione...è una questione di tempo appunto. Anche nella realizzazione sono lento d'altro canto … Il mio tempo è la pittura.

E: Quando ti ascolto mi sembra di attraversare un po' la strada della ricerca anche dei CCCP con i quali tu hai intessuto importanti collaborazioni...
A: Ho conosciuto Ferretti negli anni '80 al tempo del Tuwat di Carpi, un centro sociale in cui di fatto si formarono i CCCP. Feci lì la mia prima mostra di disegni, da giovanissimo. La collaborazione vera e propria invece nasce nel passaggio con i CSI, quando ho fatto sempre con lui il progetto Apocalisse di Giovanni. Con Giovanni Lindo Ferretti c'è ormai una relazione di amicizia, ma ho lavorato anche con Emidio Clementi e molti altri. Fare le copertine dei dischi è stata per me un'esperienza importante, un'esperienza di progetto. Che è sostanziale nel mio percorso pittorico, che peraltro è quello di un autodidatta.
E: Un percorso sicuramente che attraversa molti spazi e luoghi. Ho visto che hai fatto anche molte residenze all'estero...
A: Devo dire che quelle sono capitate. Non è che non ami viaggiare, ma dipingere è il centro. Per esempio in Cina, visto che dovevo fare la mostra, ho chiesto anche di rimanere un po' di più per capire dove ero. È veramente un mondo altro: sai, per me che studio le religioni orientali la Cina rappresenta un po' un territorio di ricerca. Sta sicuramente andando ad una velocità diversa dalla nostra...
Lascio Chiesi all'ingresso dell'Accademia e sono un po' invidiosa dei suoi studenti, che sono accolti da questa apertura, dalla disponibilità all'ascolto. Mi chiedo se forse avrei trovato anche io il modo di aprirmi al disegno con un maestro così, così diverso da giudici con la pistola del voto che invece hanno caratterizzato il mio percorso di formazione. Ma poi mi dico che ognuno ha il tempo che gli è dato e, per dirla con Emidio Clementi, “Noi facciamo ciò che siamo”.
Sabir significa cittadino del Mediterraneo

Di Vagghelis Karagheorghou – Traduzione di Elettra Stamboulis
(Pubblicato sul quotidiano EfSyn del 5-6 novembre 2016)
La Sicilia è bellissima ed è l'isola più grande del Mediterraneo. Al nominarla, però, subito compare nella mente della maggioranza il termine Mafia. Cosa Nostra si è ingigantita dopo il 1860, quando Garibaldi occupò l'isola e impose l'Unità d'Italia. I siciliani non videro di buon occhio l'annessione. Così dal 1861 fino al 1870 ci fu una guerra di resistenza. La sottomissione violenta non cambiò l'immagine che i locali avevano dell'Italia. Continuarono ad affrontarla con diffidenza e non accettavano che le istituzioni romane regolassero la loro quotidianità. Si fidavano molto di più di “istituzioni” locali, anche se invisibili e illegali – affidavano le “loro questioni” a Cosa Nostra.
Ma non tutti i siciliani sono chiusi e localisti. Ce ne sono molti che si autodefiniscono siciliani, ma che, pur non dichiarandosi cittadini del mondo, sicuramente rivendicano un'identità fortemente mediterranea. Sono di questa opinione gli organizzatori del Festival Sabir, alla sua terza edizione, supportato dagli enti locali e dall'università a Messina e successivamente a Catania.
Sabir si chiamava la lingua comune parlata nei porti del mediterraneo dall'XI al XIX secolo. Si intuisce che il termine è particolarmente azzeccato per un festival politico e culturale, che indaga l'esistenza di un'identità condivisa nel bacino del Mediterraneo tra i popoli che lo abitano.
Nei quattro giorni di durata del festival ci sono state rappresentazioni teatrali e musicali, nonché proiezioni che si sono concentrate sulle singole culture del Mediterraneo e allo stesso tempo hanno promosso gli elementi di comunanza che vi sono tra queste, derivanti dagli scambi culturali e dalle influenze reciproche.

Oltre agli eventi culturali, vi sono molti laboratori, discussioni e forum in cui gli oltre 90 ospiti hanno cercato di concentrarsi sia sui problemi che sulle pratiche comuni mediante le quali i cittadini li affrontano o potrebbero affrontarli in futuro, imparando dalle esperienze degli altri. Così nell'edizione di quest'anno le luci hanno illuminato il tema dei rifugiati, dei diritti umani, la radicalizzazione islamica, e ovviamente la crisi economica. Parallelamente c'è stata anche una ampia discussione sulle reazioni della società dei cittadini ai problemi, con particolare attenzione al movimento di solidarietà creatosi per l'arrivo dei richiedenti asilo, alle primavere arabe e ai movimenti di cittadini nel mondo islamico, agli indignados spagnoli e quelli di piazza Syntagma, ma anche agli sviluppi politici del sud dell'Europa, come l'emergere di nuovi soggetti come i Podemos in Spagna e i M5S in Italia, senza dimenticare il governo di Syriza in Grecia.
Nella grande discussione del pomeriggio della prima giornata di Sabir il tema era la crisi economica e le alternative possibili. Il panel era coordinato da una turca, mentre il relatore spagnolo, parlamentare di Podemos Pedro Arrojo e il docente universitario Tonino Perna hanno analizzato sia a livello generale che nel concreto il modello di quotidiano cooperativo che avete tra le mani, che è stato descritto dallo scrivente. Efymerida ton Syntakton mostra quali prospettive possano avere le cooperative, ma anche l'economia sociale in senso più ampio, e ha acceso un dibattito molto stimolante. L'importanza di un dibattito siffatto in un contesto multiculturale si è resa evidente quando un canale turco ha richiesto un'intervista, riflettendo sul fatto che oggi che centinaia di giornalisti a causa di Erdogan sono rimasti disoccupati, diviene forse importante l'esempio di “EfSyn” come possibile soluzione.
L'altro dibattito interessante dal punto di vista ellenico è stato quello relativo al rapporto tra politica e movimenti, ove malgrado la presenza di un parlamentare spagnolo e di uno italiano dei M5S, parte della discussione si è concentrata sull'esperienza di Syriza e in particolare su come è stata realizzata l'alleanza sociale che l'ha portata al potere, ma anche come si è sviluppata la cocente sconfitta della scorsa estate. In questo dibattito c'è stata anche la comunicazione di una “notizia”. Il rappresentante del M5S, malgrado abbia occupato parte del suo intervento per mostrare come il suo movimento a differenza di Syriza e Podemos non abbia una connotazione di sinistra, ha poi concluso dichiarando che il suo partito farà una proposta di alleanza su alcuni punti precisi ai due partiti a livello europeo.
Ma visto che se fossimo rimasti ancorati sempre ai temi greci avremmo sacrificato la ricchezza di Sabir, vorremmo menzionare almeno altri due interventi per farvi sentire l'ampiezza del Festival. Uno riguarda lo sviluppo dei fumetti in ambito mediterraneo e l'ha organizzato Elettra Stamboulis, di origine greca – che ringraziamo per il suo aiuto nella traduzione – e l'altro riguardava il turismo alternativo nell'area. La presentazione è stata fatta da un giornalista italiano che in sei mesi ha percorso in bicicletta 10.000 km intorno al bacino, trovando anche la donna della sua vita, uno scrittore e skipper che da un decennio naviga questo mare e da un gruppo di tre studenti universitari che nell'ambito di una ricerca hanno avviato un percorso a piedi, in particolare in Grecia, lungo la vecchia via Egnatia, facendo oggi partecipare a questa impresa più di 1.000 persone da diversi paesi.
È difficile descrivere l'importanza e la ricchezza di Sabir, per questo visitate il sito www.sabirfest.it oppure informatevi contattando la commissione organizzativa, così magari l'anno prossimo saremo più greci a partecipare e, perché no, a coorganizzare.
Faenza val bene la Scienza

"Mi posi all’opera più fiducioso che mai, convinto che questo terrificante fenomeno doveva pur avere la sua legge...”, così scriveva il faentino Raffaele Bendandi (1893-1979) ), che non credeva nel caso, in particolare quando si trattava di terremoti. Nato in una famiglia umile, studiò per poco, dovendo per forza andare a lavorare. Ma non abbandonò mai la curiosità e fu sicuramente uno dei più misteriosi scienziati autodidatti della nostra terra.
Il lavoro di orologiaio e poi intagliatore, i suoi studi forsennati, lo portarono a costruire un sismografo e altri strumenti. Come molti, fu particolarmente colpito dal terremoto di Messina e divenne un suo cruccio trovare il modo di prevedere i sismi. Dal punto di vista scientifico le sue teorie non sono state comprovate e accolte dalla comunità scientifica, tuttavia il suo lavoro ha sempre una forte aura di fascino. La sua idea era che i sismi fossero provocati dalle influenze degli altri pianet, tuttavia questo approccio, anche se ancora discusso e ogni tanto riproposto, non è al momento tra quelli considerabili scientificamente provati.
Nel 1968, nel pieno delle rivolte studentesche, anche lui fa una piccola rivoluzione: scopre un nuovo pianeta e lo chiama “Faenza”. Anche in questo caso la sua teoria non viene accettata, ma va ricordato che la presenza di un pianeta in quella zona del nostro universo non è nuova ed è tornata in auge a seguito delle dichiarazioni sulla presunta esistenza del nono pianeta da parte di due ricercatori californiani recentemente. La damnatio memoriae, dopo un'iniziale innamoramento, da parte di Mussolini lo rendono ancor più avvolto di mistero, visto che il suo sistema di previsione e i suoi studi non sono completamente documentati.
La visita alla casa memoria comprende non solo l'approfondimento degli elementi scientifici legati alla sua opera (il planetario permanente e il sismografo), ma è anche l'occasione di visitare una tipica casa a schiera faentina di fine ottocento. Si tratta di uno spazio gestito e curato da ricercatori e appassionati locali, che quindi è animato da vero amore per la scienza, un bell'esempio di cultura partecipata insomma, che tutte le scuole possono fruire su appuntamento, i visitatori invece tutti i primi mercoledì del mese.

Ma la città famosa per le sue ceramiche ha un cuore scientifico che non si ferma alla discussa figura di Bendandi: il Museo civico di Scienze naturali Malmerendi è sicuramente un'altra sosta importante. Composto di una collezione “morta” (ovvero una copiosa collezione di animali tassidermici, un importante insettario e un ancora più emozionante collezione aracnologica...ovvero fenomenali ragni, rigorosamente deceduti) e una collezione “viva” ovvero il giardino botanico, è sicuramente il museo scientifico più vasto del nostro territorio. Anche qui è stato il lavoro comunitario degli appassionati a ridonarlo al pubblico: chiuso fino al 2011, è stato riaperto grazie all'intervento di un comitato formato dal gruppo speleologico locale che con il proprio lavoro volontario l'ha reso nuovamente fruibile e arricchito di un interessante programma di visite didattiche. Anche qui il nucleo originario nasce, come nel caso del museo Brandolini, da una donazione privata, quella del geometra Malmerendi, fratello del pittore Giannetto, noto cacciatore e osservatore oculato della natura.
La vocazione scienfica di Faenza ha origini però antiche e non solo novecentesche: ce lo testimonia la figura di Evangelista Torricelli, il fisico, matematico e studioso di geometria allievo di Galileo Galilei e inventore del barometro a mercurio: ecco quindi il museo torricelliano, che custodisce 2000 pubblicazioni scientifiche in due sale di Palazzo Laderchi. Questa collezione conserva anche alcuni oggetti particolarmente affascinanti come un globo di Coronelli. Quest'ultimo rappresenta un relitto prezioso della rappresentazione lussuosa della terra nel Seicento. Lo xilografo francescano che si formò a Ravenna diventerà poi il cosmografo della Serenissima e sarà ingaggiato anche dal Re Sole per realizzare questi meravigliosi romanzi geografici, che più che rappresentare raccontano infatti il pianeta terra.
Dalla geografia seicentesca alla fisica, dalla botanica alla zoologia, passando per la biologia e la sismografia, la piccola grande Faenza si conferma come la capitale delle Scienze sul territorio ravennate.

Museo Civico di Scienze Malmerendi, via Medaglie d'Oro 51,
Orari: Lunedì: 9:30 – 12/ 15 -18
Giovedì: 9:30 – 12 / 15 -18
www.museoscienzefaenza.it
Museo Torricelliano, Corso Garibaldi, 2, Tel 0546.25499 – 0546.691667 Aperto Sabato dalle 10 alle 12 o su prenotazione
Casa Museo Raffaele Bendandi Via Manara 17 - 48018 Faenza (Ra) Tel 338-8188688 (Paola Pescerelli Lagorio) Aperto il primo mercoledì di ogni mese. http://www.osservatoriobendandi.it
Di-segni Divergenti, Parole e immagini del fumetto sociale

Giornata di inaugurazioni 19 novembre 2016
Mediateca Montanari - Memo, Fano (PU)
Ore 10.00-12.00
"Mi piace Spiderman...e allora? Di-segni senza stereotipi"
Laboratorio con Massimiliano di Lauro
Ore 16.00
Inaugurazione della mostra con le tavole originali del libro
"Lea Garofalo, una madre contro la 'ndrangheta"
dI Ilaria Ferramosca e Chiara Abastanotti
Ore 17.00
Incontro con l'autrice Chiara Abastanotti
Ore 18.00
Le tematiche di impegno civile attraverso la grafica e il fumetto d'autore.
Incontro con Elettra Stramboulis
(sceneggiatrice - ideatrice del Komikazen Fesitval
Festival Internazionale del Fumetto di Realtà)
Rocca Malatestiana di Cesena

Cosa succede se una pedagogista – paesaggista, Roberta Magnani, e un musicista compositore polistrumentista, Dario Giovannini, si mettono in testa di ridare vita ad una Rocca storica? Accade a Cesena, dove dal 2012 l'associazione Aidoru gestisce questo spazio: il risultato è che dalle 22.000 presenza annue sono passati a 90.000. Come sia successo l'abbiamo chiesto proprio a Roberta.
- Come siete arrivati in tre anni di gestione a moltiplicare le presenze come i pani e i pesci?
- Diciamo che è stato un po' il cuore del nostro progetto. Volevamo utilizzare il luogo per moltiplicare l'offerta. Prima c'era un'associazione che sostanzialmente gestiva le visite guidate. Che c'erano, ma ovviamente erano indirizzate a chi già era interessato all'aspetto storico artistico della Rocca. Noi abbiamo ampliato lo spettro, presentando un progetto al Comune indirizzato ai turisti, ai giovani, alle famiglie, alle scuole. Questo spazio, che è composto da un parco di quattro ettari e dalla storica Rocca, è diventato così uno spazio in cui si può ancora fare la visita diciamo ordinaria, ma a questa si aggiunge la visita Lumen Malatesta che è un percorso performativo e narrativo a lume di lanterna con degustazione, particolarmente indicato per le famiglie. Sempre per un pubblico di più giovani ci sono poi i laboratori dal grano alla piadina o Cappuccetto Rosso o l'attraversare il bosco dei segreti. Si tratta di un percorso performativo attraverso gli spazi, inseguendo la fiaba...L'idea è di fare un'esperienza, non solo vedere ed ascoltare. La strategia sta funzionando: ogni domenica i 40 o 50 posti a seconda della proposta sono sempre esauriti. Non c'è stato bisogno neanche della pubblicità, è successo tutto quasi naturalmente.

- E per quelli che più piccini non sono?
- Lo spazio è pensato ovviamente anche per gli adulti, è un luogo di spettacolo a 360°. C'è il punto ristoro, c'è la musica, c'è il teatro oppure le iniziative artistiche per raccolta fondi come quella dell'11 febbraio per sostenere il centro culturale Meque che opera in Colombia. Oppure ancora il Salotto del custode, un luogo e una programmazione per ascolti e aperitivi fuori dal comune, in uno spazio accogliente...D'estate il wellness nel parco e la musica nella corte.
- Questa vostra programmazione ha previsto anche un aumento di organico? È stata quindi anche un'operazione che ha creato nuove professionalità?
- Assolutamente sì. Dalle 4/5 persone iniziali siamo passati a 15 persone che, tra l'altro, a parte specifiche professionalità come il barista, sono multitasking. Fanno i grafici, gli attori, ma anche l'amministrazione. Sono tutte sotto i 30 anni.

- Avete avuto un modello in testa quando avete presentato il progetto all'amministrazione cesenate?
- Sono state due le fonti di ispirazione. Una la Germania. Viaggiando in quel paese ci siamo appassionati di questi luoghi che sanno avere un'accoglienza versatile, dove chiunque si sente a casa. È a proprio agio chi arriva con il cane, è a proprio agio chi ha il bambino, il turista riservato e colto...ci sono quindi meccanismi e dispositivi di accoglienza pensati per tutti. Dai bagni pensati ad accogliere chiunque (e qui mi scappa la risata, che la questione sembra secondaria invece ormai in Italia sembra centrale: Roberta coglie il mio sorriso e dice Eh, sì, hai capito, no?). C'è un'illuminazione che ti permette di essere rilassato, ma anche leggere i libri che sono a disposizione in consultazione libera. E nessuno se li porta via, perché capisce che fa parte della nostra azione di ospitalità, e quindi perché rovinarla? L'altra era proprio questa nostra volontà specifica di fare un luogo disponibile a chiunque perché non difficile, non ostico, non per pochi. E i numeri ci confermano che non abbiamo sbagliato.
- Tra poco la convenzione scadrà, cosa ne pensa il Comune del vostro operato?
- Per il momento sono molto soddisfatti, certo ancora la convenzione non è stata rinnovata, ma il nuovo assessore sembra molto interessato alle nostre attività.
- Che cosa ti piacerebbe ci fosse che ancora non c'è, quali pezzi di progetto ancora vi mancano per essere diciamo completi?
- Ecco, un buon progetto paesaggistico per il Parco della Rimembranza. L'area verde dell'accoglienza è ancora carente e potrebbe creare uno scenario veramente magico. Capisco che può essere impegnativo, ma quando ci penso...

Devo dire che non stento a crederle, essendo anche una paesaggista ed avendo come Aidoru una particolare propensione all'azione nel paesaggio, viene da pensare che con questa ulteriore tessera potrebbe essere una Romagna diversa, meno divertimentificio senza contenuti, più divertimento con il cervello e la bellezza.
Villa Silvia - Carducci di Cesena

Ma Romagna vuol dire letteratura? Cosa si scrive e si è scritto nella terra della piadina e degli ombrelloni in serie? Partiamo con questo viaggio attraverso le case museo dedicate agli scrittori e poeti di questo lembo di terra, dicendo innanzitutto che nulla ha da invidiare alla densità poetica di luoghi in cui su questo si è costruita una tradizione turistica.
Se negli ultimi decenni l'immagine della Romagna si è dapprima identificata con I vitelloni e Amarcord di Fellini, un luogo da cui si parte per uscire dalla provincia o un luogo in cui nostalgia, stupore e baionetta si uniscono in un unico corpo, per poi divenire la terra di conquista delle discoteche e dei parchi di divertimento, in questo inizio millennio si potrebbe cominciare una riconversione “ecologica” a terra di scrittori e poeti. E forse non è un caso che proprio Amarcord, ambientato negli anni '30 della memoria del regista riminese, sia stato sceneggiato insieme a Tonino Guerra, una delle grandi voci poetiche di questa terra, fertile non solo per prodotti agricoli.
Può essere quindi straniante, ma anche evocativo, visitare la Romagna partendo dalle case museo dei suoi cantori, particolarmente concentrate tra Cesena e Rimini. Esse costituiscono un'altra geografia, quella delle parole che intessono la nostra percezione del luogo. Sono insomma una geografia sentimentale, che in realtà prevale su quella prettamente fisica.
Silvia Pasolini accanto a una signora che suona il pianoforte
Fotografia albumina. Sullo sfondo un ritratto di Giosue, forse un dipinto, tratto dalla foto scattata nel 1903 che ritrae il poeta in vestaglia nel suo studio.

Partiamo quindi da uno dei suoi centri cruciali, forse il salotto che ha riacceso il fuoco nell'Italia appena unita, ovvero Villa Silvia – Carducci a Lizzano di Cesena. Si tratta di una meravigliosa villa settecentesca, che da sola vale la visita. Era la residenza estiva di questa famiglia di tradizioni liberali e dalle morbide colline cesenati permetteva un ristoro non solo del corpo. Oggi ospita al suo interno anche il museo di strumenti musicali meccanici ed è quindi particolarmente adatta ad una visita anche con i bambini, che potranno scoprire il tamburo da guerra di Leonardo da Vinci (costruito sulla base degli appunti dell'artista nei codici conservati a Parigi e Venezia), i diversi tipi di organo, ma soprattutto la Sala Regina Margherita.
Dettaglio del ritratto di Silvia Pasolini
La Regina di fatto non visitò mai la villa, ma la sala sembra sia stata preparata appositamente per lei: il piano melodico Racca che si può ammirare proprio in questa particolarissima sala ovale era amato non solo dalla prima regina consorte dell'Italia unita, ma anche da Puccini e da Pascoli. Da non perdere anche il Giardino letterario, che guida attraverso un'esperienza uditiva i visitatori tra i ricordi e le voci di questo luogo.

La villa deve il suo nome alla contessa Silvia Pasolini Zanelli. La brillante nobildonna, chiamata dal Carducci la “fata bianca”, fu sicuramente una delle animatrici culturali più attive della zona: nel suo salotto confluirono gli scrittori Nazzareno Trovanelli, Antonio Messeri, Paolo Amaducci, i musicisti come Balilla Pratella, Achille Turchi, Federico Sarti, il celebre cantante lirico Alessandro Bonci e ovviamente Giosuè Carducci. Si erano conosciuti a Faenza, da dove il marito Pasolini Zanelli proveniva. Il “freddo tempo” dell'ultimo decennio del poeta nobelista fu particolarmente malinconico, confortato dalla amicizia elettiva con la contessa Silvia, che lo ospitò appunto in questa villa per più di dieci volte.
Carducci e gli ospiti a Villa Silvia
La relazione extraconiugale del vate con la giovanissima scrittrice Annie Vivanti era divampata proprio nei primi anni della frequentazione di Villa Silvia: lei poco più che ventenne, lui, chiamato da lei amorevolmente l'Orco, consumarono in pochi anni una passione che non fu soltanto carnale. «Signorina, Nel mio codice poetico c’è questo articolo: – Ai preti e alle donne è vietato far versi. – Per i preti no, ma per Lei l’ho abrogato» le aveva detto il già illustre Carducci quando la Vivanti si era presentata con le sue poesie alla sua porta. Difatti, promosse la sua pubblicazione e ne rimase amico sincero, anche quando si sposò un avvocato irlandese.
La stanza fu lasciata esattamente come il poeta l'aveva salutata nell'ultima permanenza: e così per testamento, quando fu donata al Comune di Cesena nel 1920, conservata sostanzialmente intatta. Il resto della casa ha subito numerosi rimaneggiamenti interni, visto che fu ricovero per i giovani poveri affetti di tubercolosi prima e poi scuola materna ed elementare. Silvia Pasolini, difatti, rimasta l'ultima a chiudere la porta della vicenda di questa famiglia, i cui figli erano morti molto piccoli, decise di donare la proprietà proprio in ricordo della permanenza del poeta di Pietrasanta, ma anche vincolarla per opere benefiche a favore della popolazione del luogo. Così i famosi versi di Jaufré Rudel di Carducci:
Contessa, cos’è mai la vita?
E’ l’ombra di un sogno fuggente,
La favola breve è finita,
Il vero immortale è l’amor.
Suonano fondamentalmente profetici.
Museo Italiano della Ghisa e la Fondazione Tito Balestra di Longiano

Cos'è che rende Parigi inconfondibile? Non certo la lingua, o la dimensione, o lo smog... sono quei piccoli particolari, resi unici dal lavoro delle mani di piccoli artigiani, artisti ignoti e amanti del lavoro ben fatto, che hanno creato l'immagine condivisa di questa città. Insieme ovviamente all'assenzio e ai balletti russi... Contano di più le passeggiate sotto i lampioni in ghisa che le pacchiane discese di un parco divertimenti. E lo sanno persino i creatori dei film d'animazione.
Naviga, non affonda (Fluctuat, nec mergituri) è nello stemma della capitale francese e di certo i particolari di ghisa che affollano molte strade, piazze, angoli non sono portati al naufragio. Anche se oggi l'architettura e l'arredo urbano sembrano essere lontani dal lavoro tipico della fonderia, ancora ne ammiriamo il romanticismo e la cura del dettaglio. È però l'ornato classico, la nascita e la diffusione delle scoperte dell'archeologia che cambiano il gusto a metà ottocento e portano le maggiori città europee a gareggiare nelle forme con l'antico, imitandone decorazioni, ma con un occhio alle tecnologie che nel frattempo si erano evolute. Insieme alla diffusione dell'illuminazione pubblica, la ghisa occuperà le strade per concedere alla notte di essere abitata. Nascerà così la vita notturna, sconosciuta per millenni agli essere umani.

Esiste in Romagna, a Longiano per la precisione, un museo che racconta questa straordinaria stagione, sia dal punto di vista tecnico che estetico, che continua a fare lavoro di ricerca sia sul passato che sul presente delle fonderie. E che è ovviamente una fondazione privata, legata alla ditta Neri, che ovviamente si occupa di arredo urbano. Il fondatore, Domenico Neri, era artista e scultore, che mise la sua arte al servizio della bellezza dello spazio pubblico, fondando un'azienda che oggi opera in più di 100 paesi del mondo. Oggi il cuore della produzione ruota intorno alla ricerca e sviluppo, con laboratori all'avanguardia, ma un occhio sempre attento alle radici. Ecco quindi l'impegno della memoria e della consapevolezza con l'apertura del Museo italiano della Ghisa che occupa un ex capannone industriale, ma anche uno spazio all'aperto e Santa Maria delle Lacrime, chiesetta sconsacrata che ospita parte della collezione. Ottima per far conoscere agli studenti la storia dell'illuminazione, l'esperienza della visita è ugualmente interessante per chi vuole unire la conoscenza della storia della tecnologia all'ammirazione per le arti cosiddette minori, forse perché più diffuse e popolari.

A questa visita potete inoltre abbinare, sempre nella stessa località di Longiano, dentro al castello malatestiano, la visita alla Fondazione Tito Balestra. Non pensate di trovare materiali medioevali, si tratta invece di un archivio nato da un lascito, quello della vedova del poeta longianese, che era stato partigiano e vicesindaco per poco tempo del piccolo comune dopo la liberazione. Balestra aveva frequentato assiduamente la Galleria “La Vetrina” di via del Babuino a Roma, dove aveva frequentato quel mondo composito e ora di nuovo tornato sotto i riflettori dei critici d'arte della scuola romana, ma anche del realismo guttusiano, dell'impegno di Sughi. La raccolta spazia da Mafai a Rosai, da De Pisis a Sironi, passando per Guttuso, Morandi, Vespignani, Zancanaro, ma ci sono anche importanti pezzi internazionali che testimoniano un gusto non provinciale e amicale (Chagall, Goya, Kokoschka, Matisse, Twombly fra gli altri). Si tratta inoltre di una collezione frutto di scambi, incontri e baratti: è come se fosse la costellazione delle relazioni di Balestra, ossi di seppia delle sue fortuite amicizie.
Come poeta fu sotto l'ala di Bertolucci, ma ovviamente la raccolta che da lui prende il nome racconta la storia di una passione visiva, che a pensarci bene è proprio limitrofa alla poesia, che è visione in parole. Numerosi sono i laboratori abbinabili alla visita, ma particolare menzione va fatta ai laboratori di poesia visiva, che riprendono proprio questa particolare congiuntura.
Vi sono anche interessanti mostre temporanee, come quella che chiuderà i battenti il 13 novembre dedicata alla figura di Marcello Mascherini, di cui si testimonia in particolare l'attività di incisore per l'editoria, anche se ovviamente non si può dimenticare l'importante opera di scultore attivo sia durante il regime che nel dopoguerra, senza soluzione di continuità.

Museo Italiano della Ghisa
Orari: Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle
16.00
Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00
Ss. Emilia, 1626
47020 Longiano (FC)
Tel. 0547 652171 652172 info@museoitalianoghisa.org
Fondazione Tito Balestra Onlus
Orari: dal martedì alla domenica e festivi,
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Piazza Malatestiana, 1
47020 Longiano (FC)
tel. 0547 665850 - 0547 665420
Museo NATUra e Casa Olindo Guerrini di S. Alberto

Si può cominciare ad essere scienziati a 14 anni. Questo ci insegna la vicenda di Alfredo Brandolini, l’ornitologo che creò la raccolta del “Palazzone” oggi Museo Natura di S. Alberto, a pochi
chilometri da Ravenna.
Nel 1906 il giovane rampollo della famiglia nobile era un ragazzino affascinato dalla caccia, che praticava però con scrupolosa curiosità classificatoria e con un’attenzione empatica alla preda,
come si desume dai suoi diari dell’epoca. E proprio il pettirosso ucciso da questo adolescente avviò la collezione tassidermica che ora è ospitata nel paese sull’orlo delle Valli. Vivere nella
natura, che tra i due secoli era più che selvaggia, fu l’esperienza che segnò il destino del laureato in Agraria e appassionato ornitologo Alfredo: pur viaggiando per tutto lo stivale, visitò
anche per tre anni l’Eritrea, non dimenticò mai le sue origini. Una caratteristica tipicamente romagnola: così la sua inestimabile collezione di uccelli costituisce oggi il fulcro di questo
museo, dove i ragazzini curiosi possono scoprire lo scienziato classificatore che è in loro, meravigliarsi di fronte alle farfalle diurne italiane (tutte le specie!) e molte notturne, le farfalle
esotiche e gli invertebrati tipici di tutto il mondo, i cerambicidi delle pinete ravennati, i mammiferi che presentano fra gli altri rarissimi esemplari asiatici, i mammiferi del ravennate, i
rettili, le conchiglie dell'Adriatico, le conchiglie di acqua dolce della Romagna, le conchiglie di terra della Romagna… Ritrovare come Sherlock Holmes la capacità di differenziare, osservare con
lentezza, scoprire e distinguere le diversità nell’apparente omogeneità delle specie, costituisce, in particolare nell’età della preadolescenza e dell’adolescenza, un presupposto fondamentale per
lo sviluppo di un approccio scientifico al sapere. È in quella età in cui si suddividono le figurine, le macchinine per colori, i vestitini per tipologie, in cui si comincia insomma a
classificare nella specie, che musei come questi possono fare la differenza. E il museo Natura è proprio un luogo magico, anche per il suo involucro, che era originariamente un “Palazzone”
utilizzato come ostello e come luogo di scambio, dove insomma dal ‘500 ci si incrociava e ci si scambiava esperienze. Gestito dal 2003 dalla cooperativa Atlantide, ospita moltissime attività
durante l’anno: fino al 9 ottobre si può visitare ad esempio la mostra temporanea dal titolo “Animalerie” di Vania Bellosi, storica illustratrice della casa editrice faentina Moby Dick e per anni
illustratrice anche di quell’oggetto presente in molte delle nostre case , il “Lunêri di Smembar”.

Ma Sant’Alberto non è solo scienza, ma anche bibliofilia, luogo di libri e cultura popolare. Vale la pena fare una passeggiata anche fino alla Casa Guerrini, centro giovani e biblioteca del
paese, nonché abitazione di quel particolare intellettuale che fu Olindo Guerrini.
Sorta di Pessoa nostrano (ma senza il modernismo), appassionato anche lui di eteronimi, agitatore e massone, consigliere comunale socialisteggiante e assessore, direttore della biblioteca
universitaria bolognese sempre in bolletta, rimatore carducciano senza però l’epos e la vena aulica del professore, Olindo è sin dal nome di battesimo una sorta di distillato di romagnolità. Il
figlio del farmacista del paese scrisse il suo libro più famoso nel 1877, superando di gran lunga le vendite delle Odi Barbare dell’incensato Carducci, usando però come soprannome quello del
cugino morto di tisi, Lorenzo Stecchetti. Pochi anni prima, nel 1872, aveva contribuito all’apertura della biblioteca popolare di Sant’Alberto, un paese allora di 2740 abitanti, perlopiù
analfabeti o con bassa scolarizzazione, che però nei primi otto mesi di apertura vide 107 prestiti, di cui 21 a nome di donne. Un successo culturale senza precedenti. Certo, molti libri non
tornavano più. Soprattutto se erano piaciuti. E se proprio entusiasmavano, i lettori santalbertesi ci tenevano a farlo sapere scrivendo a margine: “Bellissimo”, “Interessantissimo”. Cosa piaceva?
Beh, l’avventura ovviamente come Ben Hur. Anche la critica però troncava con la mannaia: "Lettore, quando tu avrai letto questo libro sarai più stupido di prima", appare appunto scritto a mano su
un libro che non vi sveliamo qual è. Provate a sfogliare qualcuno di questi testi che hanno fatto le ossa dei sogni degli abitanti del paese in questi 144 anni di letture, sarà come entrare in
un’avventura di un altro, come sentire i sussurri di coloro che hanno sognato e non sono più, o sono ancora racchiusi nel nostro leggerli, come direbbe Tabucchi.
Per chi volesse approfondire F. Gabici – F. Toscano, Scienziati di Romagna, Sironi 2007.
C. Bassi Angelini, Olindo Guerrini e la Società operaia di mutuo soccorso, Longo 2005.

Museo NatuRa via Rivaletto, 25 48020 Sant'Alberto, Ravenna
www.natura.ra.it
Orari di apertura dal 1 settembre al 30 giugno:
martedì, mercoledì e giovedì: 9.30 - 13.00
venerdì, sabato, domenica e festivi: 9.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Chiuso il 25 dicembre, 26 dicembre e 1 gennaio
telefono: 0544 529260, 528710
email: infonatura@comune.ra.it
Casa Olindo Guerrini
Via Guerrini, 60 tel.: 0544 529805
Apertura invernale: da lunedì a venerdì 14.30-18; giovedì e sabato 8.30-12.30;
Casa Moretti di Cesenatico

Serenate delle zanzare: cosa dire di più realistico e ironico al contempo dell'estate romagnola? Ed è così che si intitola la rassegna estiva che si tiene ormai da cinque anni nella corte della
casa museo Marino Moretti a Cesenatico. Sembra sentire il dolce, ehm, fastidioso verso dell'insetto più molesto della nostra sabbiosa costa, eppure nell'ambiente ovattato e fedelmente protetto
della Casa museo sul canale leonardesco anche la zanzara sembra acquietarsi, essere meno molesta, addolcirsi in questo luogo che conserva le carte e gli oggetti del poeta e romanziere che disse
“Io non ho nulla da dire...” per poi cesellare parole e versi per diversi decenni.
Nato nel 1885, attraverso i primi 79 anni del secolo breve e fu un esempio di romagnolo inadempiente alle mode, discolo e non officiale. Figlio di una maestra, ovvero della prima classe colta
femminile, fu uno scolaro irrequieto, che decise di abbandonare gli studi per seguire la scuola di recitazione di Luigi Rasi a Firenze, abbandonando poi anche quella. Non si era peraltro
diplomato al ginnasio, e anche come attore risultò scadente: non lo era però nell'uso del lapis, che diventò la sua spada. Una spada che usò anche per firmare il manifesto degli intellettuali
antifascisti di Croce.

Ironico più che polemico, Moretti diventerà noto per la sua prosa e creerà scalpore per aver superato Una vita violenta di Pasolini con la sua raccolta di Novelle al premio Viareggio nel
primo dopoguerra: lui che aveva rifutato i premi fascisti, si troverà al centro di questa sterile disputa italiana.
Fu così lontano da queste discussioni, così vicino alla “quotidiana poeticità” di cui un segno lieve si può intravedere nella linda casa museo, che si può visitare solo, ahimé, con visita
guidata. Dico questo perché, malgrado la passione delle guide di questi spazi, piace ad alcuni essere nel silenzio della propria esperienza, soprattutto quando si tratta di case di poeti e
scrittori. Come successe con Hikmet e Joyce Lussu quando questa lo portò a visitare Roma e gli raccontava ogni cosa, per filo e per segno, e questo è di quello, e qui ci ha vissuto questo,
e alla fine il grande poeta turco sbottò: “Mi hai rovinato Roma! Non potrò più scrivere niente su Roma! Non riuscirò a vedere Roma se non attraverso i tuoi occhi”, così la precisa funzione
delle guide non richieste che raccontano in modo anche troppo preciso le abitudini del letterato Moretti, tendono a volte a togliere quell'aura di opportuno mistero, che invece non nuoce alle
case museo. Chi infatti ama questo tipo di visite spesso accosta l'orecchio, come fa lo strano professore Keating de L'attimo fuggente, ai libri, agli oggetti, sperando di sentire se non il carpe
diem oraziano, un qualche verso rivelatore che possa guidarci tra i bivi della vita, senza dimenticare che siamo “cibo per i vermi”.

E questo non appare blasfemo, parlando della casa Moretti, che ci raccontano che avesse proprio l'abitudine di conversare con sorella fine: “Nomina tranquillamente la morte (il che era ritenuto
villano e impudico dagli imbecilli intellettuali); si intrattiene affabilmente col becchino del suo paese; conversa ogni domenica col cappellano del cimitero e risponde alle formule per la
benedizione dell'acqua”, racconta Casnati. Non fu però mai lontano dalla vita e per quanto solitario e fuori dalle risse editoriali nostrane, scrisse anche il soggetto di un episodio di un film
di Blasetti, Tempi nostri.
Gli spazi d'altro canto sono rimasti proprio casalinghi, poco musealizzati, e quindi l'edificio verde che ospitò a lungo Marino vale sicuramente la pena, anche solo per rivedere una abitazione
ferma nel tempo: quel tempo che fu vera materia della sua poesia e della sua prosa, che fu genericamente generoso con lui, visto che visse per più di 90 anni, e con la sua casa che continua
ad essere un luogo in cui la poesia non solo si studia (è sede infatti anche di un prestigioso premio letterario), ma ancora si fa. Nel cortile, ovviamente con le zanzare.

Casa Moretti
Via Marino Moretti, 1
47042 Cesenatico FC – Italia
tel. 0547-79279
casamoretti@cesenatico.it (direzione)
infomusei@cesenatico.it (informazioni per visite guidate / gruppi)
Casa Monti di Alfonsine

« Alta è la notte, ed in profonda calma
dorme il mondo sepolto,
...Io balzo fuori dalle piume, e guardo;
e traverso alle nubi, che del vento
squarcia e sospinge l'iracondo soffio,
veggo del ciel per gl'interrotti campi
qua e là deserte scintillar le stelle.
Oh vaghe stelle!... »
(Vincenzo Monti, Pensieri d'amore,
VIII, 124-132)

Forse non molti collegano il famoso traduttore dell'Iliade con Leopardi, che ebbe giudizi non generosi nei suoi confronti: eppure, come anche i non esperti noteranno, il poeta di Recanati si è molto più che ispirato al poeta di Alfonsine, Vincenzo Monti.
La sua importanza e la sua fama non sono facilmente intuibili oggi, perché di fatto il suo nome è oscurato da un altro canone letterario: la sua fama alterna, come testimonia anche la casa museo, realizzata durante il fascismo, rimasta indenne durante i bombardamenti che rasero al suolo il comune sul Senio e ristrutturata grazie al magnate Marino Marini.
Non è mai stato facile scegliere le belle lettere invece degli affari: non lo fu neanche per Vincenzo Monti, l'intellettuale forse più influente d'inizio ottocento della Romagna. Per colpa di questa sua viscerale passione, che lo portò ad essere l'esponente più noto del neoclassicismo italiano, fu sostanzialmente diseredato dal padre. La casa dell'Ortazzo, come si chiamava la località fuori Alfonsine dove sorge ancora la sua casa natale, passò infatti ad un nipote, figlio del fratello ingegnere. Costanza Monti, la figlia del poeta, cercò di riaverla: la bella e unica figlia del celebre poeta ebbe purtroppo una sorte molto sfortunata in tutto. Non riuscì a sposare Andrea Mustoxidi, che diventerà poi il primo ministro greco dell'Istruzione nel primo governo della Grecia liberata, per la contrarietà della madre. Si trovò giovanissima ad essere poi vedova di un conte pesarese di piccola nobiltà e si rimase inerme, preda delle maldicenze. Accusata di “facili costumi”, attrasse i pettegolezzi come api al miele, viste le sue forme generose e lo sguardo vivace, la curiosità attenta e mai banale. Quando il padre morì nel 1828, Costanza era lì ad accudirlo, ma la madre la escluse dall'eredità paterna. Così si ritirò prima dai cugini a Maiano e infine dalle suore Orsoline a Ferrara, dove morì. Sempre buona, ora anche felice fece scrivere Paride Zaiotti ai piedi dell'altare della Vergine Addolorata dove fu sepolta. Certo di felicità l'affascinante progenie dell'alfonsinese in vita non ne ebbe molta.

Il padre invece alternò, come in ogni vita, momenti di gloria a momenti di difficoltà: fu un poeta mondano, uno che copiava egregiamente e che capiva con grande acume dove tirava il vento. Così a Roma presentò al Teatro Valle (sì, proprio quello delle occupazioni di cronaca...) con grande successo la tragedia Aristodemo, ispirandosi apertamente al fascinoso Alfieri. Stipendiato dalla corte pontificia, fuggì poi in una carrozza di “stato” per passare dalla parte di Napoleone. Insomma, quando il vento cambiava, cambiavano anche i suoi versi.
Il suo carattere “bilioso”, “fomentatore di odio”, non gli permise di avere amici duraturi: il legame con Foscolo, inizialmente sincero e di mutua stima, diventerà negli anni scontro all'ultimo verso. Anche quando il Foscolo sarà a Londra non si dimenticherà di ricordare il vecchio amico come “adulatore spudorato e senza pricipi”.
Dopo l'esilio parigino, il ritorno in Italia con le nuove vittorie napoleoniche divenne un tripudio di tributi per l'alfonsinese, che diventò nel 1805 poeta di corte, ricevendo 6.000 zecchini l'anno. La caduta dell'invicibile francese non sarà la fine della carriera di Monti, ma certo il suo stipendio verrà notevolmente diminuito...
Rimane per tutti l'esperienza della traduzione dell'Iliade, che lui “traduttor di traduttori” come lo chiamò ironicamente Foscolo, rese in italiano senza sapere il greco. Eppure nella sua versione poetica, che contiene notevoli mistificazioni di senso (ma d'altro canto non lo è ogni traduzione un esacerbato tentativo di ridurre in altra lingua una materia irriducibile?) c'è molta della nostra esperienza del classico. “Cantami o diva del Pelìde Achille” è per generazioni di italiani il verso che apre all'amore (o all'odio, dipende dai casi...) per la classicità, e in questo ruolo ineguagliabile di traghettatore di senso vale la pena di accostarsi a questo museo, che contiene ben poco dell'esperienza montiana, tutta sostanzialmente agita nel centro del mondo di allora, tra Roma, Milano, Parigi e Parma. Eppure tutto cominciò in questa periferia della periferia estrema, in questa tutto sommato umile casa di campagna in cui il fratello più giovane decise di disubbidire ai genitori, e di dedicarsi alla scrittura.

Casa Monti
Via Passetto, 1
tel. 0544 869808
Apertura: da dicembre a febbraio e da giugno a agosto: da lunedì a venerdì, ore 9-13; da marzo a maggio e da settembre a novembre: lunedì e venerdì, ore 9-13; martedì e giovedì, ore 9-13 e 14-17.30; mercoledì, ore 9-13 e 14-17.
Sabato, domenica e festivi aperto solo su prenotazione.
Chiusura: dal 22 dicembre al 6 gennaio e dal 9 al 24 agosto
Ingresso gratuito
Accessibile ai diversamente abili
Parco della poesia di San Mauro Pascoli

Se volete fare un viaggio sinestetico e poetico, allora casa Pascoli a San Mauro è il luogo che fa per voi. Non è semplicemente una casa museo, peraltro parziale, visto che il poeta romagnolo
visse solo i primi anni dell’infanzia in questo edificio dove nacque il 31 dicembre del 1855. Il casone, diventato opera nazionale nel 1924 (eh sì, i fascisti amavano i poeti nazionali…), oggi
permette di vedere ricostruito anche lo studiolo universitario del famoso letterato che ottenne la cattedra di Carducci di Letteratura Italiana, ma soprattutto permette di fare esperienze
pascoliane. L’impegno dell’amministrazione del Comune, dovuto in particolare al decennio del sindaco – poeta Gianfranco Miro Gori, ha reso Casa Pascoli parte di un Parco poesia che comprende
anche La Torre (ovvero Villa Torlonia), il mausoleo della famiglia Pascoli (ma Giovannino è sepolto insieme alla sorella Mariù a Barga di Lucca… d’altro canto noi ci siamo tenuti Dante), la
cappella della Madonna dell’Acqua, ma soprattutto una vasta e articolata attività di promozione, fruizione, esperienza della poesia. Ma andiamo con ordine.

Intanto ogni 10 agosto dal 2001 viene celebrato “il processo”: nato come momento in cui si aprì la discussione, imitando diciamo Un giorno in pretura, sull’omicidio del padre del famoso poeta, il
format è continuato cambiando ogni anno imputato. Il pubblico vero vota a favore o contro, dopo aver seguito un’attenta difesa e accusa del caso, che ogni anno varia e aumenta. L’anno scorso fu
il ’68 ad essere processato - e assolto a furor di popolo, in una contesa che divenne quasi sessantottina – mentre il 10 agosto del 2016 sarà Giulio Cesare ad essere sottoposto alla sbarra.
Il luogo è l’affascinante Villa Torlonia, uno dei pochi esempi conservati e ridati al pubblico di villa romagnola del XVII – XVIII secolo, che può essere visitata durante il periodo estivo, ma
anche affittata per eventi pubblici o privati, pagando un canone tutto sommato “politico”, vista la magnificenza dell’ubicazione. Il processo acquista una particolare nota simbolica perché fu qui
che tornò “la cavallina storna” che portava il padre Ruggero, ucciso in circostanza ancora misteriose.
La Torre è anche il luogo d’elezione, insieme al Giardino di Casa Pascoli, del festival “Il Giardino della Poesia”, giunto alla sua ventesima edizione: diretto prima da David Riondino e ora da
Gori, costituisce una delle più importanti e vitali rassegne dedicate alla poesia ed è caratterizzato dal legame indissolubile con la musica e la performance dal vivo. Comincia in luglio, ma in
agosto potete gustarvi il 1 agosto il recital di Isabella Ragonese che, dopo aver interpretato Paolina Leopardi ne Il giovane favoloso, leggerà accompagnata al piano una selezione di opere
pascoliane. Sempre interpreti femminili, ma questa volta per diversi autori romagnoli, il giorno dopo, ovvero Elena Bucci e Daniela Piccari, mentre sabato 6 agosto si termina con “Giorgio Caproni
per banda” con David Riondino accompagnato dalla Banda musicale di San Mauro.

Ogni giovedì peraltro i turisti della riviera possono prenotare un percorso pascoliano gratuitamente, visto che esso costituisce “la carta d’identità del Comune” ed è proposto insieme al carnet
tipico del buon vivere, come deve essere, anche in un’ottica pascoliana. Non una distanza indissolubile tra il quotidiano narrare, tra la poeticità delle piccole cose, e il canto dei vati. C’è
un’idea molto forte in questa presenza trasversale dell’offerta degli spazi e della diversificazione delle esperienze legate a questi luoghi, che vede mobilitato il Comune “dei calzolai”, come
ironicamente si autodefinisce San Mauro, e l’associazione degli industriali, che sostengono buona parte delle iniziative.
La Casa Pascoli si presta peraltro a un’esperienza totale: si può certo visitare con nonchalance, in un pomeriggio torrido e pieno di mosche nella testa, ma è anche possibile visitare il giardino
osservando, con il libro in mano, le specie botaniche citate dal poeta nelle sue poesie e che ne costituivano il ricordo odoroso, la memoria olfattiva che portava ad una malinconia mai sedata per
la perdita del nido. Proprio questo. Con le sue rose rampicanti, la cedrina, e ovviamente la mimosa rosa: Già m’accoglieva in quelle ore bruciate/sotto ombrello di trine una mimosa,/che
fioria la mia casa ai dì d’estate/co’ suoi pennacchi di color di rosa verseggiava ne “La Romagna”… Non è difficile emozionarsi un po’ nei luoghi che furono le muse profonde della poesia del
maggior poeta simbolista italiano, anche perché in qualche modo sono anche il nostro nido, quello scolastico, delle prime poesie vere imparate, a volte malamente, ma che in qualche modo si
incidono nel cuore.

Per questo si può rendere speciale l’esperienza per chi la poesia pascoliana la incontra per la prima volta: è possibile infatti per le scuole primarie e Medie inferiori abbinare alla visita alla Casa Museo un laboratorio di ispirazione poetica alla fattoria didattica La Gazéta, coniugando un’esperienza di vita contadina collegate alla lettura di una selezione di poesie. In qualche modo, la memoria olfattiva e sensoriale viene allenata sin da piccoli, e chissà che da grandi i fortunati bambini che apprendono facendo, si troveranno in un campo avendo come sottotesto qualche verso di Giovannino. Oppure si può optare per una visita “recitata”, in cui attori animano ogni stanza…alla fine del percorso i ragazzi sono invitati a comporre la loro “poesia suggestiva”. O ancora, partendo dall’uso peculiare di odori, colori, fiori, e proprio partendo dal nome dei fiori e dalla associazione alfanumerica ai colori e alle note musicali, si può realizzare un grafico che, trasferito poi sul pentagramma, darà origine ad una melodia musicale… Perché, come ha detto Mariangela Gualtieri recentemente “meglio si apprezza il musicista geniale che ha cantato ogni centimetro di questa terra, ogni più piccola e insignificante presenza, aprendoci gli occhi, aprendoci il cuore. Ridestandoci". Diciamo che in questo parco gli ingredienti ci sono tutti perché ciò accada.

Museo Casa Pascoli
Via G. Pascoli, 46 – 47030 San Mauro Pascoli (Fc)
tel. 0541.810100
www.casapascoli.it
Orari di visita: dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (dal 16.9 al 14.6)
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (dal 15.6 al
15.9)
chiuso il lunedì
Villa Torlonia
Mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30
Domenica dalle 17 alle 20
Museo degli sguardi di Rimini

La Romagna è una fitta mappa di straordinari piccoli musei e fondazioni e ciascuno di essi ha una storia che vale la pena di essere raccontata.
Se c'è un museo che ci misura sui grandi quesiti del presente, questo è il Museo degli Sguardi di Covignano, una frazione di Rimini. Il nuovo percorso museale è stato inaugurato nel 2005 ed è stato curato da un comitato alla cui guida c'era Marc Augè. L'antropologo teorico dei nonluoghi ha sicuramente impresso una direzione innovativa e, se vogliamo, leggermente profetica a questo museo che nasce dalle donazioni di diversi collezionisti. Innanzitutto il nobile veneziano Delfino Dinz Rialto, che fondò nel 1972 nel Palazzo dell'Arengo e del Podestà, il “Museo delle Arti Primitive - Raccolta Delfino Dinz Rialto” ispirandosi al “Museum of Primitive Art” di New York fondato nel 1957 da Nelson Rockfeller. A questa prezioso lascito si aggiunsero 514 pezzi donati da Ugo Canepa, un collezionista biellese che aveva ancora tra le mani la collezione privata più importante di materiale precolombiano in Europa posseduta da un privato ,e che arrivò allo scorcio dell'inaugurazione dopo un percorso ad ostacoli durato circa un decennio. A queste si aggiunse il nucleo dei Frati Francescani missionari delle Grazie, che operano ancora ad Aitape, in Papua Nuova Guinea e una collezione di pezzi dell'Amazonia regalata dal cesenate Bruno Fusconi. Ma se da soli gli oggetti antropologici ed etnografici possono comunicare un senso di galleria delle meraviglie dell'ottocento, l'allestimento e il taglio museografico di Rimini ci portano nel cuore tenebroso dell'Europa, ovvero il nostro sguardo sull'altro. Ed è per questo che lo sforzo per il visitatore è scoprire il proprio sguardo o i nostri plurimi sguardi sull'altro: a questo invitano ad esempio le vetrine opache che sfumano i contorni degli oggetti esposti. Esse ci interrogano su cosa veramente è e cosa riusciamo a vedere della cultura dell'altro. Un nodo questo che attraversa ormai qualsiasi tema all'ordine del giorno dell'opinione pubblica: anche quando l'altro è il nostro vicino di casa spesso il nostro sguardo ha una vetrina opaca che non permette una visione non conflittuale della nostra relazione. Questo museo etnografico ci pone davanti quindi all'antico indovinello di Edipo, dando però un altro esito al grifo della sfinge: ogni essere umano ha caratteristiche comuni, ma allo stesso tempo è qualcosa di ignoto, se non addirittura segreto. E anche se oggi viaggiamo molto più di ieri, quello che incontriamo ha spesso il sapore dell'identico a noi, perché il nostro sguardo fatica a togliersi lo strabismo del monopolio culturale. È qualcosa di naturale, ma su cui serve riflettere e sperimentare. Così il museo riminese ci permette un viaggio ampio nel tempo e nello spazio, dall'Oceania all'Asia, dall'Africa alle Americhe, con pochi chilometri di benzina.

Il Museo degli sguardi si svolge di fronte a noi come un romanzo di Roberto Bolaño: difatti, come nel romanzo fiume 2666, gli sguardi che si seguono in questo particolarissimo museo che mostra
oggetti per suscitare introspezione sono quattro. Lo sguardo meravigliato, che è quello del primo incontro con l'altro, in particolare il continente americano, e che è uno sguardo che trasforma
l'oggetto in stupore, curiosità, e che lo colloca in gabinetti che devono far pronunciare a chi vi entra Uhao! E poi interviente lo sguardo scientifico, ovvero quello razionalista del Settecento:
gli oggetti riportati dai viaggi esotici degli europei sono trattati in modo “scientifico”, alla pari dei rinvenimenti delle scienze naturali, accanto ai quali spesso sono esposti seguendo
perlopiù un criterio geografico. Importante poi lo sguardo del collezionista, ovvero quello della meraviglia di chi, con criteri puramente soggettivi, ha sottratto quell'oggetto al suo contesto
per renderlo protagonista della propria “versione dei fatti”, “oggetto nuovo di stupore e meraviglia”, seguendo i propri gusti e la propria chiave culturale; ogni collezionista racconta in fondo
anche di sé. Infine, lo sguardo dell'esteta: senza l'incontro con la cultura altra gli artisti delle avanguardie, ridotti all'inabilità a seguito della nascita della fotografia, avrebbero avuto
sicuramente meno strumento per trovare nuove strade. Anch'essi saccheggiatori di sguardi, per poi promuoverne di nuovi, si sono alimentati a piene mani Gauguin, i Fauves (Derain, Matisse e De
Vlaminck), Picasso, Braque, Kandinskij e gli Espressionisti, ma in realtà lo sguardo sull'altro continua ad essere l'energia creativa più potente per gli artisti contemporanei.
Uscendo si cammina per la discesa che riporta da Villa Alvarado, sede dell'esposizione, alla strada principale un po' sospesi: chi siamo infine noi? Qual è la nostra identità? E soprattutto, in
quale specchio ci possiamo guardare senza vedere ombre? Vale la pena di ripercorrere a ritroso le radici da cui proveniamo, quelle della cultura contadina a cui apparteneva il 95% della
popolazione un secolo fa: ma per questo bisognerà aspettare il prossimo mese.

Museo degli Sguardi
Via delle Grazie, 12
47923 Covignano di Rimini
tel 0541 793858
Orari di apertura dal 1 settembre 2016
mercoledì e sabato 8.30-13.00
Negli altri giorni il Museo degli Sguardi può essere visitato su richiesta (tel. 0541.704421-26 in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì)
Ingresso gratuito
http://www.museicomunalirimini.it/musei/museo_sguardi
Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini all'Ermitage di San Pietroburgo

Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini
alla Giornata Europea delle Lingue
all'Ermitage di San Pietroburgo
Sabato 24 settembre 2016 alle 17
Glavny Shtab del Museo Ermitage (Dvortsovaya pl., 2)
Sarà il fumetto quest'anno a raccontare e presentare la lingua italiana alla Giornata Europea delle Lingue a San Pietroburgo, celebrata dal 2001 in tutto il continente.
Invitati dall'Istituto Italiano di Cultura della capitale culturale della Federazione Russa, il disegnatore Gianluca Costantini e la sceneggiatrice Elettra Stamboulis dialogheranno con il pubblico sabato 24 settembre 2016 alle 17 allo Glavny Shtab del Museo Ermitage (Dvortsovaya pl., 2) sul tema “Disegnare l'Italia a fumetti. Il fumetto di realtà nel Belpaese”. Si tratterà di una conferenza in cui i due autori racconteranno non solo la loro esperienza legata alla trilogia politica su Gramsci, Berlinguer e Pertini, ma in generale di un nuovo movimento di autori interessato a conoscere e riconoscersi nella narrazione disegnata.
La mappatura dello stivale attraverso il fumetto è infatti ormai un fenomeno consolidato che interessa non solo la casa editrice che ha editato gli ultimi lavori degli autori (BeccoGiallo edizioni), ma anche altre case editrici non classicamente interessate alla nona arte.
Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini difatti non sono solo due importanti autori, che hanno da ultimo editato “Diario segreto di Pasolini”, ma anche i curatori del primo festival internazionale del fumetto di realtà, Komikazen, che aveva presentato in tempi non sospetti i più importanti autori di fumetto non solo italiani, e hanno aperto la strada e permesso a una nuova generazione e a un nuovo genere di emergere e crescere.
Info
Glavny Shtab del Museo Ermitage (Dvortsovaya pl., 2)
Sabato 24 settembre alle 17
Organizzato da: Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo
Uccellacci! 10 anni di BecchiGialli

"Uccellacci! 10 anni di BecchiGialli"
della regista Ciaj Anna Rocchi, in anteprima il 10 settembre
#MFF2016 omaggia i 10 anni di BeccoGiallo Editorecon la proiezione del documentario che racconta la storia della casa editrice che dal 2005
raccoglie, progetta e pubblica libri a fumetti d'impegno civile.
A seguire, tavola rotonda con il giornalista ed esperto di fumetti Maurizio
Principato, il direttore artistico
del Comicon, Napoli, Alino, l'autore e giornalista Marco Rizzo, lo sceneggiatore e mediattivista Francesco Barilli, l'illustratore Matteo Fenoglio, la scrittrice e
fumettista Elettra Stamboulis e Guido Ostanel per BeccoGiallo Editore.
SINOSSI
Il graphic journalism oggi è noto a tanti, ma quando dieci anni fa la casa editrice BeccoGiallo iniziò da Oderzo, in Veneto, a pubblicarne di realizzati da autori italiani tutto era diverso. Il documentario di Ciaj Rocchi ripercorre l’avventura della casa editrice indipendente attraverso le voci dei suoi autori e di tanti esperti, ma sa anche raccontare, grazie a un controcanto surreale, le precarie e non facili dinamiche della produzione editoriale a fumetti in Italia. Tante testimonianze di esperti ed autori, come ad esempio quelle di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, autori del long sellerPeppino Impastato – Un giullare contro la mafia, compongono un mosaico che orienta in un genere che non è semplice intrattenimento, ma critica del recente passato, approfondimento, supporto all’elaborazione di una coscienza civile. Fumetti per adulti politici, per chi crede nelle avventure reali.
Alessandro Beretta
L'argine: i giusti di Cotignola raccontati in un fumetto

Ha la sua storia la salvezza a fumetti. Anzi, è proprio come se la storia di chi si è salvato da quell'onda, quella totale della Seconda Guerra Mondiale, sia stata la carne con cui il nuovo fumetto, quello che ora chiamano Graphic Novel, si sia fatto.È la storia dei sommersi e dei salvati che fa sostanzialmente da sfondo a quello che viene considerato dai più il capostipite del genere, ovveroContratto con dio di Will Eisner, una raccolta di racconti che hanno per protagonisti proprio coloro che sono al margine della New York della 5th Avenue. Gli ultimi che resistono, che provano a dare un senso al naufragio della storia, come il guardiano tedesco del caseggiato di ebrei malvisto da tutti, e che alla fine fa una scelta assoluta. E poi ovviamente c'è Maus di Art Spiegelman, che ha mostrato che non solo gli ultimi dell'argine, ma anche la memoria della Shoah, dell'indicibile, poteva essere raccontata e consegnata a fumetti.
Certo, con qualche mediazione simbolica, con una cornice narrativa, che non a caso è ripresa anche dalla coppia Lombardi e Girardi ne L'argine, il nuovissimo fumetto di Becco Giallo dedicato a Cotignola e ai suoi giusti. Durò ben 145 giorni la stagnazione del fronte lungo le sponde del fiume Senio, ma la narrazione dei due autori riesce con la levità che solo il ricordo della propria infanzia può dare, a coprire un arco temporale più ampio. È un nonno che racconta al nipote durante un carnevale in paese che cosa fu la sua guerra. Cosa fu negli occhi di lui bambino la paura, ma anche e soprattutto il coraggio dell’inconsapevolezza.

Nel racconto c'è tutta la scoperta di un mondo adulto che poteva anche essere generoso: compare infatti innanzitutto il macellaio mazziniano Zanzi e la sua rete di protezione che funse da rete per la comunità tutta, anche di coloro che sbagliavano, nella convinzione accesa che la giustizia non si fa da sé e che prima di tutto bisogna proteggere i perseguitati, a prescindere dal colore politico. Così le case a Cotignola si aprirono a chi fuggiva. Egli riuscì in quest'opera rimanendo fascista in prefettura, potendo quindi agire quasi indisturbato, cosa che dopo la liberazione lo portò incredibilmente nelle carceri di Ravenna. Poi ci sono i cotignolesi, come il padre del nonno voce narrante: «Non la lascio la mia casa». Resistere malgrado il naufragio. Resistere nascondendosi in posticci rifugi, resistere per rimanere lì, nonostante tutto stesse crollando.
Ci sono quindi quelli senza nome, la piccola folla del paese, ma compare ovviamente anche Luigi Varoli, che si sa che è un artista e fa le maschere per carnevale, ma il segreto vero non è la magia della sua arte, ma che la sua casa ospita i perseguitati che potrebbero partire con i treni per la Germania, come gli Ottolenghi di Marina di Ravenna. C'è Don Stefano Casadio e “Leno” Casadio che con l'operazione bandiera bianca mostrarono il 10 aprile del 1944 che un partigiano comunista e un prete insieme potevano fare una specie di piccolo miracolo, far cessare gli ultimi bombardamenti e salvare gli ultimi superstiti e quello che restava del paese fantasma. Tutto avviene sotto gli occhi del piccolo protagonista, voce narrante, che accompagna una capretta a farsi ingravidare e che, in questa simbolica avventura, ricostruisce e ridisegna queste pagine di storia locale, ma anche universale.

E non possiamo non vedere nella capra una “apparizione elementare della vita animale” come scrisse Contini dell'omonima poesia di Saba, una simbolica riflessione della condizione di dolore umana. Così il suo sacrificio diviene atto sacrale, che suggella un percorso iniziatico che porta alla scoperta della possibiltà del gesto di umana solidarietà. È in un certo senso una trasposizione figurativa e narrativa del sacrificio di comunione, che lega una comunità con fili invisibili, che solo attraverso l'arte del ricordo si possono ogni volta riannodare. È nei silenzi che queste pagine acquistano maggiore forza, nella costruzione di sequenze che mettono insieme i due diversissimi segni dei due autori senza l'ausilio del fardello delle parole. In una storia che tutto sommato ha smesso di essere quella di una località, ma che si propone nella sua semplice e tragica esperienza come urgente monito: l’argine sta lì, sempre pronto a indicare da che parte puoi sempre stare.
L'opera è stata realizzata grazie al progetto del Museo Civico Varoli, con il contributo di Regione Emilia Romagna e Provincia di Ravenna.
Convegno "Pertini fra le nuvole" a Marrubiu (OR)

Pertini fra le nuvole
di Elettra Stamboulis (testi) e Gianluca Costantini (disegni)
ne parlerà Elettra Stamboulis
con il sindaco Andrea Santucciu e Aldo Borghesi
(Circolo Giustizia e Libertà) a Marrubiu venerdì 1 aprile alle 17.30
al Aula consiliare - P.zza roma n.7 (Marrubiu, Oristano)
Un Sandro Pertini versatile e citazionista, seduto su una nuvola in un dialogo serrato con Andrea Pazienza: è l’espediente pop per ripercorrere la vita e l'impegno politico di un indimenticabile uomo, politico, partigiano. Anche da lassù, inquieto, l'ex Presidente della Repubblica vuole muoversi alla salvezza dell’Italia…
La coppia Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini, dopo "Cena con Gramsci" e "Arrivederci, Berlinguer", si cimenta in un racconto a fumetti su Pertini: l'approccio è, come sempre, innovativo e sorprendente sia nei testi che negli stili grafici in continua mutazione. Come i personaggi interpretati, nello scorrere delle pagine, dai due protagonisti.
Paz? Ti voglio narrare l’abicì di come si diventa socialista. E soprattutto, come lo si resta.
Intervista ad Omar Galliani

Si era aperto con Plessi l'anno corrente all'Accademia di Belle Arti di Ravenna e si conclude con Omar Galliani, venerdì 5 giugno, indubitabilmente il disegnatore più virtuoso e conturbante del panorama artistico italiano. Il dialogo con i maestri non si può concludere solo con quello dei docenti, ma con l'apertura agli sguardi e alle mani di chi fa arte ai massimi livelli. La tensione pedagogica di Galliani è visibile non solo perché il maestro insegna all'Accademia di Carrara. È l'impatto della sua visione, la luce che emerge dalla linea nerissima che costruisce le figure di una bellezza evocativamente rinascimentale di un disegnatore che continua a peccare utilizzando il disegno come arma per ricomporre una bellezza dispersa e magica. Non a caso nel 2005 a Torino una sua opera dalle dimensioni sempre maestose (5x6,3 metri) è stata messa a confronto con il volto dell'angelo di Leonardo preparatorio per la Vergine delle Rocce. Artista che ha esposto in tutto il mondo, possiede una naturale indole a concedere tempo alle cose.
Si è spesso parlato di tensione etica del suo lavoro. In che senso attribuisce questa definizione alle sue opere?
Etica è un termine desueto, ma per me fare un'opera è già qualcosa di eticamente responsabile. Dedicare sei mesi alla costruzione di una grande disegno interamente fatto a mano in questo mondo di velocità e di prontezza è già un'azione etica. Una scelta responsabile.
Il disegno è spesso definito "preparatorio": lo è per la pittura, lo è anche per il mosaico. Per lei invece è il risultato. È anche questa una forma di disfatta, come quella della splendida simmetria che ricerca in molte sue opere come inesauribile segreto?
È per me una resistenza anche in termini militari, è stare in una sorta di trincea. Tutto è militarmente costruito intorno all'economia dell'arte, quindi fare un disegno su un foglio con una funzione scientifica, analitica, impiegando tutto questo tempo è l'opera. L'opera finita è poi esagerata imbarazzante, sembra annullare i processi tradizionali del fare artistico. I miei disegni arrivano a dimensioni che non sono quelli del disegno. Dico quindi resistenza militare in senso vero reale, è una scommessa.
Chi sono i maestri? E i cattivi maestri?
I maestri sono quelli di sempre. Io uso bianco e nero, lavoro in bicromia, utilizzo il legno di pioppo, elementi basici del fare, il carbonio della matita. Non ci sono grandi esempi del passato, la mia memoria visiva, se devo dirne una, arriva a Caravaggio. O il meno conosciuto disegno di Seraut che arriva ai bordi, che non è ancorato al centro. Leonardo invece finisce i disegni, questo è sicuramente il principio cui mi aggrappo. Se pensiamo al contemporaneo in Italia De Dominicis, Longo tra gli americani. I cattivi maestri non ci sono: quelli sono eventualmente arruolati nel sistema e non me ne preoccupo.
Quanto ruolo ha l'ispirazione e quanta la traspirazione, ovvero la fatica?
Un'idea originale può cambiare, però l'ispirazione è importante. Io lavoro sempre in verticale, impossibile stare seduto, sempre in piedi. Questo produce scariche sia fisiche che mentali.
È una ginnastica. Il lavoro sublima l'idea, ma è fondamentale. Ritornando all'etica, è questo che intendo, l'idea del lavoro.
Non disdegna neanche la sfida della tecnologia senza rinunciare a se stesso, come nell'opera dedicata al Correggio, realizzata per essere visualizzata da Google.
Le tecnologie non le disdegno per niente. Il mio lavoro spesso viene criticato perché sentito come visione edulcorata, che ricerca la bellezza, ma la contaminazione del contemporaneo è continua. Io sono della generazione di Blade Runner, quella che vive il day after in cui tutto si sovrappone. Sono una scheggia della storia che naviga ancora nel presente. Tutto è contemporaneo nel vero senso della parola. Ad esempio uso la fotografia che talvolta faccio io, ma spesso arriva per casualità. Un'immagine che arriva dall'effimero del web ... fermarla e farla diventare contemplazione, è un'azione etica. Prendiamo ad esempio l'aspetto del volto, così spesso citato erroneamente come “ritratti”, nessuno in realtà lo è.
Un consiglio per chi vuole fare l'artista oggi?
Non comprare troppe riviste d'arte contemporanea. Non basarsi sulle situazioni appariscenti del mondo dell'arte. Le differenze sono la qualità. Il mondo intorno è delirante, difficile trovare qualcosa che ci attiri a lungo, su cui valga la pensa soffermare troppo lo sguardo. Tutto si assomiglia. Ci sono anche bravi artisti, ma che non hanno pensato a dove stavano e dove sarebbero andati a finire. Cercare la diversità. Cercare non l'isolamento, ma la diversità sì.
L’Accademia di Rimini? Molto fashion

Il nostro viaggio tra le occasioni formative nell'ambito delle vocazioni artistiche tocca oggi la spiaggia di Rimini. No, non quella degli ombrelloni a pioggia e delle piadinerie a strisce: esiste dietro la spiaggia una città che produce cultura visiva, che ha una tradizione importante nell'ambito in particolare della moda. Viene dall'epoca del merletto e del ricamo: lo segnalava già Elisa Ricci, moglie del più noto Corrado Ricci e grande storica di quest'arte, che in Romagna c'erano tesori inesplorati. Ora ovviamente tutto è mutato: ma questo scorcio storico ci permette di capire che il corso di Design indirizzo Fashion non è un vezzo da Accademia paritaria.
Nata nel 2001 come sezione distaccata della LABA di Brescia, l'Accademia riminese si concentra sulla progettazione artistica d'impresa. Oltre al Design, la Fotografia e il Graphic Design sono i percorsi triennali legalmente riconosciuti che si possono scegliere. La sede è vicinissima alla stazione, comoda quindi anche per i pendolari, e la sua organizzazione, molto improntata alla costruzione di gruppi classe non troppo numerosi e all'utilizzo di device individuali, ricorda alcune accademie di stampo anglosassone dedicate alle arti applicate. Non ci sono le lauree specialistiche, ovvero i corsi biennali successivi al triennio, ma si può accedere a quelli di qualsiasi altra Accademia.


C'è invece un Master in Fashion System Design: un percorso più breve e più prettamente professionalizzante All'Accademia insegnano docenti giovani, ma già affermati, come il giovane designer cesenate Cannolicchio, e anche docenti che hanno fatto la storia di altre accademie come il pittore Vittorio d'Augusta. Vincenzo Izzo, che proviene da Ravenna e che qui ha dato avvio alla sua carriera, insegna da anni tra la città di Fellini e Perugia.
Ci sono molti studenti che da altre città limitrofe prediligono Rimini, anche da città in cui operano altri istituti formativi: piace lo stile professionale, l'attenzione individualizzata allo studente, l'ambiente quasi scolastico, da classe, eppure aperto alle sinergie con il territorio. Anche se ovviamente essendo un'Accademia paritaria la retta è più salata delle accademie pubbliche.
Margherita Golfarelli, ex studentessa della Laba di Rimini e ora a 30 anni parte della diaspora creativa in Australia , ci racconta così la sua esperienza: “Come in molti altri ambienti l'esperienza la fanno le persone: ai tempi sono stata fortunata ad avere non solo docenti che ti spronavano a sperimentare ed accogliere il fallimento come parte del processo di creazione, ma anche una serie di studenti che venendo da background diversi ti ispiravano e coinvolgevano costantemente.

Il corso di Storia dell'Arte è stato il primo a fondare le basi per l'approccio metodologico a una ricerca che va a fondo alle questioni (non solo d'arte) e che porto tutt'ora con me nel mio lavoro. Il corso di Graphic Design più che andare troppo sul tecnico, mi ha permesso di spingere il modo di trovare e realizzare idee oltre il semplice fatto estetico. Nell'insieme la mia è stata un'esperienza molto bella, ma mi rendo conto che chi non è molto determinato o ha chiarezza in cosa vuole fare, alla Laba ci si può perdere un po' per strada. Bisogna quindi avere le idee chiare e non andare a tentoni. Io dopo la triennale sono andata a Milano e poi 6 anni a Londra dove ho fatto l'illustratrice e la graphic designer. Ora sono a Melbourne dove faccio la designer on the go, e qui si può fare!

E quando le chiedo quali sono le cose più importanti del clima riminesi non esita: “Sei molto seguito - non sei un numero, e hai la possibilità di partecipare a lezioni con studenti di altri
corsi e migliorare l'approccio multidisciplinare”. E il lavoro fotografico che correda questo articolo conferma sicuramente questa linea.
Per maggiori informazioni http://accademia.rimini.it.
Su Margherita Golfarelli http://apricot-juice.com
Impara l’arte (del mosaico) all'Accademia

Non è più periferia la sede della storica accademia di Ravenna: l'inurbamento degli ultimi anni ha creato come una cittadella (a cui certo mancano ancora alcuni servizi di base, come una buona ciclabile) e i ragazzi che la frequentano vivono, in questo particolare edificio che fu un centro di formazione professionale di alto profilo, in uno spazio che ricorda paesaggi ibridi di altri luoghi.
Abbiamo intervistato Paola Babini, coordinatrice del corso dell'Accademia di Bologna, e girovagato per le aule che ospitano studenti di varie età.
“Vedi – dice Babini – questa è un po' la caratteristica di questa particolare Accademia: nello stesso giorno puoi incontrare i bambini che sono venuti a fare un laboratorio per sperimentare il mosaico e gli studenti dell'Accademia di Roma”.
Sono infatti presenti 12 studenti dell'accademia della capitale che stanno lavorando, guidati dai colleghi di Ravenna e sotto l'attento occhio di Tinarelli, a una serie di mosaici che saranno poi istallati al Liceo Tasso di Roma. Passa a controllare i lavori anche lo storico mosaicista Cicognani...
- Ecco, succede così. Siamo in una fase particolare: molti progetti crescono, non riesco neanche ad elencarteli tutti. Ad esempio abbiamo eseguito un lavoro per i Carabinieri, e ora sono arrivati gli artiglieri...ieri è stato in visita il questore...

- Ma cosa si impara di unico qui? So che quest'anno c'è stato un boom di iscrizioni...
- In effetti quanto seminato in questi anni si è tradotto quest'anno in un incremento notevole di richieste. Parliamo sempre di numeri diversi da quelli delle grande accademie, ma bisogna pensare anche che l'offerta formativa è costituita da un corso triennale ad indirizzo Mosaico e un biennio specialistico della stessa disciplina. Tuttavia la particolarità del corso è che, soprattutto nel triennio, gli studenti possono assaggiare e conoscere molti linguaggi e tecniche, dalla Pittura alla Fotografia alla Scultura.

- Quindi finito il Triennio possono anche specializzarsi in altri indirizzi?
- Assolutamente sì. Molti in effetti lo fanno. Così come non tutti coloro che affrontano il biennio provengono da Mosaico. Diciamo che il Mosaico è la disciplina trainante, ma è soprattutto un leitmotiv di lettura delle altre discipline. Uno stimolo concettuale.
- Chi è il vostro studente ideale?
- Sicuramente chi pensa ad un futuro artistico, anche se ad essere sinceri sono una minoranza. Oggi i ragazzi scelgono con più facilità indirizzi che prevedono l'utilizzo di arti applicate o tecnologie. Non so se sia la crisi o un mutamento del mondo dell'arte. Ma penso lo stesso che il cardine dell'Accademia debba essere il lavoro dell'artista.

- E da dove provengono?
- Diciamo che negli ultimi anni c'è stata una prevalenza di italiani provenienti da ogni parte della penisola, con qualificate presenze di studenti stranieri da ogni continente...
Nel frattempo mentre osserviamo il lavoro degli studenti di Roma mi presenta una studentessa russa e una coreana...
- Vengono dalla Sardegna, come dal Veneto. Ci conoscono attraverso internet perlopiù. Alcuni richiamati dal Mosaico, altri da Oreficeria, qualcuno dal corso di Fotografia...
- Lo tiene sempre Guido Guidi?
- Guidi ora tiene un workshop che vede la partecipazione anche di non iscritti canonici al corso, il corso annuale è tenuto da Buda. Ma il lavoro di fotografia è sempre molto importante.
- Quali sono le ragioni per cui vale la pena di iscriversi a Ravenna?
- Direi la pluralità di stimoli, il fatto che il corso ti permette di avere un ampio raggio di esperienze curricolari, ma allo stesso tempo il fatto che è un unicum. Poi c'è questo clima di famiglia, in cui arrivano molte cose, alcune piccole, altre grandi, e c'è un rapporto individuale molto stretto. Ora ad esempio nel laboratorio di Mosaico di Strada stanno lavorando ad un progetto che sarà presentato il 18 luglio in Darsena ispirato al Museo del Bardo...(entriamo mentre i bambini stanno completando i loro lavori a mosaico...nel frattempo alcuni studenti dell'Accademia stanno lavorando ad alcuni singolari mosaici). Si tratta di figure marine realizzate con un particolare materiale fluorescente che riceviamo da una ditta di Sassuolo. Adesso un'altra ditta, questa volta di Ascoli Piceno, ci ha chiesto di testare un loro materiale per realizzare borse di lusso con inserti a mosaico...
Paola riflette. Nel frattempo squilla per l'ennesima volta il telefono...
- Avete dati su cosa fanno successivamente i diplomati dell'Accademia?
- Siamo ancora agli inizi da questo punto di vista. Molto va ancora implementato: ti posso dire che molti portano questa esperienza in altri luoghi, ad esempio una ex studentessa ha aperto un laboratorio di mosaico a Caserta. Vorrei ricordare che comunque le occasioni sono differenziate sulla base anche degli interessi dei singoli studenti: mostre, progetti, attività che si intersecano con il design, sono tante le strade che possono essere intraprese.
- Che cosa ti aspetti dal futuro?
- Credo che l'Accademia di Ravenna potrebbe diventare un'esperienza di eccellenza. Il polo perlomeno europeo del Mosaico e una fucina per gli artisti. Sarebbe opportuno anche ampliare l'offerta formativa, senza sovrapporci ad altri progetti, ci sono comunque spazi interessanti da esplorare. Ci stiamo lavorando!
Il design all’estero, ma in Romagna

Volete andare a studiare all'estero, ma sentirvi a casa? Beh, c'è l'università di San Marino ... Parte proprio dal piccolo stato situato nella nostra Regione questa indagine sulle opportunità formative in Romagna legate all'ambito creativo.
La facoltà di Design è nata da dieci anni, seguendo un trend che ha visto moltiplicarsi le scuole che propongono un percorso che storicamente è nato al Politecnico di Milano, ma che ha da sempre alcune declinazioni negli ISIA come nell'esperienza faentina, incentrata sulla ceramica. Difficile districarsi tra corsi universitari, pubblici e privati, che sotto la stessa etichetta nascondono in realtà identità piuttosto differenti. Abbiamo chiesto aiuto al prof. Omar Vulpinari, che oltre a insegnare sin dalla fondazione a San Marino, ha una vasta esperienza nel campo della comunicazione e del progetto.
Che cosa si impara alla facoltà di Design? "Gli indirizzi sono due, ma il primo anno della triennale è sostanzialmente propedeutico. Serve a capire meglio le differenze tra il design della comunicazione e design di prodotto. Ma già dal secondo anno può cominciare a selezionare un percorso più specifico che ti porterà alla fine della laurea triennale a concludere gli studi e cercare di posizionarti nel mondo del lavoro oppure continuare con la laurea specialistica, attiva anch'essa a San Marino o in altri atenei. Bisogna ricordare che il progetto formativo è nato in partnership con lo IUAV di Venezia e, anche se ora la facoltà cammina con le sue gambe, lo IUAV certifica e garantisce l'equipollenza con il titolo accademico italiano". Certo, non dimentichiamoci che siamo all'estero! È come si sta in questo estero così vicino? Cosa trova uno studente che in qualche modo contraddistingue l'esperienza di studi? "Beh, innanzitutto la qualità di un campus giovanissimo sia come strutture, appena rinnovate ma poste in un contesto storico, quindi un'alta qualità ambientale complessiva, sia come corpo docenti, particolarmente giovane e brillante. San
Marino si può permettere, vista la giovane età, di selezionare collaboratori che nascono nella professione e che hanno lo sguardo sul futuro. Così il corso di design ad indirizzo comunicazione è particolarmente indirizzato alla comunicazione dinamica, ad alto contenuto tecnologico, e il design di prodotto è sì incentrato sul prodotto classico, tipo la sedia, ma trova particolare attenzione il prodotto interattivo, che oggi è maggiormente richiesto, insieme ad esempio al biomedicale. La rivoluzione digitale richiede un lavoro più complesso, il presupposto è l'innovazione tecnologica per cui c'è ampio spazi per prodotti innovativi e di servizio". E per la vita serale c'è Rimini? "Certo la repubblica sammarinese non può competere con la lady godiva dell'Adriatico, ma l'atmosfera familiare, da comunità che si vive all'università ha qualcosa di speciale. Sono circa 400 tra studenti e docenti e hanno parzialmente cambiato le abitudini dello stato. Questa possibilità di avere un rapporto individualizzato, capillare, continuo, tra docenti e discenti è sicuramente uno dei punti di valore". E a livello di opportunità lavorative cosa fa l'università? Esiste un accompagnamento al lavoro , un tutoraggio? "Compreso nei tre anni della laurea di primo livello c'è lo stage, che può essere fatto anche all'estero, in più da pochi mesi è partito il parco scientifico tecnologico di
San Marino che offre finanziamenti per idee di Start Up selezionate e uno spazio incubatore, a cui l'università ovviamente collabora.

Per quanto riguarda il tuo specifico settore ci sono particolari possibilità? "Avendo lavorato per 16 anni per la comunicazione sociale delle Nazioni Unite, ho portato questa esperienza con me e da tre anni ogni anno ci sono studenti che fanno lo stage a Bruxelles per questo ente".
Ci sono sistemi di welfare per gli studenti, studentati o altro? "in realtà no, ma la segreteria fa un ottimo lavoro di supporto. La condizione familiare sta anche in questo. Stare in una realtà piccola, ma accessibile permette di concentrarsi sul lavoro e lo studio, ma essere connessi con il mondo. I docenti hanno come età media 40 anni e gli assistenti spesso sono ex studenti. C'è una rete collaborativa informale molto forte."
E finora chi sono stati gli studenti? "C'è innanzitutto un buon equilibrio di genere, ovvero maschi e femmine in modo paritario, cosa positiva per una facoltà di design. L'età dei ragazzi è bassa, sono in maggioranza appena usciti dalle superiori, anche se c'è qualcuno dirmi orientato, perché magari aveva sbagliato la scelta iniziale. Provengono dalla Romagna e dalle Marche, ma anche molti dal Veneto e qualcuno da qualche regione più a sud delle Marche. Per il momento non abbiamo studenti stranieri, è un peccato". E i docenti? "come dicevo è uno degli aspetti più rilevanti, credo la forza principale della scuola. In questo caso l'internazionalizzazione è significativa, soprattutto nei workshop di luglio. Ma anche il meglio italiano. Ad esempio è venuto Massimo Banzi, l'inventore del microprocessore arduino.
Ecco dunque un cambiamento significativo nel panorama del monte Titano: non solo piadina e medioevo, ma anche sguardo all'innovazione e alla creatività. Una scelta originale per dire agli amici
"sono all'estero" e diventare designer.
Lo scrigno di Cesena

Il corso di Scenografia del Melodramma e del Teatro Musicale
La Romagna riserva sempre incredibili sorprese: piccole nicchie di qualità, luoghi del pensiero e del fare in cui le mani e l'immaginazione creano isole forse poco note di meraviglia. Il corso specialistico di Cesena è sicuramente una di queste chicche: fa parte della variegata offerta formativa dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ed ha già compiuto 10 anni. Nata inizialmente come Triennio e biennio, è divenuta poi un'offerta fortemente specialistica ed è un unicum nazionale. Le attività didattiche e laboratoriali sono svolte in un capannone di 700 metri quadri, messo a disposizione grazie al connubio accademia e territorio, dalla Cassa di Risparmio locale. Guidata per i primi anni da Enrico Manelli, ora in pensione, vanta docenti che mescolano attività di docenza e professionale. “Come in una bottega rinascimentale” mi dice il prof. Claudio Magrin, il quale aggiunge: “Questa è una scuola per studenti fortemente determinati, appassionati, curiosi. Non ci sono orari, come succede in teatro. Quello è il tuo obiettivo, creare la magia sulla scena. Con qualsiasi tecnica: fotografia, disegno, pittura, digitale. Non ci sono preclusioni. Noi lavoriamo per tirare fuori il tuo talento, ma tu ci devi mettere il sudore e la volontà. Il teatro non ha giorni festivi”.

E moltissimi sono i docenti che si muovono tra palco e banchi: da Rinaldo Rinaldi, finissimo pittore scenografo che ha lavorato per tutti i grandi maestri italiani, a Paola Mariani, che insegna Tecniche di sartoria ed è responsabile dei costumi del Rossini Opera Festival di Pesaro, se si scorre il curriculum degli insegnanti si capisce come il concetto di bottega artistica sia particolarmente azzeccato per questo biennio.
Per questo motivo, mi racconta Marcello Morresi, gli studenti vengono da tutta Italia e con diplomi anche molto differenti: “Non è fondamentale avere fatto il triennio di Scenografia. È certo un elemento utile, ma abbiamo avuto studenti che avevano completato gli studi ad Architettura e che volevano dedicarsi alla progettazione scenica. La complessità dell'allestimento del teatro musicale ti permette di affrontare questioni pluridisciplinari, risolvere problemi che richiedono più competenze e professionalità”.

E il rapporto con la città, come si presenta? “Certo, dice sempre Morresi, è una piccola città di provincia. Però è importante il lavoro informale che noi facciamo, di buon vicinato diciamo così, con le esperienze eccellenti che essa offre. Ad esempio il teatro di Castellucci o il laboratorio di Zimmermann e Amoroso”. Parla ovviamente di Plastikart che produce istallazioni per la biennale, per l'expo, per musei e aziende di tipo avveniristico e di rara bellezza. E i ragazzi che escono diplomati da voi che cosa si trovano di fronte? “Se hanno lavorato con serietà e attivato la loro passione, non sono certo a spasso. Dal comunale di Bologna, ai maggiori teatri d'Italia si possono trovare studenti che sono passati di qui”.
Se quindi imparate facendo, siete concentrati sull'obiettivo e soprattutto siete interessati alla comunicazione della scena, di quel mistico luogo in cui tutto si consuma nella relazione con lo spettatore, non abbiate paura di intraprendere questa strada: “Non è un problema se uno studente non sa disegnare bene. Quello lo risolviamo. Ma se alle otto vuole smontare, beh, meglio si scelga un'altra strada...”.
Per conoscere il piano di studi http://www.ababo.it/ABA/scenografia-del-melodramma/
Un docente ogni cinque aspiranti restauratori

Il corso di laurea che ha sede a Ravenna è uno degli otto in tutta Italia. Molti gli studenti dall'estero.
Ci vogliono 1825 giorni per diventare restauratori. Una rivoluzione formativa che ha portato i vari percorsi universitari a diminuire nel numero, ma a crescere in intensità. Una delle otto università in Italia che permette di conseguire il titolo di restauratore e l'abilitazione alla professione di restauratore di beni culturali è a Ravenna. Ne abbiamo parlato con la prof. Maria Giovanna Belcastro, l'alter ego di Temperance Brennan l'eroina antropologa forense creata da Cathy Reichs.
Non appena le cito la protagonista di Bones si scioglie in un sorriso...Ma ovviamente non usa escamotage così popular che per far colpo.
- è un percorso impegnativo – prosegue dopo essersi lasciata andare un momento – che è nato a seguito del riordino nel 2011 dei percorsi universitari e dura cinque anni. Come Farmacia o Veterinaria, per capirci. L'obiettivo era dare al tema del restauro qualcosa in più rispetto alla pratica di un artigianato qualificato. Una più robusta conoscenza dei materiali, della diagnostica, degli aspetti biologici e chimico fisici, ma anche storico artistici, che il restauratore competente deve tenere presenti nel suo mestiere.


- Certo che sarà difficile essere ammessi: sono solo 5 + 5 i posti a disposizione...
- La scelta del numero contenutissimo di studenti per anno è dovuta ad un aspetto didattico previsto dalla normativa. Ci vuole un restauratore professionista per ogni 5 studenti. Il rapporto laboratoriale infatti è strettissimo e parte sin dal primo anno. Poi è vero c'è l'esame di ammissione: ma invito i diplomati interessati a non scoraggiarsi. Se è vero che chi ha fatto un Liceo Artistico è più favorito nelle prime prove di tipo attitudinale e grafico, è pur vero che le conoscenze scientifiche, la determinazione, l'interesse vero per questa figura professionale sono ingredienti fondamentali per accedere al corso. E soprattutto per diventare restauratori.
- E chi sono per il momento i vostri studenti?
- Ahimè per adesso sono sostanzialmente tutti da fuori Ravenna. Segno che c'è un'attrattiva della sede, però è un peccato che non ci sia ancora un intreccio positivo tra territorio e questa opportunità. Abbiamo inoltre molte domande dall'estero. Un altro fattore interessante, per il quale faremo una riserva di posti per studenti extra UE. Il restauro è ancora un presidio formativo europeo e in particolare italiano.
- Perché mi chiedo uno studente dovrebbe scegliere Ravenna e non una delle altre otto sedi? Avete una specifica vocazione?
- Sì, la parola vocazione è quella giusta. Ed è quella dell'archeologia emiliano romagnola. Se ad uno studente interessa il dipinto è più interessante la vicina Urbino. L'unica altra sede ad avere un piano simile al nostro è Bari, ma ovviamente gravita su un bacino diverso, anche se devo dire che l'Ateneo bolognese attira, per la sua attenzione agli studenti e il ranking sempre positivo nelle classifiche, molti studenti meridionali.
L'altro aspetto che vorrei sottolineare è che Ravenna proveniva dall'esperienza conclusa di Tecnologia e diagnostica che permetteva la lettura scientifica, ma non l'intervento sul reperto o opera. In un certo senso questa laurea ha completato il percorso, tesaurizzando quel percorso.
- Sarà difficile studiare e lavorare in cinque in classe...
- Forse. Ma sicuramente è molto curato il contesto, la relazione tra docente e studente è estremamente fitta e subito si entra nel vivo del lavoro.
Non riesco a trattenermi, perché avendo letto il curriculum della coordinatrice del Corso, l'immagine di Brennan aleggia fantasmatica...
- E la sua professionalità che proviene da studi prettamente scientifici, come si coniuga con un percorso che comunque insiste sull'ambito storico artistico? (di nuovo sorriso)
- Beh, la mia è proprio una storia nata con la Biologia. Che poi è diventata Antropologia Fisica, questo strano sapere che ha a che fare con i resti umani. Può diventare forense oppure no, dipende da cosa trovi e anche da chi viene chiamato quando si trova uno scheletro, come è successo recentemente in via Rizzoli a Bologna durante i lavori.Carabinieri o Sovrintendenza? Certo, è un ambito per pochi. Siamo un pugno in tutta Italia... (di nuovo sorriso, poi torniamo veloci al tema). Credo che anche una disciplina come la mia mostri quale multidisciplinarietà attraversi questa laurea. Quali competenze complesse siano necessarie. Oggi non si può più diventare restauratori in Italia se non accedendo a questo tipo di percorsi formativi. Ravenna è un'occasione favorevole, il rapporto con la Sovrintendenza, con la Fondazione Flaminia, con Ravennantica. in generale con gli attori del territorio che facilitano il nostro lavoro, garantisce una qualità effettiva al titolo.
Quindi per chi ha sempre sognato di curare, preservare e conservare l'antico, le date da segnarsi sono
Iscrizione alla prova di selezione: 20/08/2015
Prima prova di ammissione: 31/08/2015
Seconda prova di ammissione: 02/09/2015
Terza prova di ammissione: 04/09/2015
Per info: http://corsi.unibo.it/MagistraleCU/ConservazioneRestauroBeniculturali/Pagine/default.aspx
Il voto greco ci racconta chi siamo diventati

È andata così: esco alle 2 di notte da un localino underground, dove con amici abbiamo suonato e bevuto svariate birre. Bella serata, bel clima. Andando a casa vedo file di gente ai bancomat. Dico: “Caro, siamo in guerra?”. “Macché — mi risponde lui — la gente esce e rimane senza soldi…”.Arrivata a casa accendo la Tv. E so che non abbiamo firmato l’accordo capestro. Tiro un respiro di sollievo. Meglio la guerra simbolica che quella vera». Così mi racconta mia cugina al telefono domenica. Lei ha un negozio di vestiti da donna e fa anche vestiti su misura, ha studiato moda a Roma. Fino a qualche anno fa la sua attività era una piccola fabbrica di soldi, ora stringe denti e cordone della spesa.
«Che vuoi fare — aggiunge –. Non si può vendere anche la dignità». «Ma dicono che Tsipras perderà il referendum…». Alla mia obiezione scatta una grassa risata: «Chi dice una fesseria del genere? Persino le televisioni prezzolate dagli ex partiti di governo danno il no all’83 percento». Io rimango interdetta, e anche un po’ senza parole… Ancora una volta la superficialità dell’informazione di flusso colpisce come un mitra: «Non so, gira questo sondaggio… L’ho letto su Facebook». Scopro poco dopo che si trattava di un sondaggio online fatto da un quotidiano il giorno prima del discorso di Tsipras e che misurava l’europeismo ellenico. «Guarda, ogni volta che esce Dijsselbloem e apre la bocca 10 sì diventano 10 no. Hanno pestato troppi calli. Lo sai come sono i greci… Non gli toccare la bandiera, il senso d’orgoglio nazionale. Ci trattano come ladri e imbroglioni… E continuano a fare l’occhiolino a chi ci ha ridotto così. E poi, prendi ad esempio la zia Zacha. Prende 350 euro di pensione al mese: che gliele riduca la Merkel o il default… Almeno nel secondo caso avrà salvato la propria dignità».
Ecco, non so se anche in me si sia accesa quella fiammella dell’orgoglio, se sia il callo pestato che duole, se semplicemente mi sembra che la storia in questo strano paese stia scorrendo veloce e non la voglio perdere, ma penso che vorrei andare a votare. Ne ho sempre avuto diritto: sono nata in Italia, ma come tutti coloro che nascono qui da genitori non italiani, ho acquisito la cittadinanza a 19 anni. Prima avevo il permesso di soggiorno. E la cittadinanza greca non la perdi neanche se ti travesti da ottomano. Eppure non l’ho mai esercitato il diritto di voto. Ho sempre fatto prevalere il principio civico di agire come elettrice dove vivo, e non dove vivono i miei numerosi parenti. Questa volta però è diverso: il voto mi sembra europeo. È un riappropriarsi di quella voce che spesso viene addormentata dal cloroformio del «niente cambia, tutto è scritto, questa è l’unica via possibile». Una retorica spietata e travolgente, malgrado i dati allarmanti sulla disparità sociale anche nel vecchio Continente. Ricchi sempre più ricchi, poveri sempre di più (e meno garantiti). Il discorso menzognero di una classe dirigente che rinnega persino quello che scrive sembra non essere leggibile anche da chi ci si trova in mezzo alla diseguaglianza e alla disparità. La favola del cattivo bambino, che non ha pagato il gelato che ha mangiato, è semplice e potente, molto di più dell’analisi economico e finanziaria dei dati del debito greco, semplicemente cresciuto come un tumore impazzito grazie alla cura finora attuata.
I socialisti del Pasok e i conservatori di Nuova Democrazia, che hanno tenuto le redini del paese dal 1974, hanno eseguito in modo puntuale e obbediente le ricette che il farmacista ha loro prescritto. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, e hanno portato il paese che ha inventato la parola Europa a scendere in un baratro da cui sembra difficile risollevarsi. Difficile, ma non impossibile. Questa è la differenza di questo strano governo, il cui premier scravattato crea un panico comprensibile: è proprio diverso. Anagraficamente, politicamente, ha amici diversi. Si guardano e fanno fatica a riconoscersi questi dinosauri della politica, che gestiscono il potere da generazioni (provate a guardare le loro biografie e capirete di cosa parlo) e questi nuovi arrivati, che sono stati esclusi dal potere storicamente.
Per dire, io sono la prima (e finora unica) dipendente pubblica della mia numerosissima famiglia (14 cugini di primo grado per capirci): quando vinsi il concorso per diventare insegnante, mia
nonna si bevve un brandy per festeggiare. Chi era di sinistra per generazioni non ci pensava proprio e non poteva entrare nell’apparato pubblico. Parlo di questa esclusione, non di vincere le
elezioni. Eppure è successo: ora le carte sono sparigliate, le piaghe purulente e visibili. Sembra che nessuno riesca ad immaginare cosa può succedere. Ma questa è la politica, immaginare il
possibile e provare a costruire nuovi orizzonti.
Pubblicato sul settimanale Ravenna e dintorni del 3 luglio 2015
Partecipazione alla conferenza internazionale di Amsterdam comics: “Comics Interaction”
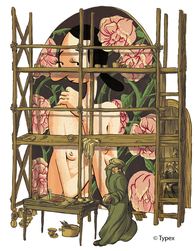
Sono molto lieta e curiosa di partecipare a questa importante conferenza che avrà luogo dal 1 al 3 luglio all'Università di Amsterdam. L'obiettivo è incoraggiare le connessioni interdisciplinari
tra gli studiosi di fumetti, gli artisti, gli editori e gli operatori culturali di musei e altri istituzioni culturali. Tre i focus: Il fumetto e l'arte, l'arte nel fumetto; storia e trauma nel
fumetto: il fumetto come letteratura mondiale. Partecipano tra gli altri il Prof. Dr. Jan Baetens, dell'Università di Lovanio in Belgio, il Prof. Dr. Bart Beaty, dell'Università
di Calgary in Canada e Dr. Joyce Goggin, dell'Università di Amsterdam. Io interverrò in un panel nell'ambito di History and Trauma: Body Politics il 3 luglio e credo che
sarà una discussione molto stimolante, fuori dagli schemi soliti, un po' autoreferenziali, a cui siamo abituati:
Panelists:
Jonathan Gill “’This Women’s Lib Stuff’: Samuel R. Delany and Wonder Woman”
Candida Rifkind “Jordan and the Giant: Graphic Biographies of Sports, Spectacle, and Trauma”
Elettra Stamboulis “Drawing reality, assuming a point of view: A visual militant practice”
Roel van den Oever & Max van Kreij “Holy Camp, Batman! Deconstructing the Opposition between Seriousness and Silliness in the Batman Universe"
qui il programma completo www.amsterdamcomics.com
Favole per bambini molto stanchi

giovedì 25 giugno
DENTE presenta
"Favole per bambini molto stanchi", volume illustrato edito da Bompiani e realizzato insieme al noto disegnatore Franco Matticchio.
presentano Francesco Farabegoli ed Elettra Stamboulis
all'interno banchetto di Libreria Modernissima
Questa favola va letta ad alta voce
Così anche nel buio
La favola si vede
Fine.
Le favole di Dente sono un universo di pianeti curiosi e impertinenti, che rifiutano la logica, giocano con la morale, rovesciano le leggi della fisica e della sintassi. Eppure, come accade nella vita di tutti i giorni, i personaggi che li abitano si innamorano e si odiano, si parlano e non si capiscono, sono fragili e un po’ spietati, ma soprattutto ridono molto, rimanendo serissimi.
Giuseppe Peveri detto Dente è nato a Fidenza nel 1976. Tra i più acclamati cantautori della nuova generazione, ha all’attivo cinque dischi che gli sono valsi un’accoglienza calorosa del pubblico e della critica.
Franco Matticchio illustratore, autore di fumetti e pittore, ha collaborato con le più importanti testate in Italia e all’estero, dal “Corriere della Sera” al “New Yorker”.
Cartoon in Khartoum - Intervista a Khalid Albaih
Pubblicato su Linus, maggio (2015)

Giocando con il nome della capitale del suo paese, il Sudan, Khalid Albaih ha chiamato il suo progetto khartoon. Lievemente ironico, ma sostanzialmente politico, è un disegnatore fuori dagli schemi africani. Non fa vignette satiriche, ma usa il disegno per consegnare un messaggio politico. Ovviamente è in esilio dal sul paese dove, come mi ha raccontato a Perugia al Festival del giornalismo, pochi giorni fa hanno chiuso 17 quotidiani in giorno. Così vive in Qatar e lavora come curatore in museo. Non è purtroppo comune incontrare un disegnatore nero: prima di lui avevo conosciuto solo Ho Che Anderson. E come Anderson, ha una chiara visione di questo suo essere raro e del perché è così complicato fare critica politica attraverso il disegno vivendo in paesi autoritari. Tuttavia, proprio come il biografo a fumetti di M. L. King, non usa mezze parole per descrivere quella che per lui è “l’ipocrisia del colonialismo del pensiero”.
Così sei un nero sudanese nato in Romania?
Esatto, sembra quasi una condanna… Ma ci sono rimasto poco. Mio padre era un diplomatico così ci siamo mossi tra Europa dell’est e dell’ovest, e altri continenti. sono andato a vivere in Sudan quando ero ragazzino.
E quando hai cominciato a disegnare?
A disegnare potrei dire da sempre, ma ho cominciato a disegnare fumetti ai primi anni di Università, quando mi sono iscritto alla facoltà di Graphic Design. A quell’epoca giocavo anche per la nazionale di basket…
Che tipo di fumetto hai incontrato e quali ti hanno formato?
Sostanzialmente quello che si trova in Sudan sono le traduzioni della Marvel, Dc comics, Disney, poi i fumetti egiziani e libanesi, e ovviamente i fumetti prodotti nel paese.
Sono curiosa di sapere che tipo di fumetti sono…
Veramente interessanti, ma le riviste sono praticamente morte. Io sono però un lettore forte, soprattutto di Graphic Novel. Ho amato molto Habibi di Craig Thompson, tutto di Joe Sacco. Ho apprezzato moltissimo recentemente Il mio miglior nemico, di Filiu e David B. Sui rapporti tra Medio Oriente e Usa. Purtroppo non si può comprare da noi. È vietato e non capisco perché, è un bellissimo libro di analisi storica molto corretto nell’impostazione. Poi Jerusalem di Guy Delisle. Sono stato pero solo una volta ad un festival di fumetto…al Comicon di Dubai. Ma non ci sono fumetti! Potevi pagare e farti fare foto con famosi disegnatori, ma c’erano solo giochi! Ero proprio frustrato!
Hai però contatti in tutto il mondo…
Sì, per fortuna c’è internet! Ma ho anche partecipato a una trasmissione con Zulkiflee Anwar Haque, il disegnatore malese i cui libri sono stati censurati in Malesia ed è stato anche arrestato per i suoi disegni e con Carlos Latuff su Al Jazeera. (http://stream.aljazeera.com/story/201401290053-0023426). Essere associato a loro è stato per me un grande onore. Mi sarebbe piaciuto che fossero stati invitati a parlare qui anche loro di Charlie Hebdo. Mi dicono che la mia visione è tale perché sono musulmano, ma Carlos è un brasiliano, e la sua posizione non è diversa dalla mia.
Questo è un tema molto complesso per la sensibilità europea. Negli USA ci sono state posizioni ancora diverse. Ad esempio Nicole Schulman, una disegnatrice del gruppo WWIII, ha detto che ovviamente era molto dispiaciuta per quanto accaduto, ma che comunque non poteva sentirsi “Charlie” perché la testata è stata spesso sessista e maschilista…Anche Joe Sacco ha espresso una posizione non dissimile
In qualche modo è anche la mia posizione. Quello che è successo è tragico e ingiusto, ma non muta la mia opinione sulla rivista. Cabu ha partecipato alla Guerra d’Algeria, in generale il loro è stato un discorso dell’odio e viene propagandato come libertà d’espressione. E comunque, lo vuoi fare, ok, fallo. Ma la storia dimostrerà che sei dalla parte sbagliata. Devi dire qualcosa che metta le persone insieme. Devi pensare ai vicini di casa. Quanti musulmani vivono in Francia? Vuoi che ti odino? Tu, come essere umano devi porti il problema dell’incontro, non provocare lo scontro. Non dire, me ne frego, e dico quello che voglio, senza pormi il problema dell’altro.

La storia di Charlie però è diversa: hanno avuto un’attenzione particolare, quasi ossessiva, verso tutte le religioni. Non solo verso l’Islam… Si sentivano liberi di puntare il nostro dito su espressioni della religione, non solo islamica, che percepivano come ostacoli alla libertà…
La questione è come ne parli. Io parlo dei tabù e parlo anche della religione. Non è semplice in società autoritarie come la nostra, ma non ho paura del potere. Non è di quello che parlo. ma della sensibilità che mostri all’altro, al tuo pubblico, al tuo destinatario. Il punto è che lo vuoi fare? Quello per cui combatti è posso dire il cavolo che voglio? La gente muore ogni giorno per avere un minimo di diritti umani, e la questione è dire qualsiasi cosa ti passa per la testa? Credo che l’attenzione all’altro sia sostanziale.

Però per i francesi è un simbolo della libertà di espressione. Se avessero scelto Le Monde o Le Figaro sarebbe stato diverso…
Noi viviamo con questa gente. Li vediamo crescere ogni giorno. Noi siamo le prime vittime del terrorismo. La nostra vita è segnata dalla loro violenza. Ma allo stesso tempo questo non è motivo per me di difendere la linea editoriale di Charlie. Gli attentatori volevano reclamare qualcosa, la loro rabbia voleva colpire questo tipo di obiettivo.
Hanno colpito la redazione del loro quartiere, quella che vedevano ogni giorno passando da lì e più facilmente avvicinabile…
Non lo sapevo. È un dettaglio interessante. Ognuno per me ripeto ha la libertà di dire quello che ritiene giusto. Allo stesso tempo noi come disegnatori abbiamo il dovere di porci il problema del messaggio consegnato: come arriva al destinatario, è uno strumento per creare ponti o dividere. Quali sono i limiti che dobbiamo rispettare perché la critica sia efficace, ma allo stesso tempo rispettosa dell’altro. Senza questo recinto diventiamo non solo fragili, che questo è semplice per il lavoro che facciamo, ma portatori di un discorso d’odio.
Questa intervista è stata realizzata durante il Festival internazionale di Giornalismo di Perugia
Possiamo ridere - I Podemos tra satira e app
L’articolo è stato pubblicato originariamente su Linus, n° 599, aprile 2015

Per comprendere il movimento spagnolo Podemos, non c’è bisogno di leggere editoriali autorevoli: bastano le vignette. Per sapere se sono di sinistra o meno, non c’è bisogno di fare elucubrazioni sul colore viola che hanno scelto come guida, ce lo raccontano i satiristi soprattutto avversi al movimento ispanico.
Pablo Iglesias, il leader indiscusso del nascente astro politico iberico, ha 37 anni ed è un brillante docente di Scienze Politiche dell’università di Madrid. Porta i capelli lunghi e proviene dalla Gioventù comunista (eh, sì, proprio quei cattivoni), che ha abbandonato nel 2007 per abbracciare i movimenti no global. L’altro esponente politico di spicco, Monedero, anche lui cattedratico, è stato consulente del governo venezuelano. Una vicenda che gli è costata una sorta di condanna mediatica: il vignettista JM Nieto su ABC nel 2014 ha ritratto un dubbioso Maduro (presidente del Venezuela) che legge un trattato economico del dirigente di Podemos, con didascalia lapidaria: “In realtà ci sono alcuni spagnoli che hanno contribuito al fallimento del Venezuela”.

Nella vignetta non c’è spazio per i distinguo, naturalmente: la visione d’insieme prevale, senza sfumature. È la sintesi per gli occhi di analisi spesso diluite in migliaia di parole: l’accusa di vicinanza con il chavismo e la politica venezuelana, tacciati di populismo. Si tratta ovviamente di un dibattito che si muove all’interno di categorie politiche decisamente di sinistra: bolivariani, guevaristi e tutte le altre, apparentemente dismesse, del Novecento, sono state rispolverate dal movimento nato come rivolta rabbiosa contro una classe dirigente cieca, sorda e autoreferenziale, e che ha trovato condottieri nelle aule universitarie.
A proposito, ecco che nelle vignette ritorna l’immagine epica del cavallo di Troia, con Iglesias/Ulisse che rimbrotta la truppa troppo interventista: “Compagni bolivariani, siete come bambini. Ripeto: aspettate il mio segnale”. Segno che la presa del potere da parte del neonato partito viene sentita come prossima, anche se ottenuta uno stratagemma.
La rappresentazione mediatica del gruppo dirigente dei giovanissimi Podemos è però assai più vasta di qualche vignetta satirica. Forse perché il capellone Pablo è diventato celebrità nei talk show televisivi, prima che portavoce di un movimento che alla prima tornata elettorale ha preso l’8%. O forse per il protagonismo sui social network, che non passa inosservato: Iglesias viene disegnato da Manel Fontdevila mentre si fa un selfie gigioneggiando con Papa Bergoglio, ironizzando sull’onnipresenza del leader spagnolo che stranamente non ha ancora raggiunto il numero di follower del pontefice; intanto, tutti quanti i Podemos sono protagonisti di una parodia televisiva del programma satirico catalano Polonia.

Titolo evocativo, The Tic Tac Theory (che ammicca con il seguitissimo The Big Bang Theory): nella sigla d’apertura le immagini che si sovrappongono a quelle dei tre protagonisti sono ritratti di Marx, Mao, Che Guevara. E i tre sono Iglesias, Monedero e il giovanissimo Íñigo Errejón, anche lui ricercatore universitario, che ha guidato la campagna elettorale e furoreggia in TV. Le puntate mettono insieme gag generiche (Iglesias e Errejon stanno giocando alla Playstation, quando il capo del partito esclama: “Attenzione! Un gruppo di zombie bancari attacca un pensionato!”) e attacchi mirati (Monedero viene accusato di aver incassato centinaia di migliaia di euro da governi non propriamente democratici), mischiati con la solita critica alla casta, tema onnipresente nella polemica politica del nuovo milieu spagnolo. La casta ha ispirato anche una app, Casta Wars: il logo è quello di Guerre Stellari, il protagonista lo jedi Pablo Iglesias, in lotta contro i vecchi politici. Inutile dire che è diventata virale in pochi giorni.
Ma come affrontano la satira, questi nuovi arrivati sulla scena politica? In un caso, si sono già esposti: è successo quando il comico Facu Diaz ha mandato in onda uno sketch televisivo in cui assimilava i politici del Partito Popolare a terroristi. Mentre i popolari lo accusavano di aver superato il confine della decenza, Iglesias ha twittato: “No alla censura, sì alla libertà di espressione. Sto con Facu”. Si capisce quindi, che uno così difficilmente può reagire male alle critiche o all’ironia che si scagliano sulla sua persona.
Chi ha paura di Cappuccetto Tsipras?
L’articolo è stato pubblicato originariamente su Linus, n° 598, marzo 2015

Chi ha paura di Cappuccetto Tsipras?
Fotografia della satira ellenica ai tempi si Syriza
V for Varoufakis anche sui Social: in questi giorni di intensi viaggi e incontri per definire le condizioni di revisione del debito greco, uno dei più nominati nello spazio virtuale del Web è proprio lo scravattato accademico neoministro greco. Forte della sua precedente notorietà in rete, supportato dall’aspetto fisico e dallo sguardo languido, il ministro delle Finanze più desiderato del momento, ha vinto la battaglia dei cinguettii, non solo tra i greci, ma anche tra i tweet in inglese. La citazione più amata mette in campo tutta la suggestione del “siamo pochi, ma buoni”, uno dei refrain della comunicazione politica del partito vincitore alle elezioni: “Ad un certo punto qualcuno deve pur dire No. Questo ruolo è ricaduto su di noi, la piccola Grecia (At some point someone has to say No. This role has fallen to us, little #Greece), frase che è rimbalzata per circa 5000 volte in inglese.

Ma nell’immaginario, oltre al piccolo e indifeso paese, al paese cuore antico di una civiltà occidentale che costruisce il proprio DNA proprio su una parola di origine ellenica, democrazia, è emerso un nuovo personaggio, recuperato dalla memoria fiabesca e ben presente nell’iconografia della caricatura politica, e che ben si sposa con il rosso Tsipras. Piccolo e rosso, indifeso ma deciso a compiere la missione, ovviamente nella fiaba è lei, la bambina che viene mangiata dal lupo. Ed ecco il secondo messaggio più amato dal popolo della rete sociale: Let’s make a deal, wolfie! (Dai, facciamo un accordo lupetto!), e ovviamente il ruolo del lupo non può che essere quello di Wolf_Schauble, ormai un nuovo epiteto per il ministro dell’Economia tedesco, l’inossidabile uomo di potere germanico che, oltre ad avere negoziato la riunificazione tedesca, siede in gabinetto dal 1984 quasi ininterrottamente.

Dall’altra parte cappuccetto rosso in versione Tsipras, che forse sarà sbranato, ma intanto è dalla parte dei buoni. Niente politically correct sulla carrozzina e la disabilità del ministro germanico, dovuta ad un attentato del 1990 di uno psicopatico. Ma diciamo che sui tedeschi la scure della satira non guarda in faccia nessuno. Come se le matite si fossero fermate agli anni ‘40.
Qualcosa però è cambiato nel mondo della satira: intanto come in tanti Paesi sono scomparse riviste storiche. Babel innanzitutto: molti italiani se la ricordano perché era un luogo particolarmente attento al fumetto nostrano, e poi organizzava il più bel festival europeo. Una sorta di trance musicale fumettistica dove accorrevano migliaia di giovani, ma senza mercato e senza cosplayer. È scomparsa Galera, un tentativo durato alcuni anni di mettere insieme fumetto politico e satirico. Ma soprattutto sono scomparse in una notte la TV di Stato e il quotidiano più importante, Eleftherotipia, seppelliti da una classe dirigente inetta e vorace. Di conseguenza anche gli spazi per il confronto, per la pubblicazione si sono ristretti notevolmente. Sono sopravvissute però esperienze come To Pontiki (il topo), storico settimanale satirico a base di fotografie con balloon e articoli particolarmente ironici. Ci sono stati poi alcuni importanti contributi, la crisi ha tolto lavoro ma non lo sguardo, e così sono fioccate le pubblicazioni che mappano la crisi, i suoi effetti sociali e i suoi colpevoli (come ad esempio il Memorandum dei disegnatori).

Così prima delle elezioni i disegnatori greci si erano concentrati sulla rappresentazione di una classe dirigente ormai asservita ai potentati esterni al paese, colpevoli della crisi devastante e dei suoi effetti sulla popolazione, ma il post elezioni non li ha lasciati privi di strumenti per ironizzare e per contribuire alla demitizzazione di un governo che altrimenti potrebbe parere veramente troppo bello per essere vero.
Intanto Tsipras da ragazzo veloce e imprendibile (come nelle vignette del 2008 di Ioannis Ioannou, uno degli storici disegnatori umoristici ellenici) che soffia sul collo del partito socialista allora al potere saldamente (sembra un secolo fa…ma sono solo sei anni!), è diventato il birbante cappuccetto rosso, ateo e presenzialista.
Il lupo è sempre cattivo, ed essendo individuato nei tedeschi, è troppo facile cadere nel cliché deltetesco kattiven, anche se in molti disegni si sottolinea che i lupi sono tanti.
La società greca, ancora arcaica per alcuni versi, viene rappresentata nella sua medietà dall’uomo primitivo o dalla contadina/pastore. Anche se girando per le strade di Atene la sfavillante metropolitana, linda ed essenziale, sembra parlare di un’altra epoca, la tradizione e il villaggio sono rimasti nel cuore. Dio si sarà dimenticato di parlare con Samaras, l’ateismo esplicito e inusitato per il nazionalismo greco (stato e ortodossia stanno nella stessa bandiera) diventa nelle mani dei caricaturisti un oggetto di lieve satira, sagace, ma non forcaiola. Un po’ come, mutatis mutandis, l’omosessualità in Italia: una questione su cui tuonare, ma che non ha impedito a Vendola nella terrona Puglia di essere eletto due volte. Così il giovane premier sarà pure senza Dio, ma nel dialogo con il Papa la sua attenzione a chi rappresenta il clero viene trasformata in attenzione per il numero di seguaci, non diversamente da Lady Gaga. E il cambiamento di schemi e di soggetti al potere è bene presente in molte vignette di questi giorni: Satirikos di To Pontiki nella fotografia del nonno e della bambina sottolinea i cambiamenti del sistema scolastico e le paure di una revisione culturale in Grecia (“cosa avete imparato oggi a scuola?” “La dialettica del processo storico, nonno”)

Massimiliano Fabbri e il "volto" di Selvatico

Massimiliano Fabbri (Faenza, 1972) è un artista totale: pittore, curatore, agitatore culturale, un loquace e poliedrico affamato di arte, che carpisce ai bambini i piccoli e grandi segreti dello sguardo disincantato. Vive a Cotignola, dove è anche cresciuto, dove anche lavora, dove organizza mostre e rassegne che fanno impallidire i vicini parigini.
Come sei diventato pittore? Era quello che volevi fare da piccolo?
«No, da piccolo volevo fare il fumettista... Poi una serie di incontri in Accademia a Bologna, una serie di gesti banali o semplici, che in realtà non lo erano, hanno sviato il mio percorso. Pulini ad esempio la prima volta che ha visto il mio lavoro mi ha portato alla biblioteca del Dams e mi ha aperto un libro di Lucien Freud e uno di Auerbach. Scoprii che c'erano altri che avevano allenato lo sguardo a cercare quello che io con fatica cercavo. Fu un gesto che ritengo importante, anche adesso: l'arte è un luogo di furti, di metabolismo continuo di ciò che c'è già stato».
E quindi abbandonasti il fumetto...
«Non so dirti perché, continuo a leggere fumetti, ma dopo il Liceo Artistico a Ravenna l’unica sicurezza che avevo era che volevo andarmene, ma l’unica soluzione era una scuola di fumetto a Milano, che però era fuori dal mio budget. Era una fase in cui Bologna era un territorio fertile, era un bel modo per aprire gli occhi».
C'è stata quindi questa conversione sulla via per Damasco...
«Non so se si possa parlare di conversione... Ancora oggi è una cosa un po' urticante per me la divisione per settori. Oggi il fumetto è per me uno specchio che guarda il mondo in maniera trasversale, è un luogo di scontri, mescola il popolare con visioni diciamo più alte».
Questa tua opposizione alla divisione con l'accetta si vede anche nel tuo operare... In questi progetti che tu attivi come curatore sei come un compositore polifonico, metti una nota e poi dici ora fatemi un'orchestra, e mescoli generi e persone.
«L'artista non è un lavoro che si fa in solitudine. Serve, ma ho sempre avuto bisogno di qualche cosa che mettesse in atto una specie di traduzione di questo tipo di solitudine con un passo verso o con gli altri. Per vivere in questi anni ho fatto altro, ho lavorato per i bambini, questa cosa mi ha nutrito molto e costretto a non usare trabocchetti. Davanti ai bambini sei costretto a smontare i meccanismi. Il lavoro di curatore, anche se non è proprio il termine giusto per me, porta a creare lavori collettivi: credo di portare lo stesso sguardo di artista in questo operare. Sono d'altro canto il contrario della “fuga di cervelli”. Mi sono trovato a lavorare nello stesso posto in cui ho passato i pomeriggi da bambino: casa Varoli è di fronte alle case popolari dove vivevo. È una roba terribile: hai un’erosione della memoria quotidiana, non c’è qualcosa che puoi mettere nel cassetto per i momenti commoventi. Mettevo in fila i miei soldatini lì, ma ogni giorno ci timbro anche il cartellino. Per un artista la scelta più intelligente è andare nel mondo, l'altra scelta, quella più stupida da un certo punto di vista, è quella di rimanere sul proprio territorio...»

A te è toccata la seconda...
«La provincia è quella di qualsiasi provincia. Parlando di Selvatico, la rassegna che io curo, non potrebbe essere in città neanche come Bologna. Il titolo originale era difatti “rassegna di campagna”, la dimensione dell'isolamento era il motore di tutto questo movimento. Non può andare altrove. Devi avere un rapporto familiare con questi spazi».
E il tuo rapporto con Varoli?
«Sono cotignolese, e come per tutti Varoli è un nome intoccabile. Da giovane lo vedi come un padre, quindi lo devi uccidere. Per un giovane artista è un artista post impressionista, senza assalti e fughe. Ma poi scopri che è multiforme. Lavoro per uno dei musei che reputo tra i più divertenti della bassa Romagna. Negli ultimi anni mi sono occupato del Varoli giusto, della resistenza passiva operata da lui, dal prete Argnani, e da Vittorio Zanzi, che aveva una carica fascista, ma che fascista non era, che permise di salvare 41 ebrei dallo sterminio. C’è il piccolo cenacolo che lui formò, con artisti che poi lo superarono. È stato un raccoglitore di oggetti strani, un insegnante tra i primi in Italia a dare importanza al disegno infantile. Credo che quello che fa Selvatico, portare persone in luoghi che difficilmente sarebbero da loro attraversati, sia una pratica vicina alla sensibilità varoliana».
In questa edizione di Selvatico, che è iniziata a Conselice con il Collettivo FX e altri, quale sarà la nota che guiderà la tua composizione visiva?
«Sono partito da una mia ossessione. Un innamoramento che è tornato negli ultimi mesi, che è il volto. Non tanto come genere a sé, ma come tema che permette di credere ancora nella possibilità che quello che abbiamo disegnato, dipinto ci guardi a sua volta. E quindi mettere al centro anche lo spettatore, perché il volto è uno specchio, lavori con i fantasmi. Dico scherzando che Selvatico è diventato grande e si può permettere di affrontare un tema che fa tremare le gambe. Negli ultimi anni disegnavo solo paesaggi, natura. Era un lavoro domestico, potevo interrompere e riprendere. Rispondeva anche a dinamiche familiari. Mentre la pittura richiede un tempo monastico. Poi ho ripreso a interrogarmi sui volti. Dopo il Bianco e il Nero di Selvatico, mi sembrava che ragionare sui colori fosse un tema esaurito. Così ci saranno artisti nuovi, mai visti a Selvatico, e altri già incrociati. Selvatico parte dalle memorie, dalle identità dei Comuni della bassa: volevamo allargarlo a tutti e nove. A Conselice ad esempio non c'è nessun museo sul quale lavorare, quindi ci siamo collegati al progetto di muri pubblici di Pellegrini che è uno scenografo. Le cose sono date anche da coincidenze, un'affinità, come quella con il Collettivo FX, Dissenso Cognitivo, e molti altri».
E il catalogo, che è sempre un oggetto molto bello del progetto Selvatico?
«Esce il 30 novembre in coincidenza con la prima mostra, ed affronta il tema dei volti da molteplici punti di vista. Solo l'arte contemporanea ci sembrava poco. Ci sono ad esempio disegni dei bambini, in collaborazione con Pinac, l'unica pinacoteca italiana e un modello d'eccellenza a livello internazionale, del disegno infantile. C’è un percorso sulla fotografia che si intitola Lo scudo di Perseo, pensato insieme a Buda e Casadio, in cui interpretiamo la macchina fotografica come fosse uno scudo per tagliare la testa al mostro e vedere meglio. C'è il video, c'è un continuo mescolamento. Ci sono i collezionisti privati dell'area lughese, una quadreria come una sorta di flusso...Difficile numerare ed elencare tutti gli artisti coinvolti e i rivoli selvatici. L'unico modo è muoversi e vedere».
Per info dettagliate sulle mostre e gli artisti http://museovaroli.blogspot.it
Elogio del paesaggio Intervista a Silvia Camporesi

E' possibile che il pensiero prenda forma in immagini? Proviene da studi filosofici l'artista Silvia Camporesi, protagonista insieme a Valentina Accardi a Rimini del progetto “Vie di dialogo”. Silvia, classe 1973, ed è sicuramente una delle artiste della nostra regione su cui tenere gli occhi puntati: per il rigore del lavoro, per la ricerca formale e intellettuale alla base di ogni progetto che usa la fotografia come mezzo puramente artistico.
- Quando si è consumato il tuo incontro con la fotografia? Come soprattutto si è consumato questo incontro...
- Ero verso la fine dell'Università dove studiavo Filosofia, e ho incontrato alcuni fotografi che mi hanno insegnato la tecnica in maniera molto basilare, stampando in camera oscura. Quando ho cominciato a fotografare ho capito subito che non era solo documentazione, ma uno strumento con cui potevo inventare dei mondi. E quindi ho subito inserito un aspetto più filosofico nella ricerca.
- Quindi per te questi due aspetti sono allineati, in dialogo, filosofia e fotografia. Raccontaci come è possibile questo incontro...
- Per me la fotografia non è lo scatto, ma anche tutto il lavoro che precede e segue. Se tratto ad esempio il paesaggio, faccio miei alcuni concetti filosofici che affrontano questo tema e poi cerco di tradurli in immagini. Magari non letteralmente. Ma quel tipo di ricerca nasce per aver letto Foucault o Perec. Non uso la fotografia per documentare, ma la uso per raccontare un'idea. Lo scatto è l'ultimo atto di un processo molto lungo.
- Il percorso che è cominciato alla fine dell'Università come si è svolto, come sei arrivata all'oggi: luci ed ombre...
- Non avevo ovviamente i riferimenti tipici di chi fa un'Accademia. Ho cominciato a studiare, vedere, curiosare da sola. E partecipando a dei concorsi. Parlo di un'epoca in cui essi erano uno strumento molto valido, prima che la parola “crisi” diventasse la porta che chiude tutto. In Italia e soprattutto in Emilia Romagna per i giovani artisti c'erano molte opportunità. E quindi per anni sono andata avanti vincendo concorsi...
- Come ad esempio il premio Guercino a Bologna...
- Esatto. Potevano essere sostegno economico o mostre. Così comunque ho conosciuto i galleristi che hanno cominciato ad espormi.
- E oggi?
- Mi sembra che la situazione sia scivolata in maniera tragica. Finché non passa questo periodo terribile...non so, ho poca fiducia.
- Cosa si dovrebbe fare?
- Non certo formarsi! Un artista deve poter lavorare, esporre, produrre.
- Questa mostra di Rimini che cosa presenta?
- è un progetto che in corso, un viaggio in Italia a tappe. Sto visitando tutte le Regioni italiane e fotografo i paesi abbandonati per un libro che poi uscirà all'inizio dell'anno prossimo per Corraini. Nella mostra di Rimini ho esposto la tappa Emilia Romagna. Per cui il lavoro sui paesi, i luoghi abbandonati nella nostra Regione.
- Sei affascinata quindi dall'abbandono?
- Mi interessano soprattutto i luoghi poco noti, quelli che non sono compresi nel classico immaginario del sistema Italia. E ora con questo progetto, avendo ricevuto il sostegno di 15 collezionisti che finanziano la ricerca, ho avuto la possibilità di scandagliare visivamente questo aspetto. Mi interessa di questi luoghi la loro fragilità. Il fatto che quando li vado a fotografare sono in un momento della loro storia che li vede in un processo di cambiamento repentino, perché di lì a poco crollano, oppure saranno ristrutturati.
- E' un po' la malia della vertigine, del precipizio, vedere la prima della fine. La tua non è documentaria, può essere intesa come opera di salvaguardia di un luogo o comunque il flusso delle cose prevede la sparizione?
- la questione della memoria non mi interessa in particolare, a me interessa soprattutto la loro condizione dei luoghi in quel momento. Lì ci sono state persone e quindi perchè se ne sono andate. Sfuggo quindi alla documentazione anche perchè c'è un intervento massiccio di post produzione: le foto sono in bianco e nero e io le ricoloro a mano con dei colori innaturali, molto morbida. Inusuale.
- Sei come tornata alle origini della fotografia...
- è anche un'azione concettuale, l'idea di colorarli è dedicare tempo e cura a qualcosa che sta sparendo.
- Della nostra Regione quali sono i luoghi che ti hanno colpito di più?
- Sicuramente il teatro di Novi, chiuso prima del terremoto e poi ulteriormente danneggiato dal sisma. Oppure paesi abbandonati come Formignano sopra Cesena. S. Antonio sopra Modena. Discoteche del riminese lasciate alla natura... di posti ce ne sono tantissimi. Li ho scelti anche in base alla loro estetica.
- Hai anche gallerie che ti seguono oltre ai collezionisti?
- Sì, la Photographica Fine Art di Lugano e la Z2O di Roma.
- E con la galleria di Lugano hai fatto anche un progetto internazionale?
- sì, con loro ho potuto proseguire un lavoro sul paesaggio che avevo iniziato a Venezia, facendo un'indagine sull'Armenia. Ovviamente il collegamento era dato un filo come S. Lazzaro degli Armeni che segna anche topograficamente due luoghi apparentemente così distanti.
Si può vedere il progetto sui luoghi abbandonati in Regione a
VIE DI DIALOGO/4
Silvia Camporesi / Valentina D’Accardi
A cura di Claudia Collina e Massimo Pulini
Museo della Città di Rimini, Ala Nuova
6 settembre 2014 – 26 ottobre 2014. Inaugurazione 6 settembre ore 18
orario 10-13 / 16-20 / lunedì chiuso
ingresso libero
Sito personale http://www.silviacamporesi.it
Gallerie di riferimento
Imperiituro. Quel che resta degli Ottoni
Catalogo "Imperiituro"
Renovatio imperii: Ravenna nell'Europa ottoniana, a cura di Maria Pia Guermandi , Silvia Urbini, testo in catalogo, 2014.

Secondo Malraux non c'è progresso e nemmeno 'storia' fra la creazione degli stambecchi o dei cervi di di Lascaux o Altamira e il toro inciso di Picasso": così esordiva Jean Clair in un'intervista in forma di dialogo sull'arte moderna. Riprendendo questo paradosso, che mette in crisi qualsiasi ipotesi storicista che veda nell'evoluzione una progressiva conquista di nuove mete, potremmo dire che non c'è evoluzione e soluzione di continuità fra molta dell'arte figurativa medievale e il fumetto contemporaneo. Di tutte le epoche organiche alla costruzione del presente, l'età di mezzo (e in modo particolare l'Alto Medioevo), costituisce una di quelle in cui l'imperativo del linguaggio verbale era meno dominante. L'arte non era solo "guarigione dal concetto" e "riappropriazione della presenza dell'essere", ma era l'unica bussola per orientarsi nel mare magnumdell'esperienza narrativa. E spesso immagine e parola coesistevano ed era naturale districarsi in un flusso sequenziale di immagini che snocciolavano le fasi salienti di una storia.
Non è quindi difficile cedere il passo all'analogia tra nona arte e rappresentazione medievale, soprattutto bizantina. Eppure, la stessa distanza che c'è tra la scelta sintetica di Picasso nelle incisioni, la possiamo ritrovare nei silenzi e nelle scelte figurative dei disegnatori di fumetto contemporanei.
È quindi forse più interessante sottolineare quanto rivela diversità, più che rammendare questo vestito dismesso con le analogie evidenti tra un medium nato popolare come il fumetto (e come l'arte medievale fortemente connotato dagli intenti didascalici e sintetici) e quanto rimane dell'arte figurativa altomedievale. Certo è che il Medioevo è profondamente radicato nel fumetto, sia come tema narrativo che come utilizzo delle tecniche rappresentative: come hanno raccontato in modo piuttosto esauriente le mostre del 2010 nella Torre di Giovanni Senza Paura "Le Moyen Âge en Bande Dessinée" e in modo più sintetico l'esposizione didattica "Nuvole di Medioevo" dell'Istituto Alcide Cervi; l'esposizione francese era concentrata a indagare, con ottimi apparati filologici, come il fumetto abbia riutilizzato moduli visivi e linguistici già presenti nell'età di mezzo, la mostra reggiana più concentrata sul come il fumetto abbia rappresentato il Medioevo.
Di quest'ultimo tema ha scritto anche Umberto Eco negli anni Ottanta, sistematizzando il tema del sogno del Medioevo. Essendo pura rappresentazione, cuore e origine dei nostri mali, non lo si ammira, dice il professore bolognese, lo si abita. "Il Medioevo inventa tutte le cose con cui ancora stiamo facendo i conti, le banche e la cambiale, l'organizzazione del latifondo, la struttura dell'amministrazione e della politica comunale, le lotte di classe e il pauperismo, la diatriba tra Stato e Chiesa, l'università, il terrorismo mistico, il processo indiziario, l'ospedale e il vescovado, persino l'organizzazione turistica, [...]. E infatti noi non siamo ossessionati dal problema della schiavitù o dell'ostracismo, o del perché si debba, e necessariamente, uccidere la propria madre (problemi classici per eccellenza), ma di come far fronte all'eresia, e ai compagni che sbagliano, e a quelli che si pentono, di come si debba rispettare la propria moglie e languire per la propria amante, perché il Medioevo inventa anche il concetto dell'amore in Occidente".
È quindi lì l'armamentario, il baule a cui si attinge, e il fumetto lo fa a piene mani, a volte in modo inconsapevole. Il sogno del Medioevo è anche rappresentato nel Medioevo in forma di fumetto ante litteram: per esempio ne La Grande Cronaca di Francia, il sogno della regina che dorme a sinistra è rappresentato a destra in una serie di vignette che seguono l'ordine di apparizione degli animali onirici. Ci lascia quindi increduli la ricostruzione visiva della rêverie: una modalità di scomposizione e rappresentazione dell'esperienza del sogno che diventa fantasticheria rappresentata e che scomparirà nei secoli della tarda modernità per ricomparire solo nell'Ottocento. Essa diventerà quindi in Bachelard uno strumento cognitivo.
L'andare e il tornare a questa età tenebrosa, da Tasso ai Romantici, da Carducci a Dante Gabriel Rossetti, al fantasy e al thriller monacale, non fanno che posizionarci nel mondo, ricostruire la nostra tela valoriale, rivedere il nostrostatus del presente, sulla base della nostra mappatura di questo passato immaginario. Questa mappatura diviene linea e segno, costruzione sequenziale e logica, geografia dell'immaginario realizzata in una storia a fumetti. La tela del ragno che invade i sogni diventa visione incarnata, che, per ragioni di permanenza date dalla necessità visiva e delimitante della linea e della costruzione sequenziale delle vignette, ricostruisce stilemi e modalità rappresentative che, proprio nel Medioevo, hanno avuto particolare fortuna.
Si tratta quindi di una rifondazione dell'immaginario che utilizza lo stesso scalpellino e lo stesso alfabeto medievale, mutando codice e funzione. Tale spostamento di significato (dall'analisi alla ricreazione di senso) diventa particolarmente evidente se si prova, come nel caso della mostra alla Classense di Ravenna, a raccontare o evocare gli Ottoni: Adelaide, Teofano, Gerbert ovvero papa Silvestro II. Tre nomi che certo non possono competere nella narrazione popolare, nel sogno del Medioevo appunto, con altri più evocativi e ormai archiviati nella nostra strapiena memoria. Eppure, le loro vite movimentate, il loro essere erranti in un'Europa sempre raccontata come immobile e poco incline al viaggio, li rende fantasmi fosforescenti e a noi più comprensibili. Le vite di Adelaide e Teofano, per esempio, mettono in crisi le figure stereotipate delle donne medioevali. Sono donne che con il potere stringono patti, che il potere lo esercitano e lo diffondono. Papa Silvestro II ha una forte carica simbolica: il suo essere il pontefice che attraversa il pericoloso anno 1000, con un nome altrettanto evocativo che lo lega alla memoria di Costantino, ormai divenuto nella vulgata il cristianizzatore, costituisce un tassello anch'esso dissonante dall'elenco dei papi tenebrosi. E ci spiazza, perché era anche e soprattutto matematico e studioso.
Ma in tutte queste notizie manca un collante visivo, un retaggio patrimoniale, un luogo di accoglienza di disperse indiscrezioni storiche, che rischiano di rimanere erudizione, se non sostenute da un ponteggio che sarà anche sogno del Medioevo, ma d'altro canto i fatti senza narrazione e senza correlativi oggettivi, luoghi e oggetti che fisicamente li richiamino, rischiano di diventare rumore. È vero che la nostra "storiografia percettiva" si concentra su quello che ci rende vicina ed empatica la storia. Sulla voce in prima persona, sul segno autoriale di disegnatori che non nascondono la loro attitudine artistica e quindi interpretativa. La storia diviene la loro, e ci viene restituita in un formato accogliente, un guscio che racconta di noi. L'esotismo di questo luogo temporale, lontano per gestualità e pensiero, diviene un elemento di continuità culturale. D'altro canto il fumetto affonda le sue radici proprio nelle rappresentazioni e narrazioni medioevali, quando l'altro si interseca con la fiaba e con un ignoto che per essere compreso diviene forse "orientalismo storico": mutuando questa categoria nel senso interpretativo di Edward Said si può dire che il rafforzamento degli stereotipi derivanti dal mondo elettronico e postmoderno hanno avuto effetto anche sulla rappresentazione del Medioevo. Riuscire a scartare consapevolmente o meno gli elementi fondativi della visione consolidata di un'epoca di cui ancora viviamo le strade e gli spazi, ma da cui ci sentiamo profondamente ed esoticamente lontani, non è processo semplice. Tanto più in un contesto in cui si ricostruisce sottotraccia un elemento identitario geopolitico attraverso la rivisitazione di un periodo e di una dinastia: continuità e permanenze, Ravenna e gli Ottoni, il qui e l'allora, in un dialogo in cui è l'hic et nunc ad acquistare in spessore e senso.
Niente può essere aggiunto a quanto già stato. La saga di questa tutto sommato breve stirpe di potenti, che visse nel continuo balenio dell'universale, una categoria che doveva ricucire un mondo in disgregazione entropica, una dinastia che vide nelle donne d'Oriente e d'Occidente figure carismatiche, in questo ultimo rapporto vero tra il vecchio Oriente, che di lì a poco chiuderà per qualche secolo il rapporto con un'Europa assertiva e proiettata verso nuovi centri, è sicuramente un luogo di racconti che facilmente scuotono la nostra sensibilità di ascoltatori. Anche oggi nell'Europa politica e in quella geografica che continuano a non combaciare c'è un richiamo continuo, non sempre funzionante, a categorie universali che uniscano. Il fatto che questi richiami non si tramutino in veri ponti non è materia di questo contributo: vero è che la costruzione dell'Europa è un fattore che coinvolge l'immaginario più che la fisica da sempre.
Non c'è quindi intento didascalico, come spesso erroneamente si attribuisce anche solo nominando il medium del fumetto. L'obiettivo è rigorosamente ermeneutico, apertamente e dichiaratamente soggettivo e di attribuzione di nuovo senso. Nelle brevi e fulgide storie di Gianluca Costantini, Giuseppe Palumbo e Rocco Lombardi che si possono ammirare in mostra, segni diversi e diverse sensibilità pittoriche pescano dal naufragio della storia piccoli amuleti che ci dicono soprattutto chi siamo noi, che cosa resta del giorno. Una sorta di rêveriestorica che, come ci insegna Bachelard, non può essere raccontata, ma va messa su pagina.
True Detective / Across the Line
Catalogo "Across the line", artista Nerosunero (Mario Sughi)
Edito da GIUDA edizioni, 2014

“Io penso che la coscienza umana sia stato un tragico errore dell’evoluzione. Siamo diventati troppo consapevoli di noi stessi. La natura ha creato un proprio aspetto che è diventato indipendente da essa. Siamo creature che non dovrebbero esistere, secondo la legge naturale”. Rustin Cohle in True Detective, The Long Bright Dark, episodio 1 stagione 1
Oltrepassare la linea tra ciò che appare e ciò che è: questo è uno dei centri narrativi più ustionanti della serie TV più osannata degli ultimi tempi, la pluripremiata True Detective. Una reazione curiosa di un pubblico che sembra essere coltivatore di autoreferenziali certezze, aduso al pregiudizio, non educato alla sperimentazione e alla ricerca di fonti e che invece si è sentito fortemente attratto da questa miscela di fotografia artistica, dialoghi nietzschiani e piani sequenza lunghi come quelli sovietici.
Anche in questo ciclo contraddittorio vi è la croce della nostra non contemporaneità. Viviamo nell’era dell’informazione, attoniti disinformati. Edulcorati e corretti da una scroll page di faccialibro. Pizzolatto, lo scrittore che ha realizzato la serie di HBO, ha guardato il paesaggio della Louisiana, quella terra di confine che è anche la sua, un luogo in cui il tempo sembra veramente a diverse dimensioni, e ha deciso di renderlo una metafora narrativa. Esso è infatti continuamente non tanto lo sfondo in cui si svolgono le complesse vicende, che hanno diversi livelli temporali, ma il vero spazio catalizzatore del contenuto. Il suo rimando, il suo specchio deformato. Il luogo che contraddice l’ovvietà della realtà narrata dal chiacchiericcio globale. Il “The truth is out there” di X Files, ma senza alieni.
Nerosunero (alias di Mario Sughi) non abita in Louisiana, ma sembra provenire dalla stessa necessità di togliere il velo alla Maya del paesaggio, e del contesto. A partire dalla tecnica, che nega senza appelli la possibilità materica dell’originale feticcio. Se la realtà è rappresentazione, sogno, onirica presenza, non vi è più ragione d’essere della sacralità del feticcio al di fuori del suo intangibile senso. La sua apparente pittura, che gioca con la nostra percezione, ci provoca allo stupore cooptato (ma guarda un po’ che si fa con il computer, come se esso avesse una sua potenza autonoma, un’intelligenza menomata che noi attiviamo), all’incredulità isterica (oh my god! Veramente la pittura digitale anche del ritratto?) in un percorso che, se l’arte già dagli anni ‘60 aveva non solo sdoganato, ma aveva fatto gridare alla fine degli dei, ancora oggi nella percezione condivisa e universale, provoca reazioni esattamente allo stesso modo dell’epoca di Beuys.
I dettagli deformanti (un lampione che insiste sulle strisce stradali, ombre che sfidano le leggi della fisica, panchine sospese senza gambe) sono paradossi di un contesto in cui il corpo conosce se stesso dal di fuori, come una cosa tra le altre cose, unico sospeso oggetto di un intelletto ondivago, entità di pixel che sorridono a Schopenhauer, confermandone la presenza nel mondo postcibernetico. Il corpo dunque in uno spazio che lo agita e lo rende perturbante.
È il contesto a dare una lezione narrativa alla rappresentazione dell’artista: è solo nel rapporto tra oggetti e soggetti, tra paesaggi che citano paesaggi con lezioni cromatiche del postimpressionismo, di Gauguin, di Puvis de Chavannes, ed ognuno può allenare la retina nell’agnizione del noumeno che nasconde un immaginario apparentemente consolatorio. Che potrebbe stare in un cafè alla moda, celando il proprio perturbante per l’occhio scaltro e viziato.
E in un Internet cafè si celano ad esempio le bottiglie di Morandi: che così diventano popolari e non metafisiche. Una specie di sinestesia ci obbliga a recuperare quell’odore rancido e condiviso di questi luoghi
12
in cui non c’è relazione, se non con oggetti corrosi e in un altrove che nessuno sa veramente toccare. Tra una improbabile conoscenza deduttiva e paradigmatica, per usare la terminologia di Jerome Bruner, e quella narrativa, Sughi ha scelto la seconda. Nella strutturazione delle sequenze concentrate, che possono insistere su un’unica esperienza concentrata, il meccanismo protoermetico del rapporto cogente tra titolo e opera (vera negazione dell’onnivoro Untitled) è sicuramente una delle tecniche più presenti: ad esempio in #814 Ahhhhhhhh!
È vero che la narrativa ha bisogno di sequenza, di mettere le cose in un ordine, anche quando segnala il disordine del reale: ne Lo straniero di Camus l’uccisione del giovane algerino, evidentemente senza legami razionali e logici con gli antefatti, e che rimane tale fino alla fine, costituisce il centro narrativo del romanzo. In quest’ordine i fatti ci dicono che non c’è ordine e casualità nel caos del mondo. E questa è narrativa. La pittura non prevede questo, ed è un fatto. Ma la numerazione volontaria dei quadri costituisce una sequenza ordinata di un corpus di fenomeni che assumono una facies narrativa.
Il vero detective non potrà che allenare la retina, restituire al paradosso il suo nome, è la tartaruga la più veloce. Ad ogni istante corrisponde un preciso indizio.
True Detective / Across the Line
Catalog "Across the line", artist Nerosunero (Mario Sughi)
Published by GIUDA edizioni, 2014

“I think human consciousness, is a tragic misstep in evolution. We became too self-aware, nature
created an aspect of nature separate from itself, we are creatures that should not exist by natural law.”
Rustin Cohle in True Detective, The Long Bright Dark,
Season 1, Episode 1
Crossing the line between what appears and what is – this is one of the most burning narrative nubs of the multi-award-winning True Detective, the most highly acclaimed TV series of recent years. It elicits a curious reaction from a public that appears to cultivate self-referential certainties and that is accustomed to prejudice, never having been taught to experiment or to seek out sources. And yet a public that has been powerfully attracted to this blend of artistic photography, Nietzschean dialogues and sequence shots as long as those of Soviet times. Here too, in this contradictory cycle, we find the burden of our inability to accept the contemporary. We live in the information age, stunned and misinformed. Sweetened and spiked by a facebook scroll page. Pizzolatto, the writer who created the HBO series, looked out over the landscape of Louisiana, the frontier land which is also his own and where time really does appear in different dimensions, and decided to turn it into a narrative metaphor.
It is not so much a background, where complex events are played
7
out in different times, as a real space that inspires the story. It is its constant allusion, its misshapen mirror. A place that contradicts the obviousness of the reality portrayed by background chatter. It is “the truth is out there” of X Files, but without the aliens.
Nerosunero (aka Mario Sughi) does not live in Louisiana, but he appears to emerge from the same need to remove the veil from the Maja of the landscape and of the setting. Starting with his technique, which, without leave of appeal, banishes the material potential of the graven original. If reality is representation and a dream-world musing presence, the sacredness of the fetish has no reason to exist outside of its own intangible sense. His apparent painting plays on our perceptions, commandeering our astonishment (who’d have thought what a computer can do, as if it had a mind of its own, a disabled intelligence that we bring to life), just as it plays on hysterical disbelief (Oh my god! Really? Digital painting from portraits?). Ever since the 1960s, art brought this process into the mainstream, provoking cries from the doomsayers, and yet still today, in the universally accepted perception, it still manages to provoke the same reactions as it did in Beuys’s day.
Deforming details (a lamppost standing on a zebra crossing, shadows that defy the laws of physics, legless benches suspended in the air), these are the paradoxes of a context in which the body sees itself from outside of itself. It is just one thing among many, the only suspended object of a vague intellect, an entity made of pixels smiling at Schopenhauer, confirming his presence in a post-cybernetic world. The body, therefore, caught in a space that agitates it and makes it disconcerting.
It is the context that teaches the artist’s representation its narrative lesson, but it is only in the relationship between subject and object, and between landscapes that quote others that have learnt the lessons of colour from Puvis de Chavannes, from post-impressionism and Gauguin. We can all train our retina to recognise an apparently consolatory world of the imagination in what we contemplate. It might be in some trendy café, concealing its own uncanniness for the shrewd, pampered eye.
Morandi’s bottles may for example be concealed in some Internet
8
café, thus becoming popular rather than metaphysical. A kind of synaesthesia takes us back to the rancid smell shared in places devoid of relationships, other than with corroded objects, in an elsewhere that nobody really knows how to reach. In a choice between narrative knowledge and some improbable deductive, paradigmatic form of understanding, as Jerome Bruner would put it, Sughi chooses the former. In structuring concentrated sequences that focus on a single concentrated experience, the proto-hermetic mechanism that inevitably binds title to work (an authentic negation of the omnivorous Untitled) is undoubtedly one of these techniques, as we see, for example, in #814 Ahhhhhhhh!
It is true that narrative needs a sequence, necessarily putting things in order, even when pointing to the disorder of reality: the killing of the young Algerian in Camus’ The Stranger, clearly with no rational or logical link to what has gone before, and remaining this way until the end, is the narrative heart of the novel. The facts in this order show that there is no order and coincidence in the chaos of the world. For this is narrative. Painting does not contemplate this, and that is one thing. But the intentional numbering of the paintings gives an ordered sequence to a corpus of phenomena that acquire a narrative aspect.
The true detective can but train the retina and give paradox back its name, for it is the fastest tortoise. To each instant corresponds a precise clue.
Lo sguardo di Alessandra Dragoni

Lo sguardo di Alessandra Dragoni
La fotografa fondatrice di My Camera si racconta
di Elettra Stambouls
È minuta, sorridente e sbarazzina Alessandra Dragoni: è figlia del nomadismo dello sguardo e la sua costruzione biografica nasce dalla casualità suadente del destino. Da Ravenna al mondo e ritorno, cura l'unica galleria di fotografia della provincia e una delle poche in Regione. Si chiama con grande riservatezza e umiltà My Camera, come a dire, c'è la fotografia (in inglese), ma è anche la mia stanza.
Sei nata e cresciuta a Ravenna e quindi anche gli studi li hai fatti qui?
«Sì, sono romagnola, e ho studiato alle mitiche Magistrali sperimentali a indirizzo linguistico. Devo dire che quello fu il contesto in cui scoprii che c’era un mondo là fuori, grazie Maria
Teresa Rossi, docente che andrebbe ricordata a Ravenna. Lei mi ha molto capita, ispirata e appassionata alla conoscenza. Invitò a scuola Carmelo Bene, il Living Theatre...»
E poi partisti...
«Sì, all’inizio a Lingue a Cà Foscari, un percorso che non conclusi. L'Università mi stava stretta, così partii con un’amica per l’Olanda. Erano gli anni ’80. E lì mi sono fermata. Primo lavoro
in pizzeria: proprietario israeliano, pizzaiolo marocchino, cameriera canadese, lavapiatti egiziano...»
E tu...
«Io che mi guardavo intorno, imparavo la lingua, e mi incuriosivo di fotografia, che mio padre praticava amatorialmente. Andai tramite un amico, convinto che fossi sprecata come cameriera,
all'agenzia Abc press, fondata negli anni Cinquanta da un giornalista ungherese amico di Robert Capa... un’agenzia importante, che forniva i principali quotidiani e riviste olandesi. All'inizio
feci lavoro di archivio, poi mi iscrissi a una scuola di fotografia. Era un periodo fecondo, di grande attenzione per le arti visive: in ogni quartiere c'erano camere oscure disponibili».
È stato quindi l’ambiente, il contesto che ti ha formato...
«E poi il mio percorso è stato all'inverso: ho imparato la fotografia facendo e guardando, lavorando per la stampa. Quando sono tornata a Ravenna, molti anni dopo, mi sono iscritta all'Accademia
al corso di Fotografia di Guido Guidi».
Com'era lavorare in una piccola e prestigiosa agenzia ?
«Sai, pensavano che lavorare 7 giorni su 7 non fosse utile per la creatività. Per cui si lavorava 4 giorni alla settimana, per avere il tempo di nutrirsi, ma il destino mi riportò in Italia...»
Ovviamente Milano...
«Sì, avevo conosciuto tramite la titolare di Abc, Grazia Neri che mi prese con sé. Furono due anni estenuanti, si lavorava a ritmi incessanti, così partii nuovamente, destinazione Parigi. Andai a
Liberation, non pagata, con uno stage».
Hai investito sul tuo sguardo...
«Avevo bisogno di acuire lo sguardo: c’era Christian Caujoulle, ma la mia intenzione era crescere ancora, così scrissi una specie di lettera d'amore alla Magnum... E mi presero a lavorare come
tuttofare, gratis naturellement, ma fu strepitoso esplorarne gli archivi, conoscere personalmente Cartier Bresson e non solo. Alla fine rimasi con loro più a lungo dello stage concordato, come
assistente di Diane Dufour (attuale direttrice di Le Bal a Parigi), ottenendo vitto e alloggio. Vidi abbastanza e tornai a Milano più forte...

Così cominciò la tua carriera da freelance...
«Sì, avevo quasi trent'anni ed ero cresciuta, ci fu anche l'intermezzo di Fabrica, la collaborazione con Adam Broomberg. Un'esperienza entusiasmante e molto diversa da quello che diventò poco dopo lo spazio di sperimentazione di Benetton. Tornata a Milano fui chiamata da Marie Claire per collaborare come fotografa e photo editor. Guadagnavo molto bene, ero immersa nelle fotografie, ma soprattutto potevo salvaguardare il mio modo di vedere. Ero riuscita a raggiungere un'aura che mi permetteva di non cedere alle richieste, a volte frenanti, delle riviste.
Alla fine però sei tornata quando è nato tuo figlio, come se ci fosse il richiamo delle sirene della nascita dei figli, non sei la prima a fare questa scelta...
«È vero, è stato per me un momento in cui avevo bisogno di tempo per me e lui. Non me la sono sentita di lasciarlo, così piccolo, anche per poco, per lavoro. E il risultato fu che il
rapporto con Milano piano piano si è affievolito. È un mondo in cui ci devi essere, sempre. A Ravenna ho sperimentato un altro modo di affrontare la Fotografia, in Accademia. Però certo a livello
lavorativo non è stato semplice. Mantengo questo spazio da sola, per avere un polmone in cui poter fare e far vedere quello che so e che mi piace. Ho collaborato con varie realtà, come ad esempio
Cantieri con cui ho scattato i ritratti dei bambini e ragazzi della città al party in terza o per Nutrimenti. Un lavoro che mi ha molto appassionato. La fotografia di moda invece è quella che mi
“garantisce” entrate sufficienti a coprire le spese della galleria. Poi ci sono progetti di libri e di ricerca».
Tra archivio, visivo, documentazione, poetica come la mettiamo con la fotografia? Oggi gli archivi si volatilizzano, ma tutti lavorano sugli archivi, sulla mappatura. Che cosa proporresti
tu a questa città su questo tema?
«La fotografia è documento, in questa cosa Guidi è un maestro. Ma ci sono altre strade, come la ricerca dalle sfere più personali, magari amatoriali ma autentiche. È un po' questo il mio campo
d'attenzione al momento. La mia idea su questa città è un mix delle due cose. Ravenna sorge sulla base dei quartieri, che erano una sorta di realtà “indipendenti” (Nullo Baldini, Villaggio Anic,
San Biagio, Gulli etc). A me piacerebbe chiedere la collaborazione dei cittadini per creare un archivio visivo dell'esperienza dei quartieri, degli spazi, ma anche del privato, negli anni
'50, '60 e '70. Vorrei che chi ne ha voglia attingesse al proprio archivio personale. Erano gli anni del boom, quando ci si trasferì dalla campagna e si creò realmente questa città. Sarebbe
un po' come far uscire questa idea di città, questa vita sedimentata in scatti, e ridarla alla luce. Mettere insieme esperienza personale e pubblica, documento e privato, per capire e conoscerci
meglio».
Workshop con Marcos Morau

Dal 20 al 22 giugno 2014, a Ravenna, Associazione Culturale Mirada organizza, in collaborazione con Associazione Cantieri, un workshop condotto dal coreografo Marcos Morau, grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna. Al workshop prenderanno parte dieci artisti visivi selezionati dall’archivio giovani artisti e dieci coreografi e danzautori emergenti emiliano romagnoli.
Si tratta di un importante momento di formazione e confronto per gli artisti del nostro territorio con un regista che costituisce un unicum in Europa e che è stato presentato con grande attenzione di critica e pubblico alla Biennale di Venezia e a Roma Europa Festival la scorsa estate.

L’intento è di vivisezionare la poetica del coreografo spagnolo, la sua particolare indagine che parte spesso da un’opera visuale (come nel caso di Siena) verbalizzandola e trasferendola ad un livello coreografico. Le traiettorie emotive che sono tracciate nello spazio interrogano lo spettatore e “sottolineano il potere dello sguardo”. L’ipotesi di lavoro è di creare un gruppo ibrido di artisti pronto a lavorare e produrre superando i vecchi schemi concettuali delle arti per categorie, un progetto pedagogico e relazionale insieme.
L’assessore Mezzetti della Regione Emilia Romagna sottolinea con queste parole l’importanza dell’iniziativa: “Voglio inviare agli organizzatori, ai membri dell’Associazione e ai partecipanti i migliori auguri dell’assessorato regionale alla Cultura per questa importante iniziativa.
Al di là dell’alto valore intrinseco allo stesso workshop, mi preme sottolineare come il progetto si collochi in un settore, quello della creatività e dell’innovazione che ha profonde radici nella tradizione, in sintonia con le nostre politiche culturali e nello stesso spirito che anima la sfida per Ravenna 2019”. Aggiunge Valentina Morigi, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna: “Ancora una volta Associazione Culturale Mirada e Associazione Cantieri mettono a disposizione della nostra città un’opportunità di crescita e formazione di altissimo profilo artistico, nel segno della sperimentazione, della creatività e dell’innovazione. Un’occasione da non perdere !”

Marcos Morau è direttore artistico e regista della compagnia La Veronal, da lui fondata nel 2005 con l’obiettivo di creare un spazio artistico globale che utilizzi tutti i codici della contemporaneità. A tale scopo per la sua compagnia ha creato un team artistico formato da artisti provenienti non solo dal mondo della danza, ma anche dalla cinematografia, dalla fotografia e dalla letteratura . Da anni La Veronal crea un decalogo in cui ogni punto di partenza è dato da un paese o una città del mondo, col preciso intento di instaurare una profonda analogia tra danza e geografia. I vari “pezzi” non vogliono diventare dei lavori documentari che descrivano il paese in presa diretta, ma utilizzano gli elementi forniti dal luogo per compiere, attraverso il percorso artistico e lo scambio con gli artisti locali, lo sviluppo di un concetto, il punto di vista su una questione ritrovata. Questo immaginario ha portato la compagnia a differenziarsi nel contesto artistico internazionale come una voce a sé stante, una voce forte e originale che ha assicurato a Morau il merito di importanti riconoscimenti nazionali e non, come il Premio Sebastian Gasch assegnatogli nel 2013 dalla FAD Foundation.
Ravenna, Cantine di Palazzo Rava 20, 21, 22 giugno 2014 Incontro pubblico / conferenza stampa venerdì 20 giugno ore 11 c/o Associazione Mirada via Mazzini 83
Per maggiori informazioni
Associazione culturale Mirada, via Mazzini 83, 48121 Ravenna Telefono 0544217359 email info@mirada.it
Un progetto ideato da Elettra Stamboulis
Curatrice coordinamento Sabina Ghinassi
Realizzato da Associazione Mirada e Cantieri
Grazie al contributo di Regione Emilia Romagna
Per info: Associazione Mirada, Via Mazzini 83 Ravenna Tel +39 0544 217359 info@mirada.it | www.mirada.it
Marco Antonini, un eclettico che ha fatto strada nella Grande Mela

Marco Antonini, un eclettico che ha fatto strada nella Grande Mela
di Elettra Stamboulis
Marco Antonini fa parte di quella magmatica generazione di laureati in Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna: ancora oggi è difficile incasellarlo in una categoria precisa. Di origini pescaresi, ha mosso i primi passi da artista (vincendo il concorso Ram come fotografo) e curatore (collaborando ad esempio con la galleria Ninapì) nella nostra città, per poi migrare come molti all'estero.
La Grande Mela l'ha accolto e, se non coccolato (che la metropoli è madre matrigna), sicuramente valorizzato. Oggi è il direttore responsabile della galleria NURTUREart, specializzata nella selezione di giovani talenti e progetti collettivi. Ha vinto numerosi riconoscimenti tra cui anche il fatto di essere finalista al premio Andy Warhol Foundation Art Writers
Che cosa significa oggi curare una mostra a New York? Tu hai una personalità poliedrica, artista curatore poeta. Come coniughi queste diverse attitudini?
«Significa quello che significa ovunque nel mondo, solo in un contesto estremamente competitivo, in cui l’attenzione per l’arte contemporanea e il livello di alfabetizzazione in termini di
cultura visiva e storia dell’arte contemporanea sono molto, molto alti. Qui a NY il pubblico è al contempo presente, nel senso che è attentissimo a ciò che viene proposto, e assente, cioè meno
disposto ad approfondire e discutere, poiché la sua attenzione è catturata da tantissimi eventi, tematiche e informazioni concomitanti. C’è un grande valore, ma anche un limite in tutto questo.
Personalmente uso NY come una base strategica. Qui è facile incontrare persone e idee in transito. La convenienza strategica dello “stare” a NY in attesa di vedere il mondo passare dalla porta
(che in effetti succede, e spesso…) è, paradossalmente, quella di sentirsi un po’ tagliati fuori, di non essere noi stessi a partecipare in prima persona a quel che succede, e che a NY viene
recepito, discusso e rappresentato. Io ero artista visivo, sono poeta e scrittore della domenica, gioco ancora con la macchinetta fotografica (una vecchia Pentax ME Super), e curo il design e la
produzione delle nostre pubblicazioni a NURTUREart spesso anche di quelle prodotte dalle istituzioni con cui lavoro come curatore indipendente. Prima ancora mi sono ritrovato ad essere musicista,
pseudo-produttore, fanzinaro, DJ… un sacco di roba; un approccio “totale” al lavoro che spesso non viene capito e/o accettato. Mi va bene così perché per natura non sono una persona che ama
specializzarsi. Mi sono sempre sentito più libero come eclettico, anche se in alcuni aspetti del mio lavoro mi sento più “esperto” di altri. Forse il periodo precedente avrebbe più senso
sostituendo la parola “lavoro” con la parola “vita,” perché alla fine vivere a modo mio è praticamente quello che faccio per vivere. Anche per questo ho deciso di intitolare la mia pagina web
“Sempre Meglio che Lavorare”. Lavorare stanca».
Da Ravenna alla Grande Mela. Già dirlo fa sorridere... Come è stato l'impatto iniziale? Cosa ti sei portato dietro e cosa hai dovuto abbandonare?
«Mi dispiace molto che una frase come “Da Ravenna alla Grande Mela” faccia sorridere. L’impatto iniziale non riesco più a ricordarlo bene. Rileggo degli articoletti che scrivevo appena arrivato a
NY e mi suonano disperatamente naif, ma anche onesti. Dietro mi sono portato, e ancora mi porto, una grande nostalgia per le persone, le cose, le situazioni vissute durante i miei anni in Italia,
soprattutto una nostalgia per la gente di Ravenna e per i miei amici che ancora vivono li. Non ho ancora trovato un modo di riconciliare il mio presente e il mio passato in un futuro che posa
contenerli entrambi, accogliendo le varie personalità che, di esperienza in esperienza, sono venute ad esistere in me».
Il tuo sguardo adesso è diventato largo: che cosa vedi del mondo dell'arte italiano? Consiglieresti a un giovane artista di prendere l'aereo e attraversare l'Oceano?
«Non conosco molto il mondo dell’arte italiano. Spesso incontro persone fantastiche, ma il fatto che le incontri puntualmente a NY o altrove in giro per il mondo parla da se. Partire è sempre
utile e importante. Non mi sento di poter dare consigli, io qui ho fatto tantissimi errori. Se decidete di fare un salto in qua, leggete America di Baudrillard prima della partenza:
aiuta».
Torniamo ancora alla formazione. Al tuo periodo universitario a Ravenna: che bilancio fai di questa tua scelta? Se potessi cambiare qualcosa che cosa?
«Ravenna è stata una città importante per me, ancor di più la gente di Ravenna: quel loro misto di pragmatismo e rilassatezza che ho sempre sentito così vicino. Conservazione dei Beni Culturali
era o, se esiste ancora, suppongo ancora sia un progetto malriuscito, con professori eccellenti e cialtroni seduti allo stesso banco, infrastrutture insufficienti, programmi e metodi didattici
antidiluviani, la storia dell’arte contemporanea studiata su libri scritti con una mano sola dai soliti noti della critica Italiana. Mi viene da ridere al solo ripensarci. D’altro canto è stato
bello poter studiare con dei veri esperti della storia dell’arte medievale (settore in cui, pur volendo occuparmi di arte contemporanea, mi specializzai, scegliendo in base alla qualità degli
insegnanti… un’idea di cui non mi sono mai pentito) e immerso nel museo a cielo aperto di Ravenna. Un errore madornale che ho fatto durante i miei anni di università è stato quello di non
viaggiare abbastanza e forse anche di non aver saputo esplorare e capire la scena artistica e culturale di città relativamente “vicine” come Torino e Milano… persino Bologna, dove pure andavamo
spesso. In quelle città, gli anni novanta sono stati un periodo fantastico. A Ravenna si restava spesso intrappolati nel localismo, incapaci di guardare al di fuori se non per emulare, senza le
basi culturali per rielaborare gli stimoli che ci arrivavano dall’esterno, per immaginare “in grande,” per pensare rivolti al futuro. Quel tipo di ambizione si vedeva nella scena del teatro
sperimentale e nel lavoro dei pochi musicisti, artisti e operatori culturali locali che davvero ci credevano; qualcuno è emerso, qualcuno no, qualcuno ha lasciato perdere e qualcun’ altro alla
fine è andato via».
Inganni gentili e delicatezze brutali

La siciliana Giambrone protagonista al Mar
di Elettra Stamboulis
Inaugura sabato 14 dicembre alle 18 al Museo d'Arte della Città di via di Roma 13 "Critica in Arte 2013", Silvia Giambrone uno dei tre artisti protagonisti, insieme a Francesca Pasquali e Eron. Parliamo con lei della sua arte e dell'esposizione ravennate.
Silvia Giambrone (Agrigento, 1981) è una artista poliedrica che utilizza scultura, fotografia, istallazione, ma soprattutto il corpo, come arma intensa e inalienabile della nostra presenza nel mondo. E del suo corpo appaiono questi capelli alla Tiziano, rossi e impertinenti, per una siciliana come Silvia. Sarà una delle protagoniste delle mostre personali di Critica in arte 2013 al Mar (fino al 12 gennaio), ma soprattutto è una delle protagoniste emergenti dell’arte contemporanea italiana che non cede all’effetto show, ma richiede tempo, attenzione e dedizione.
Una parole che risuona in diverse interviste è “intensità”: è questa la cifra che vedremo nella mostra di Ravenna?
«Credo che l'intensità fosse proprio uno degli aspetti che Silvia Cirelli, la curatrice della mostra che mi ha invitata al Mar, volesse evidenziare per Critica in Arte, e credo altresì che questa
sia la ragione per cui abbiamo lavorato insieme in grande armonia. Ricercare l'intensità è qualcosa che che ti chiede di non adagiarti su quanto hai già vissuto, ti mette nella posizione di
guardare qualcosa sempre come fosse la prima. È necessaria una certa partecipazione, ma anche una certa alienazione».
La tua poetica è spesso pervasa di poesia, di un discorso poetico che scorre nelle vene di quello che mostri, anche di te che ti mostri. Che rapporto hai con la parola scritta e
letta?
«Credo che la poesia sia un’arma potentissima perché è l’unica forma di resistenza che si può opporre e coltivare contro la pervasività della realtà, qualunque aspetto essa incarni… A dispetto di
quanto si possa pensare, non c'è resistenza al potere che non passi per una resistenza interiore. Lasciare uno spazio per il tentativo sempre fallimentare e sempre ricercato del dire l'ineffabile
è tutto ciò che abbiamo per non cedere alla tentazione di contrattare tutto, per salvare quello che Borges chiamerebbe “il centro del cuore che non consiste in parole, non si baratta coi sogni e
che tempo, gioia, avversità lasciano intatto”».
“Non voglio vivere nell'ostilità” oppure “L'ambizione è rimanere alla pari” sono tue dichiarazioni di tipo politico alto. E nei tuoi lavori,
in cui tu cerchi continuamente una relazione, spesso emotivamente importante, con lo spettatore chi vince, chi perde?
«Perde chi credeva di vincere e vince chi credeva di perdere. Un inganno gentile e una delicatezza brutale rinegoziano ostinatamente il senso della verità dell’udito di chi parla e della voce di
chi ascolta».
Ti sei formata all’Accademia di Belle Arti di Roma: che cosa ti porti ancora appresso dell’esperienza formativa e cosa invece hai abbandonato?
«Mi porto dietro qualche buon amico scovato tra i rumorosi miti di fondo che disanimano l’accademia, e la
consapevolezza che nessuno ti insegna a essere un’artista. Tutt'al più puoi trovare, se sei fortunato, qualche professore illuminato che intuisce come tirare fuori da te quello che hai già
dentro. Mi porto anche molte occasioni mancate e qualche amarezza, perché troppo è quello che si potrebbe fare nelle accademie e che per sciocche ragioni non si fa».
Sei stata una delle artiste di due mostre collettive (Autoritratti. Iscrizioni del femminile nell'arte italiana contemporanea al MAMbo di Bologna. e NOW! Giovani artiste italiane all'Ex
Refettorio del Complesso San Paolo diFerrara) entrambe nella nostra Regione ed entrambe centrate sul fare femminile artistico. La tua vocazione femminista, il tuo dialogare con il pensiero di
Carla Lonzi ad esempio, e il tuo mettere in discussione il concetto di femminile nell'arte...
«L’incontro con il lavoro di Carla Lonzi è stato essenziale per me ed è arrivato un po’ come arriva l'amore: ti pare che arrivi sempre troppo tardi e che sempre se ne vada troppo presto.
Riconosco in Carla Lonzi un'interlocutrice molto importante, forse perché la più radicale, perché lei ti mette spalle al muro, ti manda alle corde, ma il muro è l’evidenza di un confine da cui
partire e le corde sono un elastico per rientrare sul ring. Io, da quanto studiato sui suoi testi, ho tratto l'opportunità di pensare la fragilità e la differenza come punti di forza. Fatico
sempre a parlare di “femminile”, forse rispetto al genere sono molto più vicina alle posizioni di Judith Butler che a quelle di Lonzi, ad ogni modo l’eredità femminista che rivendico è quella
della pratica di riflessione ed azione sui rapporti di potere più sotterranei, che contribuiscono a formare un soggetto (sia maschile che femminile) e che innervano tutte le relazioni, da quelle
più apparentemente semplici a quelle più articolate e complesse
“I capelli rossi ce li avevo solo io”: questo essere individuabile, riconoscibile viene da te a volte sentito come un limite, eppure anche un'opportunità di assumersi una
responsabilità...
«La differenza dall'altro ognuno la scopre a proprio modo ed è sempre una scoperta molto delicata. Quando la scopri con leggerezza e serenità hai qualche possibilità in più di coltivare ciò che
in te è autentico, quando la scopri con disagio invece corri il rischio di ospitare per sempre un ingombro e di divenire il riflesso dell'idea di altri. Credo che la responsabilità della
propria differenza sia un percorso che ha forse un'origine, ma non una fine. Che sia una pratica costante e che richieda alla “social catena” tanto amore da dare e tanto da ricevere. Detto ciò,
non vedo l'ora di andare prima o poi a quel raduno itinerante, che ho scoperto esistere solo recentemente, di sole persone con i capelli rossi e sapere finalmente com'è essere, almeno sotto
il profilo melaninico, uguale a tutti gli altri».
Valerio Adami e la verità del momento metafisico

Ha uno sguardo indagatore e curioso, e impone subito un cambio di ruoli prima dell'intervista: prende di contropiede e chiede «l’arte è per lei dovere?».
Valerio Adami è il pittore più pop della sua generazione: nato nel '35, ha attraversato la recente storia dell’arte, imprimendo un segno con un timbro inconfondibile, netto,
resistente alla catalogazione in corrente o a un gruppo. In mostra al Mar di Ravenna (fino all'8 dicembre) è possibile vedere una sintetica presentazione di un processo artistico che abbraccia
con dedizione un arco di tempo che va dalla fine degli '50 ad oggi. Un paesaggio figurativo rigoroso, sobrio, puntuale e intenso, come lo sguardo di questo artista che ancora ha molti progetti
nel cassetto del futuro. Grande viaggiatore, stimolato alla curiosità per gli spazi altri soprattutto dalla moglie Camilla, anch’ella pittrice di talento, vive soprattutto a Parigi, città che per
prima gli ha dedicato un’ampia personale pubblica.
La sua è una biografia di un artista affermato e che è riuscito già in gioventù ad ottenere riconoscimenti ed attenzione. È replicabile una simile biografia oggi?
«All’epoca tutto era limitato a pochi attori. C’erano due gallerie a Milano e tre a Parigi. Oggi siamo di fronte a un paesaggio diverso, la stessa espressione artistica si ê differenziata. Ci
sono pittori che dipingono, ma ci sono molti che trovano forme espressive diverse dalla tradizione di questo linguaggio. Il possesso del pensiero dell’arte stesso si è ampliato. Ho come
l’impressione che ci sia più interesse, ma con minore intensità. Se un giovane ragazzo di buona famiglia comunica alla famiglia che vuole diventare artista, i genitori possono essere quasi
contenti. Quando ero giovane, l’iscrizione all'Accademia era un atto riprovevole».
Come reagirono i suoi genitori alla sua iscrizione all’Accademia di Brera?
«Lo tenni segreto per due anni, dicendo che avevo scelto Architettura. Poi non fui rimproverato, ma mi autocensurai. Quando lo seppero non furono irati, ma io temevo».
Si legge spesso che la sua arte è la più vicina alla Pop Art americana di Lichtenstein. E che la sua sarebbe una raffigurazione che parte dal fumetto, anche se di fatto non c'è traccia
dei miti delle culture mainstream o pop nella sua figurazione...
«In effetti non sono mai stato un lettore di fumetto, non ne so nulla. Probabilmente quello che ha creato l’equivoco è l’utilizzo della linea chiusa. Con l’arte sequenziale però non ho mai avuto
rapporti diretti, se non con MAD, la rivista satirica statunitense, che mi incuriosì quando la incontrai, perché erano artisti che si esprimevano con stile evidente, così per un periodo ne
collezionai i numeri».
Lei è stato amico di Tabucchi, che ha scritto del suo disegno in Racconto con figure, definendo lo racconto del mondo.
«Non credo che la pittura possa raccontare. La verità sta nel momento metafisico, c'è sicuramente un racconto inconscio, di ciò che abbiamo vissuto, ma non un vero e proprio racconto. Il mio è
piuttosto un lavoro sulla forma, sullo spazio».
Per riprendere Tabucchi, una “geometria del reale”: che ruolo ha dunque lo stato d’animo, la partecipazione dello spettatore?
«Ci sono forme di pittura come l’Action Painting o il tachisme in cui l’opera si crea come deposito di uno stato emotivo. Nel mio lavoro la forma può provocare uno stato d’animo, non lo escludo,
ma non parte da questo. Non è nelle mie corde dare forma a un vissuto tragico o al dolore, alla malinconia piuttosto».
Il suo è un percorso costellato da un'intensa frequentazione con il mondo artistico e intellettuale nel senso più ampio del termine, come ad esempio con Derrida con cui ha promosso dei
particolari seminari a Meina sul lago Maggiore...
«Negli ultimi venti anni ho tenuto questi seminari in cui il contributo di Derrida era straordinario. Dopo la sua morte si sono rallentati, perché l’assenza era rilevante. C’era una convivialità,
uno stare insieme che si esprimeva nel pensiero perennemente acceso, su un tema scelto in anticipo. Per quattro giorni si discuteva in un gruppo di invitati, devo dire perlopiù francese, solo
però per ragioni linguistiche. Ora sto pensando di ripartire con l'esperienza...»
In occasione della mostra di Ravenna ha realizzato anche dei mosaici in collaborazione con giovani artisti musivi di Ravenna.
«Sono felice di questa esperienza, anche se non sono contento di me stesso, mi piacerebbe essere coinvolto nel pensiero musivo maggiormente, ma non ho avuto tempo finora di approfondire questo
linguaggio. Diversamente dalla tecnica delle vetrate, nella quale sono entrato completamente, sono diventato esperto, il mosaico ha bisogno per me di un lavoro in tandem. Forse in futuro».
Paesaggi sognati in “time lapse“
Dietro l'obiettivo di Laura Liverani di Elettra Stamboulis

In mostra fino al 7 novembre alla galleria fotografica Interzone di Roma, Laura Liverani vive tra Faenza e Tokyo. Laureatasi al Dams, non ha mai smesso di osservare, guardare, provare a
fermare il tempo e il luogo. Dopo un master di fotografia a Londra, l'Asia è diventata la sua seconda casa. Un luogo che ha rappresentato sia in istantanee crudeli e veritiere, che in poetiche
interpretazioni come queste della mostra romana, realizzate con la particolare tecnica stenopeica. Docente da diversi anni all'Isia, è una sorta di occhio italiano sui misteri delle tigri
asiatiche.
Dunque ... Raccontami un po' della tua vita, sei nata a Ravenna e poi?
«Sono nata a Ravenna, ma sono cresciuta nella provincia lombarda, dove i miei si erano trasferiti per lavoro. In ogni caso ho sempre mantenuto un legame forte con Ravenna, dove tornavo ogni anno
con la famiglia durante le vacanze estive, e dove torno tuttora spesso. Da due anni son tornata “romagnola“ perché ora vivo a Faenza, dove insegno fotografia all'Isia. Anche se in Italia non
passo che pochi mesi l'anno».
Come sei arrivata nella lontana Asia?
«La prima volta che sono stata in Asia vivevo ancora a Londra nel 2000. Sono partita per Hong Kong, con l'idea di fare un viaggio in treno fino a Pechino ed esplorare la scena musicale
underground, che allora era molto interessante. Ho cominciato a fotografare i quartieri popolari di Hong Kong e a lavorare ad alcuni servizi fotogiornalistici sulla Cina Popolare poi venduti alla
stampa italiana; tornavo in Cina ogni anno. Sono stata in Giappone nella prima volta nel 2007, venendo da Shanghai. Con Tokyo è stato amore a prima vista e da qualche tempo vi passo dai tre ai
sei mesi l'anno».
Sei fotografa: come lavori, con quali tempi, con quali modalità ... Soprattutto nel mondo dell'arte o dell'informazione?
«Il mio lavoro ed approccio alla fotografia è cambiato nel tempo. Quando ho cominciato ero più attiva nel mondo dell'informazione, con servizi editoriali di viaggio e cultura per riviste in
Italia e in Asia. Fotografavo e scrivevo. Quando sono tornata in Italia da Londra, alle fine del 2000, dove ho studiato fotografia e vissuto per quattro anni, ho cominciato ad insegnare
parallelamente alla mia attività di fotografa freelance. Anche oggi più o meno la situazione è questa: insegno fotografia all'Isia di Faenza, e porto avanti progetti personali e commissioni. Sto
perdendo graduale interesse nella fotografia editoriale e di informazione (pagata cifre ridicole oggi, con poche eccezioni), a favore della ricerca personale, comunque sempre legata al linguaggio
della fotografia documentaria. Le commissioni a cui lavoro sono tra le più varie: libri, moda, cataloghi, soprattutto in Giappone. In Italia lavoro pochissimo, e ci passo sempre meno tempo».
Hai studiato a Bologna: che cosa ricordi di quella esperienza? Come l'ha i trasferita nella tua esperienza di insegnamento?
«Della vita da studente a Bologna mi ricordo, oltre alle deprimenti case condivise in cui ho vissuto, la scintillante vita sociale: erano gli anno del Link, del primo TPO occupato, di Luther
Blissett e della piscogeografia. Facevo un programma di musica sperimentale rock e noise a radio Kappa, un'emittente autogestita, che era una scusa per andare a vedere gratis tutte le band
che suonavano in zona. Non avevo ancora cominciato a fotografare. Dopo la laurea mi sono trasferita a Londra per un master di fotografia, e la mia esperienza di insegnamento è sicuramente più
legata all'esperienza universitaria a Londra».
Domanda di rito... Fonti di ispirazione, fotografi che consideri maestri, vicini e lontani.
«I fotografi che amo cambiano nel tempo. I miei primi “amori“, sono stati Weegee e William Klein. Tra i contemporanei il primo nome che mi viene in mente è Taryn Simon. Mi piace moltissimo anche
la fotografia giapponese degli anni '60, e tra le nuove generazioni Lieko Shiega. Tra le fonti di ispirazione, dirette e indirette, anche il cinema di Hong Kong degli anni '70-80, e i deliranti
film giapponesi ero-guro, un nome su tutti: Ishii Teruo».
Cosa racconta una fotografia dell'odierno est? In Neon Dreams alla galleria Interzone di Roma esponi sia fotografie che immagini time lapse. Ci racconti la tecnica che
usi e le motivazioni di questa scelta?
«Non sono paesaggi reali, ma immaginati, sognati. La tecnica del foro stenopeico, applicata tanto alla pellicola quanto al supporto digitale, si presta perfettamente a questo, come ho scritto
nella mia introduzione. Usare la pinhole è come usare una macchina del tempo: dal qui-ed-ora si viene trasportati altrove».
Paesaggi distopici, luoghi in cui il qui ed ora scompare...è proprio questa l'esperienza di vita nelle metropoli dell'estremo?
«L'esperienza reale nelle metropoli asiatiche ovviamente non è rispecchiata dalle mie immagini, e soprattutto varia da città a città. Pechino, Hong Kong e Tokyo sono diversissime tra loro e
la loro percezione varia da persona a persona. La mia è una rilettura dei luoghi molto personale, filtrata dalle mie memorie, dal cinema e dalla letteratura. Detto questo, la mia prima
impressione di Pechino è stata realmente di una città aliena, da incubo, eppure affascinante. Guardavo fuori dalla finestra dell'hotel e vedevo una torre di acciaio spuntare dallo smog, come
sospesa nel vuoto, un'immagine bellissima. Tokyo invece è una città sorprendentemente tranquilla, dove giro in bici e faccio pic nic al parco con gli amici. Basta evitare la stazione di Shinjuku
all'ora di punta, dove l'essenza dell'incubo metropolitano si materializza»...
Occupy Museum, 99% Komikazen

It has been a year since then and now I can say it: the 2013 edition of Komikazen has been the best one. You’d better not take this catalogue because it will not be able to instil the energy of that collective action. It was not an exhibition, not even a project. It was a collective performative event carried out by 99 illustrators.
None of them knew what was going to be exhibited, except for their own table. Those who responded to our call knew a few simple things: they would neither have been refunded nor paid. They had to come to Ravenna – possibly stay there paying it all – and make a table based on the theme “99%”. Once at the MAR (Museum of Art of Ravenna), they had to install the table on their own following the instruction that you can read at page one. Of course, they had to draw.
Till the last second we did not know if all the respondents would have come, if it would have worked. What would have been the result of it? In this case, let me say, each creation – all 99 listed in here – is a small grain of sand in the eyes of those who do not want to see. They will not blind them; they will not change the mind of those who carelessly look at the increasing social, economic and even cultural gap between social classes. But a grain of sand in the eye is annoying for sure.
Many people reacted, also on a local political level. They have been touched personally or institutionally. This is what they call a guilty conscience. Some artists declined our invitation at the last minute, because “you never know”. Whether you point the finger and speak up or resist the silence maintained by most of the contemporary artist, you will neither be arrested nor tortured. You will not be the new Ai Wei Wei. Because we are human. But you will not take part to the feasts that count and let you pay the bills. You will receive fewer invitations; you will not be a welcome guest. Somebody may gabble: “It was nothing special”. That gabble can make you lose a mediocre contact. Sometimes it may happen. It happens. If the worker loses her/his job, which had a name – contract (at least most of times) – what if an illustrator, a singer, an actor or a writer loses her/his job? They do not even have a contract. They would not know how to make a living. That gabble, that finger, that being unwelcome do not lead anywhere.

It has been a year since then and now I can say it: the 2013 edition of Kamikazen has been the best one. You’d better not take this catalogue because it will not be able to instil the energy of that collective action. It was not an exhibition, not even a project. It was a collective performative event carried out by 99 illustrators.
None of them knew what was going to be exhibited, except for their own table. Those who responded to our call knew a few simple things: they would neither have been refunded nor paid. They had to come to Ravenna – possibly stay there paying it all – and make a table based on the theme “99%”. Once at the MAR (Museum of Art of Ravenna), they had to install the table on their own following the instruction that you can read at page one. Of course, they had to draw.
Till the last second we did not know if all the respondents would have come, if it would have worked. What would have been the result of it? In this case, let me say, each creation – all 99 listed in here – is a small grain of sand in the eyes of those who do not want to see. They will not blind them; they will not change the mind of those who carelessly look at the increasing social, economic and even cultural gap between social classes. But a grain of sand in the eye is annoying for sure.
Many people reacted, also on a local political level. They have been touched personally or institutionally. This is what they call a guilty conscience. Some artists declined our invitation at the last minute, because “you never know”. Whether you point the finger and speak up or resist the silence maintained by most of the contemporary artist, you will neither be arrested nor tortured. You will not be the new Ai Wei Wei. Because we are human. But you will not take part to the feasts that count and let you pay the bills. You will receive fewer invitations; you will not be a welcome guest. Somebody may gabble: “It was nothing special”. That gabble can make you lose a mediocre contact. Sometimes it may happen. It happens. If the worker loses her/his job, which had a name – contract (at least most of times) – what if an illustrator, a singer, an actor or a writer loses her/his job? They do not even have a contract. They would not know how to make a living. That gabble, that finger, that being unwelcome do not lead anywhere.
If you want art, buy it. It does not cost that much. The supporters of arts who do not have at least an artwork made by one of their friends are strange people. They are like the supporters of books who do not have a single book on their shelves, or like those who want to be playgoers without attending a play. Art is trade and none should be scared by that. Drawings can be bought.
Well, I am wasting time. I did not analyse, I did not summarize, I did not recall the right names. In fact, I did not want to, because this is a self-explanatory action, it does not need any annotation. You can see it in the video enclosed to the catalogue and recorded because – to be sincere – that is the artwork.
Each table is the interpretation of the same leitmotiv. You think you can make a fool of us, but we can see you. You’d better be afraid. The wave is coming.
“Banks robbed us and politicians drove the car to run away. Read Griftopia. Watch Inside Job”1: this is what they said in Zuccotti Park during one of the most important civil demonstration after the civil right march in the USA. Precisely there, right in the middle of the empire. If it was in Tunis, Cairo and Beirut, there would have been no problem. Even in Madrid or Athens – at the end of the day they are almost Africans. But they were American citizens in the Big Apple.
“Another art world is possible, one that’s more principled and ethical, and that looks out for the human and labour rights of all. Artists should not be asked to exhibit in museums that have been built on the back of abused workers … that’s what it boils down to. When you’re acquired by a museum that does that, that’s unfair. Your complicity is being bought along with the artwork.” That is what Gulf, one of the organizations that take part to the actions of occupymuseum.org, said. For example, consider one of the actions of occupymuseum.org: the projection of utterances such as “1% Museums means 1% Art”, “Art built on Oppression Loses Meaning”, “There are other possible Futures of Art” on the façade of the Guggenheim Museum. The actions of these groups of American artists aim to reveal the horrible work condition of those who are building the new Guggenheim Museum in Abu Dhabi. We should be concerned about it, because also in Italy those who work to produce and preserve the art world have become occasional workers.
Our intent was easier: we wanted to show the unsustainable work conditions of those who work in the fields of culture and art. It is no more about occasional work, but work for free. Even the Ministry offers free traineeships as if they were real jobs. Even if one makes it for passion, it does not mean that one should not make a living out of it. You can be a doctor, a luthier, a lawyer for passion, but no one can even think of not paying you for your work.
The social welfare system and the political mediation that was born from the social conflict in 60s-70s did not led to equality, but it caused a substantial redistribution of wealth that granted our parents the well-being that has not been recorded in any other age on such a large scale. Those who should act in our stead to claim more rights, to protect our lives and be our mediator is driving the car to run away, in fact. As a result, we can just move on, take out pens, pencils and microphones, and start again claiming more social equality and more chances for everybody.
(Oh! The thing that surprised me the most was that, at the end, all the artworks were multifaceted, rich, and different. There was no repetition, no standardized thinking. This means that – yes -- we are the 99%, but we all have different minds).
Nel due qualcuno si fa sempre male - Maria Ghetti
Pubblicato nel catalogo R.A.M. 2013, GIUDA edizioni, Ravenna

Nel due qualcuno si fa sempre male.
Il presente non è ciò che si è, ma ciò che si fa...
Noi non percepiamo, praticamente, che il passato dal momento che il puro presente è l’inafferrabile progresso del passato che erode il futuro1
Maria Ghetti opera come una ricercatrice sociale dello spazio, un’artefice che vuole rendere visibile l’invisibile, un’ape operaia nello spazio obsoleto. È una transumante della campagna. Poggia i piedi tra Torri di Mezzano e il Belgio. Si interroga sull’integrità del sé come farebbe un giovane Jung: la relazione tra l’Io e il sé, che può essere orizzonte e possibilità. L’orizzonte è una meta, non solo e non tanto fisica, e la possibilità nuota nella costante e incessante vorticosità del mutamento.
L’etica del flusso, che tanto ha influenzato il pensiero protonovecentesco e non solo, ricompare in nuove forme, si veste di altre rappresentazioni: la dematerializzazione del sapere non ha sconfitto la materialità dell’esistenza, dello stare qui e altrove. Anzi, la deriva identitaria che stiamo vivendo ne richiama fortemente le istanze. Questa generazione, consapevole o meno di essere la custode di questo pesante fardello, ne riprende i quesiti, ne riconosce nuovamente, rivedendone però i codici, l’attualità.
Così Ghetti rifugge il dualismo culturale: “La società occidentale moderna in cui viviamo è figlia di una cultura dualistica (bianco/nero, bene/male, anima/corpo, lontano/vicino, etc..). Questa proprietà intrinseca ci porta a volte a costruirci una raffigurazione monolitica di noi stessi, fondata sulle nostre certezze, tante volte percepite come matematiche (se non siamo neri siamo per forza bianchi!)”. E invece nell’erranza dei cromosomi ci sono solo infinite possibilità di tonalità. Già Donna Haraway2 vedeva nel dualismo un falso ideologico, volto a stabilire la supremazia di uno dei due elementi sull’altro: uomo/donna, bianco/nero, corpo/mente, sono in realtà coppie in conflitto in cui uno prevale sull’altro.
L’installazione Contro l’apparente dualità vuole operare nell’instabile mobilità dell’immagine catturata e rifratta. Il multiforme è per ammissione della stessa artista, la condizione del nomade. Che vive nell’individuazione, nell’essere qui ed ora, ma eternamente sfuggente. Così lo specchio, uno degli elementi più costanti di un artista italiano ormai storicizzato come Pistoletto, diventa lo strumento prismatico che intercetta spazio e tempo. Esso, come sosteneva il giovane Pistoletto nella storica mostra del ‘78 a Torino, può riflettere tutto, tranne se stesso. Eppure, può anche moltiplicarsi quando più specchi interagiscono. Suddividere diventava per l’artista il fondamento sostanziale di ogni sviluppo organico e aveva anche un valore sociale, “la condivisione come logica alternativa a quella dell’accumulazione e dell’esclusione”. Maria è un’epigona selettiva dell’interpretazione di Pistoletto: non ne fa un uso esclusivo e stilistico, ma ne sfrutta la valenza, ne cita la vocazione artistica, per un’opera che dialoga con questo tema, con una domanda che diventa dialettica concreta.
“Se l’arte è lo specchio della vita, io sono lo specchiaio”, asseriva l’artista biellese. Attratta più dal suo aspetto ludico, in cui il gioco diventa strumento cognitivo e non “divertimento” (dal latino deversus, volgere altrove, deviare), Ghetti è propagatrice di uno stupore bambino: vuole invitare il pubblico a riconoscersi nella nomade immagine, a ricomporre e acciambellare le certezze, che sono fumo se diventano un monolite. La certezza è pietra fragile, che porta al sonno della ragione.
1 H. Bergson, Materia e memoria. Saggio sulla relazione del corpo allo spirito, in H. Bergson, Opere, 1889-1896, di F. Sossi, a cura di P. A. Rovatti, A. Mondadori, Milano 1986, pagg. 257-258 396-397)
2 Donna Haraway, Manifesto Cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, a cura di L. Borghi, Milano, Feltrinelli 1995
ROM.AGNA Pratiche di transumanti
Pubblicato nel catalogo R.A.M. 2013, GIUDA edizioni, Ravenna

“Trasumanare” è uno degli innumerevoli neologismi utilizzati da Dante e significa andare al di là dei limiti della natura umana, trapassandola, trasformandola, fino a superarla per aderire ad una natura più alta, alla natura divina. Ripresa da Pasolini nella raccolta Trasumanar e organizzar, è diventata la parola guida di questa edizione di RAM: una sollecitazione partita dall’analisi delle biografie degli artisti e curatori vincitori di questa edizione, giocando con una parola affine fonicamente come transumante. Entrambi i termini, uno alto, letterario, l’altro legato alla pastorizia, a una delle attività più antiche dell’uomo, sono legati al viaggio, all’attraversamento, alla condizione mutabile.
La comunità artistica che ci troviamo davanti ci ha rimandato a questi due concetti: in questa nona edizione di RAM il tema su cui si sono trovati a lavorare gli artisti premiati è emerso da loro, da quello che loro comunicano con le loro storie e biografie.
La comunità artistica che ci troviamo davanti ci ha rimandato a questi due concetti: in questa nona edizione di RAM il tema su cui si sono trovati a lavorare gli artisti premiati è emerso da loro, da quello che loro comunicano con le loro storie e biografie.
Una generazione, non solo artistica, caratterizzata da un nomadismo strutturale, abituata al mutamento, destinata alla precarietà come elemento costitutivo della costruzione della storia di vita: questo dato emerge dalle bio, non solo del campione di RAM, ma degli artisti under 35 in generale. Il nomadismo peraltro è stato un tratto riconosciuto anche recentemente nella mostra “Nuovo nomadismo individuale” a Mantova curata da Francesco Barozzi: in quel caso l’etichetta, anche se ironica, era funzionale alla necessità di operare un riconoscimento tra stili e modalità differenti dei dodici artisti selezionati. Nel nostro caso il percorso è stato diverso. Non abbiamo bisogno di etichette e non ci muoviamo nella dérive lettrista: quel meraviglioso giocoso movimento fatto di ragazzi che per le strade di Parigi negli anni ’40 fermavano i passanti regalando pietre che dicevano essere meteoriti o comete con “le quali realizzare le nuove costruzioni da sottrarre alla progettazione degli architetti, che riempivano i muri di poliscrittura e che, armati di tutto ciò che il caso gli forniva, inventavano ogni giorno modi nuovi di sabotare lo spazio della città”1 Giovani che si divertivano a dare “l’appuntamento possibile”: si dava un appuntamento ad un amico di un amico che non si conosceva con precisione di orario e luogo. Nessuna persona lo aspettava, eppure questo “possibile appuntamento” che lo avrebbe condotto in un luogo poteva conoscere o meno. Comunque lo induceva ad osservarne i paraggi, a chiedere informazioni ai passanti o a muoversi in direzioni inconsulte, realizzando una deriva inconsapevole. Il situazionismo degli anni ‘60 doveva molto alle anticoncezionali visioni di questa esperienza: e al situazionismo si possono ricollegare molte delle esperienze basate sul processo, sull’osservazione del percorso artistico, del fare, più che al risultato, che sono emergenti in questi ultimi anni. Ma a noi non serviva un canone stilistico per mettere insieme gli artisti. Ci interessava osservare come gli aspetti salienti del nomadismo, il suo essere ibrido e meticcio, mescolatore e impuro, fosse alla base non solo di alcuni lavori, ma delle biografie stesse degli artisti vincitori di questa edizione.
Peraltro il fare e il pensare del più noto e influente artista italiano, Cattelan deve per sua stessa ammissione, molto alla consapevolezza della condizione nomadica “Credo che il nomadismo oggi sia molto importante: non solo ti ricorda come ci si sente da outsider, ma ti aiuta anche a tornare a casa e vedere il posto in cui vivi con occhi diversi, riaperti...”2
Oltre alla biografia però c’è anche la necessità di allargare il campo dalla propria condizione esistenziale alla riflessione su di esso, sulla categoria di nomade/transumante in questa contemporaneità fatta di lowcost e connessione a banda larga.
Anche se affascina la psicogeografia, le sue ramificazioni contemporanee, Hakim Bey e la “chiusura della mappa”, abbiamo preferito declinare la ricerca tra questi due poli apparentemente distanti: la trasumanza e il trasumanar dantesco ma ancor più pasoliniano. Tra i nomadi tradizionali, i transumanti sono legati alle stagioni e a luoghi tendenzialmente fissi: le greggi, le mandrie e i pastori si muovono dalla montagna alla pianura percorrendo i tratturi e seguendo il ritmo del clima. Conosciuta sin dall’antichità, la transumanza ha caratterizzato la vita di pastori di ogni Paese d’Europa e non solo: ora è un termine usato anche in rete, per indicare con metaforico pragmatismo il trasferimento di dati particolarmente cari da un sito all’altro... segno dei tempi.
In questa permanenza di una categoria fisica e terrena del movimento nomadico, si muovono i lavori del fotografo Camorani e Pezzi, del pittore Lanzoni, i trofei inquietanti di Fabiana Guerrini. Anche se l’allenamento al mestiere del’icona, dei milioni di scatti, di riproduzioni filmate, di parole raccolte in poche pagine di libro nel tentativo di produrre una sintesi della nostra vita tende di per sé al trasumanar: ci rendiamo divini, epuriamo le nostre immagini con benedizioni in post-produzione, pregando ogni giorno che qualcuno ci veda, che sia possibile ancora diventare divinità di noi stessi. E sulla labile frangia del polo apparentemente opposto, laconico luogo in cui la materia tende come la metafora o meglio la Sineciosi della diaspora (termine ripreso da Fortini che così definì la sua poesia: connubio tra antitesi e ossimoro, e che intitola una sezione di Trasumanar e organizzar), si trovano i lavori di Naghmeh Farahvash, i leggerissimi mosaici di Samantha Holmes, le installazioni incantate di Maria Ghetti. Nello spazio tramonta e si rinnova il sacro: evidente il tentativo di congiungere gli opposti, renderli visibili, sottoponendo lo sguardo a revisione. Cedono le algebriche costruzioni delle derive identitarie cedono alla dolce dérive gioiosa dei vecchi lettristi. Non difformi dai salti acrobatici dei giovani che fuori dal Mar volteggiano nel parkour. Dimenticano le barriere imposte, i codici preconfezionati e pregiudiziali per aprire nuove strade alla visione e alla geografia del sentimento. La nostra non è quindi un’etichetta, ma una provocazione sensoriale, una citazione dispersa che ha impegnato curatori e artisti per questa mostra/ricerca.
“Smetto di essere poeta originale, costa mancanza
di libertà: un sistema stilistico è troppo esclusivo.
Adotto schemi letterari collaudati, per essere più libero.
Naturalmente per ragioni pratiche”. (Pierpaolo Pasolini, Comunicato dell’Ansa, in Transumanar e organizzar, Garzanti, Milano, 1971, p. 66)
1 Liberamente copiato dal sito dei Luther Blissett.
2 Maurizio Cattelan l’arte di citare, intervista a Barbara Casavecchia.
Il gioco serissimo di Bajani con Tabucchi
L'intervista allo scrittore passato da Feltrinelli di Elettra Stamboulis

Quale sia il confine tra persona e personaggio, e se esso effettivamente esista, è una delle questioni centrali della produzione di Antonio Tabucchi. Forse non è un caso che Andrea Bajani abbia
reagito alla morte dello scrittore con cui aveva instaurato un legame importante rendendo lo stesso Tabucchi personaggio di questo strano romanzo/epistola dal titolo Mi riconosci
(presentato alla Feltrinelli di Ravenna giovedì 30 maggio).
Molti hanno interpretato questo tuo ultimo libro come un'indagine sul rapporto tra generazioni, oppure un dono di un figlio al padre simbolico...
«Sì, è vero. Peccato che io non creda esattamente nel concetto di “generazioni”. Non è la cosa prevalente per me nelle relazioni, nel legame. E in particolare con Tabucchi, con il quale avevo un
rapporto più simile a quello di due bambini che giocano seriamente. Hai presente quando due bambini giocano con due pietre e dicono questo è pinco e quello è caio e se le pietre cadono in un
tombino poi si può anche piangere? Ecco, quella serietà lì, che è strutturale nella scoperta, nel dialogo. È la stessa serietà giocosa che mi guida anche nelle mie esperienze con gli
adolescenti».

Raccontaci qualcosa di più questi tuoi percorsi di avvicinamento alla lettura e alla scrittura che conduci da diversi anni.
«Sono contesti molto faticosi, ma molto intensi, in cui, per ritornare ai due bambini che giocano, se un bambino ha un gioco che l’altro vuole, non lo vuole per il gioco in sé, tant’è che se lo
conquista scompare anche l’interesse. Vuole gli occhi con cui l’altro bambino vede quel gioco. Ecco, io cerco di proporre la letteratura cercando di rendere desiderabile lo sguardo con cui io
leggo. Questa è la base con cui lavoro, attivare situazioni di gioco serissimo in cui indaghiamo i nostri sguardi: ad esempio nel progetto per il Salone del libro di Torino l’idea giocosa di
inventare parole inesistenti su temi sentiti come più rilevanti mette insieme questi due aspetti. E i risultati parlano da sé, da “biostalgia” a “perdistanza” sono termini che individuano
qualcosa che c’è, ma prima non c’era il modo per dirlo».
In questo approccio c'è molto del tuo essere creativo, sconfinare dagli ambiti della scrittura letteraria per sperimentare anche altri spazi, come il teatro con Paolini,
la radio. Da dove sei partito?
«Sono partito dalla confusione, in cui c’era un’unica certezza. Avrei voluto scrivere. Semplicemente quando vedevo dalla finestra del futuro passare altre ipotesi, che sono passate come un corteo
di eventuali possibilità, l’unica sulla quale mi potessi ritrovare era quella della scrittura. Quindi laurea in Lettere, poi esperienze di ricerca, ambito letterature comparate. Ma quel mondo mi
stava stretto. Così fuga nella realtà. Correttore di bozze, progettista di eventi, quell’ambito indistinto del precariato cognitivo. Su cui ho anche scritto un libro reportage Mi spezzo, ma
non m’impiego, che oggi sento come troppo ironico. Non lo farei più con quel tono, perché quello che allora mi sembrava bislacco, oggi è drammatico. Poi mi ha salvato la Cgil...»
Una vertenza sul lavoro...
«No, una fortuna: il centenario del sindacato. Per il quale inseriscono nel carnet gli spettacoli una serie di reading per le camere del lavoro, tra cui anche un mio intervento. Ovviamente quello
che costa meno, visto che nessuno mi conosce. Questo, insieme a un piccolo anticipo che Einaudi mi diede per un libro, mi permisero di smettere di lavorare per vivere e cominciare a vivere per
lavorare. Girai tutte le sedi più piccole e sconosciute, tra cui ricordo una sarda con i minatori pensionati che ascoltavano perplessi la mia lettura sui precari. Questo mi permise anche di
viaggiare, cosa che non avevo mai fatto e che costituisce uno degli strumenti di lavoro più rilevanti che ho. Quando scrivo di Romania, vado e vivo lì. Per me la verità di quanto scritto è molto
più rilevante dello stile».
Quindi, quale potrebbe essere il tuo consiglio per un giovane che vede dalla finestra del futuro la scrittura come opzione?
«Fammi leggere qualcosa... La curiosità verso la letteratura, l’adesione alla sua profondità sono quello che ho trovato di inaspettato in Tabucchi, che lesse Se consideri le colpe e
volle scrivermi una lettera. Fu questo il motore della nostra amicizia».
E il luogo galeotto fu la casa di Valerio Adami...
«Esatto, un altro signore che mi ha permesso, anche ospitandomi a casa sua a Parigi, ad accedere ad un mondo dal quale sono molto attratto che è quello delle arti visive. Anche la copertina di
Benati di "Mi riconosci" è stata scelta da me ed ha un valore semantico nei confronti del libro che apre. Ho anche scritto un testo per un catalogo di Berruti, un altro artista che stimo molto e
il cui disegno mette in linee cose che vorrei dire».
Torniamo alle esperienze con i giovani: Domani niente scuola è uno strano libro nato dall’osservazione e dalla condivisione di un tempo sospeso come quello delle gite scolastiche
con tre gruppi, uno di Torino, uno di Palermo e uno di Firenze. La cosa curiosa è che è incredibilmente assonnante con la non scuola, che ha sede proprio a Ravenna.
«Conosco Ermanna e Marco, con i quali posso dire c'è una vicinanza di sensibilità, un domandarsi uguale. E sono anche particolarmente legato a Bagnacavallo».
Bajani ha vinto una schiera di premi, Bagutta, Super Mondello, Lo Straniero, Recanati, fattori che in alcuni casi potrebbero costruire un ottimo alibi per alzare il sopracciglio e sentenziare con
fervore. Stupisce, così come lui si stupì della curiosità di Tabucchi, la sua inesauribile curiosa voracità del reale, il desiderio di acchiappare con le parole e l’ascolto nel caos delle voci
spicchi di realtà. È quindi inesauribile l’intervista, un’aria piena di possibili aneddoti, personaggi, letture, analisi, domande.
Koko mosaico alla biennale con i quadri di Domingo Zapata
La collaborazione tra l’artista amato
dal jet set americano e i mosaicisti ravennati di Elettra Stamboulis

Hollywood si interessa al mosaico? Sembrerebbe di sì, e il caso, ma anche la tenacia, hanno premiato i Koko mosaico, l’atelier aperto a Ravenna da Luca Barberini, Arianna Gallo e Takako Hirai nel 2005.
Arianna, raccontaci come è successo che Domingo Zapata, artista amato dalle star e dal jet set americano, ha deciso di produrre ben quattro opere nel vostro studio.
«È stato veramente un puro caso. O meglio, la sua curiosità lo ha spinto a entrare come molti nel nostro spazio di fronte alla basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Tutti rimangono stupiti, quasi
meravigliati dopo aver visto i mosaici della chiesa nel vedere che ancora sopravvivono luoghi e mani che coltivano quest’arte. Ha fatto mille domande, su materiali, modalità di lavorazione, il
nostro percorso... Poi ha detto “tra un mese inauguro una mostra alla Biennale di Venezia: potete fare una traduzione a mosaico dei miei quadri?”. Ho risposto educatamente di sì, ma non ci
contavo molto».
E invece poi ha confermato il lavoro...
«Non solo. Ma è partito commissionandoci due opere di grande formato. Visto che una l’ha già venduta prima di esporla, ne ha richieste altre due. Speriamo l'abbia presa Johnny Depp...»
Oltre a voi, altri artisti del mosaico sono stati coinvolti nel progetto...
«Questa non è una novità. È il nostro modo di intendere questo spazio, un luogo aperto a chi vuole cimentarsi, uno spazio di incontro, in cui si può anche dormire e mangiare, dove fare comunità
artistica. In questo modo abbiamo avuto molti ospiti in residenza, soprattutto dal Giappone, ma non solo, curiosi di sperimentare questa tecnica. Ma Koko è un risultato collettivo. Questo periodo
per esempio collaboriamo con i CaCO3 su vari fronti, anche nella realizzazione di tre mosaici per la prossima mostra di Adami al Mar».
È molto interessante questa scelta di aprire un luogo in cui non c’è più quell’idea di segretezza che un po’ aleggiava nelle pratiche musive della nostra città. Anche se tu e Luca siete
veramente figli della scuola ravennate.
«Difatti entrambi ci siamo diplomati all’Istituto d’arte per il mosaico Severini. Io poi ho anche frequentato la scuola di restauro della Sovrintendenza e l’Albe Steiner. Anche se l’esperienza
che ci ha fatto incontrare è stata la realizzazione della copia della Battaglia di Isso. Quel contesto fu per noi non solo formativo, ma “galeotto”. Io sono quella che deve progettare, studiare,
mentre Luca è l’anima creativa. Ci completiamo».
Questa occasione è sicuramente positiva non solo per voi, ma per il mosaico in generale. che cosa consiglieresti ad un giovane che vuole intraprendere questa strada?
«Certo è dura. Ci vuole passione e tenacia. Ogni tanto qualcuno appare con la tempra, come un ragazzo che ha fatto lo stage da noi con la scuola e che è venuto per tutto l’inverno proprio per
passione. Vorremmo regalargli un corso di inglese: perché oltre al talento e al sacrificio, ci vuole anche la capacità di relazionarsi con il mondo, che è il luogo nel quale bisogna operare. Per
cui direi: lavora, crea! Ma anche: impara almeno l'inglese!»
Chiudere la porta di Koko è sempre un po' triste perchè si respira un’aria di vero laboratorio e stordisce positivamente stare in un luogo in cui tutti fanno con la testa e con le mani. E le
opere che campeggiano in attesa di essere trasferite sul Canal Grande per la mostra di Zapata non fanno ombra alle creazioni originali degli artisti che in questo caso non sono stati semplici
traduttori. Se poi è possibile mai fare una buona traduzione, senza ricreare un mondo.
I mosaici realizzati da Koko Mosaico per Domingo Zapata saranno esposti a Palazzo Morosini da Mula, sul canal Grande, dorso duro 725. L’inaugurazione su invito è prevista per il 28
maggio.
Margherita Manzelli, da Ravenna al mondo e ritorno
Ha esposto al Maxxi, Istanbul, New York, Londra
«Per diventare artista serve una vocazione a una religione laica» di Elettra Stamboulis

Sulla carta d’identità c’è scritto “artista”, ma, malgrado sia una delle artiste visive italiane più significative degli ultimi anni, le autorità le chiedono ancora se fa l’attrice. Margherita Manzelli, classe 1968 è una pittrice nata a Ravenna e che in città è tornata dopo avere esposto nelle capitali dell’arte e aver vissuto a Milano e per un breve periodo a New York e soprattutto a Londra.
Che effetto fa tornare nella provincia dopo aver respirato l'aria del mondo? Non ti senti parzialmente in esilio volontario?
«Essendo stata una scelta definirla esilio è forse ambiguo. Certo è che Londra mi manca moltissimo, tant'è che ci torno spessissimo. Trovo continuamente alibi che mi permettono di fuggire e
ritrovarla, anche se devo dire che la vita che ho fatto nella capitale inglese non è diversa da quella che faccio qui. Sono molto concentrata sul mio lavoro, sono un animale da studio, vivo
relegata sull’opera e rifuggo la mondanità e le inaugurazioni. Forse ne ho fatte troppe. E ora le scelgo accuratamente».
Qui comunque, oltre ad avere la tua famiglia che ha un ruolo centrale nella tua vita, ti sei formata.
«Sì, ho frequentato il Liceo Artistico, perché non avevo alternative, a me piaceva solo disegnare, sin da bambina. Una specie di possessione. “Per far star buona Margherita lasciatela
disegnare”... I miei genitori anche se a malincuore hanno assecondato questa mia passione, anche perché l'ho rivestita di un’aura utilitaristica, soprattutto quando ho annunciato loro che avrei
fatto anche l’Accademia a Ravenna. Scelsi Scultura, che con la sua veste pragmatica e il laboratorio di oreficeria tenuto allora da Lissoni aveva una parvenza di mestiere».

Però poi hai sempre dipinto! E negli anni ’90, quando fare pittura era quasi un'eresia.
«è vero (sorride). Sono un’autodidatta. E mi sento ancora una principiante per questo. Nessuno mi ha insegnato quello che poi ho praticato con ostinazione. Per questa ragione mi sento una che ha
avuto una fortuna formidabile. O forse il mio essere così tenace, fuori posto, bislacca, mi ha in qualche modo ripagato. Non ti dico poi la faccia che fatto mia madre quando le ho confessato che
volevo fare l'artista...»
Eppure ci sei riuscita. Cosa è successo dopo l’Accademia?
«Ho provato a fare tante cose. Un ruolo particolare, e non so neanche se lui lo sappia, lo ebbe Daniele Panebarco, che mi fece sperimentare tante cose. E mi fece capire che tutte mi piacevano, ma
che io volevo altro. Anche lui fu esterrefatto della mia scelta. Andai a Milano. Partire è fondamentale, se devo dare un consiglio. Poi si può ritornare. Ma solitamente, anche se ci sono
eccezioni, è necessario andare nel mondo, sfondare porte. Sentirsi anche soli e insicuri. È molto faticoso, ma è l’unica strada. Il mio primo canale a Milano fu Viafarini».
Lo spazio di documentazione e promozione dell’arte giovane che oggi gestisce anche le residenze della Fabbrica del Vapore?
«Esatto. Non so ancora come feci a convincere la curatrice, forse la presi per sfinimento. E quella mia mostra con quadretti appesi piacque molto, mi fece entrare in contatto con quelli che
sarebbero stati i miei galleristi e che ancora curano il mio lavoro».
Hai fatto mostre a Palazzo Grassi con Bonami, biennali, personali al Maxxi, esposto a Istanbul e New York, una delle tue gallerie di riferimento è a Londra. Come si coniuga questa
diaspora con il vivere a Ravenna? Sei in rapporto con il mondo dell’arte locale?
«Ora è possibile. Sono tornata matura, con una mia identità. E alcuni luoghi per me non erano praticabili per una vita, come ad esempio New York, che ho trovato così ancorata al denaro, così poco
stimolante, anche se ancora tutto si muove lì e se ho lottato per ottenere la residenza in quella città. Qui trovo una dimensione che mi permette di coniugare lavoro artistico e vita personale.
Con la mia città sono quindi in relazione, ma in modo diverso, su un livello privato. Non riesco a tenere insieme troppi progetti. E quindi sono costretta a vivere un po’ schiva. Mi avevano ad
esempio proposto delle docenze, ma non mi sento in grado di insegnare. Rifiutai anche quando me lo chiesero da Los Angeles. E poi ripeto mi sento una che va per tentativi».
Che cosa consiglieresti a chi vuole intraprendere oggi la carriera di artista...
«Cercherei di fargli cambiare idea! È una condizione orribile, solo pochissimi ci riescono. Io sono stata molto fortunata, ma conosco molti amici molto più dotati, più bravi di me che non sono
riusciti. E ci vuole una sorta di vocazione, di chiamata a una religione laica. Se non si ha quella, meglio dirottarsi su altro. Se mio figlio mi dicesse che vuol fare l'artista non la prenderei
bene...»
Margherita sorride, e con la sua grazia e dolcezza scherma l’estrema concentrazione e dedizione alla pittura e alla figura. Chissà che anche il figlio non ci sorprenda.
Nomadi per scelta e per necessità
La fotografia come forma terapeutica e i viaggi fino in Taiwan di Nastynasty di Elettra Stamboulis

Dopo una serie di residenze artistiche all’estero che li hanno portati dal pack russo all’avveniristica Taiwan, il duo Nastynasty© è ora ospite del programma di “casa temporanea”
per artisti di Ardis Hall. Emiliano Biondelli e Valentina Venturi vengono da esperienze e traiettorie diverse, ma sono accomunati dall’interesse «per come le cose reagiscono alla luce», per dirla
con Valentina.
Come siete approdati alla fotografia? Mi ricordo di Valentina tecnico delle luci...
V: «Effettivamente mia madre quando mi ha visto srotolare dei cavi non l’ha presa bene. D’altro canto io vedo una linea coerente di ricerca: dall’istituto d’arte Severini al Dams
indirizzo Arte, alle luci sul palco alla fotografia, c’è questo continuo stupore per come la luce si posa sulle cose».
E: «Il mio, forse, è un percorso più obliquo. Sono ragioniere, e dopo il diploma ho fatto il consulente del lavoro...»
È difficile immaginarti in questo ruolo...
E: «Anche per me lo fu, faticoso. Cercavo una fuga, una forma di liberazione, così mi iscrissi all’università a Conservazione. Poi andai in terapia, dove portai la serie di
fotografie che mi facevo come forma di individuazione. Il terapeuta mi disse che era interessante, che forse potevo usare questo mezzo per indagare anche altro».
Quindi la fotografia come forma terapeutica e di ricerca...
V: «Sì, una sorta di strumento di indagine, che però scardina le cose più che metterle in ordine. È una ricerca centrifuga, più che centripeta, la nostra. Un guardare per
evidenziare quanto c'è di storto o inaspettato».
E il nome? Questo curioso Nastynasty©...
E: «Volevamo qualcosa che ricordasse il linguaggio dei teenager, quello che non siamo più. Quella lingua che abbiamo scordato. Allo stesso tempo volevamo qualcosa che desse
l'idea di un brand, non di una o più persone. Noi non siamo artisti che impongono la loro visione, ma allo stesso tempo viviamo in un mercato».
V: «Cerchiamo piuttosto di cogliere la falsità della visione. Il nostro non è carotaggio in profondità, ma una lieve deformazione».
Quest’anima irrequieta e curiosa vi ha portato peregrini all’estero. Come è successo? Cosa succede in residenza artistica? È un’occasione o una possibilità dentro l'impossibilità del
lavoro artistico in Italia?
V: «Direi che ci sono entrambi gli aspetti. Noi siamo partiti dalla ricognizione della Romagna, con BlisterZine, che è un progetto editoriale autoprodotto, abbiamo
inaugurato la pubblicazione con R.i.p. Real Italian Patriot: una interpretazione fotografica della commemorazione garibaldina del nostro territorio».
E: «Poi con I Folk U e gli sciucaren, che hanno riscosso un'attenzione incredibile in Giappone...».
V: «In realtà questi progetti, che forse un po' ingenuamente avevamo proposto anche sul territorio, qui non hanno mai ricevuto attenzione, mentre all’estero sono stati un po’ il
nostro viatico. La residenza artistica però funziona su un progetto che si sviluppa nel luogo in cui si va. Ci sono siti che danno informazioni sulle residenze attive e credibili, è il luogo
giusto da cui partire».
E: «Noi prima partiamo dalla questione che ci interessa, diciamo dal tema e poi selezioniamo l’area a cui fare domanda. Ad esempio, nel progetto sul potere della fotografia è
venuto spontaneo rivolgersi all’area asiatica, in particolare Taiwan, che è uno dei luoghi in cui si producono più dispositivi mobili che permettono a chiunque di fotografare. Quasi costringono a
farlo».
Qual è il valore aggiunto della residenza? Essere nomadi è una condizione connaturata all’essere artisti?
V: «In questo momento è la modalità con cui si può lavorare. L’Italia è al palo, chiusa ancora nel sistema delle scuderie, con le gallerie che stanno saltando una ad una».
E: «Il nostro poi è un lavoro misto, ibrido, difficile da rinchiudere in un format. Per cui la possibilità di essere e guardare fuori, ci permette di fare progetti che qui sono
ancora in divenire. Prendiamo ad esempio il libro d'artista, un modo intermedio con cui il formato libro sta tentando la sopravvivenza interagendo con il processo artistico...».
Sarà quindi particolarmente stimolante visitare sabato e domenica il risultato dell’open studio all’Ardis Hall, perché seguire le traiettorie mobili della progettualità di Nastynasty© sul globo è
possibile solo virtualmente. Oppure comprando i progetti editoriali, raffinati ma anche indocili, che ne testimoniano il tragitto.
Marina Girardi, fumettista in bici
L'illustratrice bolognese in mostra a Ravenna di Elettra Stamboulis
Avrebbe voluto far la maestra, Marina Girardi: questo ha raccontato agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna venerdì 12 aprile. E certo, la sua frizzante esperienza di didattica
attoriale – laboratoriale del disegno un po’ lascia intravedere l’anima pedagogica e accogliente dell’artista bellunese trapiantata a Bologna.

Raccontaci un po’ la storia di questo percorso di ricerca, come sei diventata artista, come ti mantieni... le stesse domande che gli studenti dell’Accademia ti hanno rivolto e che
preoccupano i molti che si affacciano al mondo “inutile” dell’arte...
«Il mio è stato un percorso un po’ anomalo. Dalle aule seriose del Liceo Classico sono poi planata al disegno, alla musica, alla pittura e al fumetto attraverso molti incontri e diverse
esperienze formative. Devo dire che un ruolo particolare ha avuto il workshop con Marjane Satrapi che voi di Mirada avevate organizzato nel 2003. Lì ho come puntualizzato che cosa volevo essere.
Ovviamente i buoni maestri della Scuola di Comics di Firenze, alla Nuova Eloisa di Bologna, alla Scuola Internazionale di Illustrazione di Sarmede (TV), infine al corso di Fumetto e
Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove mi sono diplomata nel 2009 hanno contribuito a darmi strumenti per tirare fuori quello che volevo».
Che cosa succede in una settimana da Marina? Come organizzi il tuo tempo e il tuo lavoro?
«Forse perché ho origini montanare, amo molto la natura e l’aria aperta. Un appuntamento quasi fisso è la pittura en plein air in via Oberdan a Bologna il sabato. Cavalletto, colori e pennelli ho
il mio pubblico semifisso che mi aspetta. Clienti inaspettati che comprano un quadro, dialoghi di critici improvvisati sul colore, interventi sul lavoro di commesse e studenti. Da ormai dieci
anni sanno che mi troveranno lì, molti tornano, altri passano e si incuriosiscono. Poi ci sono i laboratori in giro per l'Italia: fumetti in bici è nato a Bologna, ma si è spostato anche a
Venezia...»

Ti interrompo. Ma come si fa a fare fumetti in bici?
«È lo sguardo a un’altra velocità che conta. Ovunque ci sono storie e angoli che val la pena di raccontare, bisogna però rallentare e annusare. La bici può aiutare...»
I tuoi laboratori sono sempre pieni di sorprese. Come la chitarra, l’uso della drammatizzazione per disegnare...
«A me piace meravigliarmi e i bambini ci riescono sempre a riempirmi di stupore. Cerco quindi di usare anche io qualche strumento che mi permetta di connettermi a questa meraviglia...»
Non ti senti una pittrice fumettista un po’ naif? Come ti vedono in genere nel mondo dell’arte?
«Sinceramente non me lo chiedo. Cioè, la questione del mondo dell’arte. Ho visto la mostra Borderline al Mar e ho pensato che potrei essere un’autrice esposta... anche se per il momento non mi è
stata diagnosticata nessuna malattia mentale! Il naif invece mi piace come categoria: è qualcosa di popolare e comunicativo, che scende dal piedistallo. E in tutto quello che faccio, dal fumetto
alla pittura, uno dei miei obiettivi è togliere l'aura della lontanza e ristabilire una vicinanza con l’arte».
Chi è stato all'inaugurazione della mostra di disegni originali “Dalle tane” non potrà certo dimenticare quest'artista che ha disegnato a grandi e bambini sul volto o sulla mano una visione di
primavera, cantando. Magie della Maga Magira, come ama spesso chiamarsi.
La mostra “Dalle tane” è visitabile presso Galleria Mirada, in via Mazzini 83 a Ravenna fino al 5 maggio 2013 il mercoledì dalle 10 alle 13 e dal venerdì alla domenica dalle 15 alle 19 (altri
orari su appuntamento info@mirada.it).
Per maggiori informazioni sul lavoro di Marina Girardi http://www.magira.altervista.org/
Cuori così bianchi. Un immaginario dialogo tra Javier Marías e sua figlia.
Pubblicato sul catalogo di Selvatico, Cotignola (2013)

-
Hai finito?
-
In che senso, ho finito? Intendi se ho finito di scrivere?
-
Sì, vedo che guardi la pagina bianca.
-
È così. Ho scritto la parola fine. Ma non so se questo significa finire. Perché sempre si può ricominciare. Decidere un nuovo inizio.
-
Certo. Anche io a volte decido di cominciare un gioco nuovo. Comunque lo decido. Allora, hai deciso di finire?
-
Credo di sì. Vedere la pagina bianca mi fa pensare alla fine. Che non ho più niente da aggiungere.
-
È strano, tu dici sempre che la pagina bianca è un inizio, è la possibilità, non la fine. Oggi mi dici il contrario.
-
A volte anche il contrario può essere vero.
-
Papà, mi confondi. Il contrario non può essere vero. Solo ci possono essere due verità in una cosa che appaiono contrarie. Anche in alcune storie è così.
-
Hai ragione, non mi sono espresso bene. Ci sono entrambe le cose, che non sono verità, in una pagina bianca. L'inizio e la fine. Solo quando mettiamo un segno, o non lo mettiamo, decidiamo in che parte della cosa vogliamo stare. A te piace più finire o iniziare?
-
A me piace iniziare, quando il gioco finisce è sempre un po' triste. Lasci qualcuno o qualcosa. C'è un abbandono.
-
Però puoi sempre iniziare qualcosa di nuovo. E quindi c'è sempre anche la possibilità di un nuovo inizio. Come in questa pagina bianca. Potrei ricominciare a scrivere adesso, e dopo aver scritto Un cuore così bianco, scrivere un altro romanzo oppure disegnare oppure tenere un diario. Oppure stare a parlare con te...
-
Parlare con me è sempre meglio, è meno rischioso e più divertente. Anche se a volte mi sembra che preferiresti continuare a guardare la tua pagina bianca... Di cosa parla il tuo libro?
-
Credo che parli del segreto e della sua possibile convenienza, della persuasione e dell'istigazione, del matrimonio, della responsabilità di chi ha saputo, della possibilità di sapere e dell'impossibilità d'ignorare, del sospetto, del parlare e del tacere.
-
È come la pagina bianca, insomma. Ci sono sempre due cose. Parlare e tacere, sapere e ignorare. Voi adulti mi confondete. Sembra che non ci siano mai confini tra le cose. Capisco l'inizio e la fine, ma sapere e ignorare. Sono proprio due cose diverse.
-
Forse invece è proprio così in tutte le cose. Coesistono due cose diverse. Anche tu sei il risultato di due cose diverse, il papà e la mamma.
-
Uhm, però io sono io. E sono anche un po' la nonna. E papà, se ci sono sempre almeno due cose, come si fa a decidere? Perché tu scrivi oppure smetti, oppure disegni?
-
Difficile rispondere. Tu perché decidi di giocare oppure di smettere?
-
Io smetto quando mi annoio. Quando sento che ho finito con quel gioco lì, non c'è più niente che possa succedere.
-
Allora sappiamo quando si smette. E quando si decide di iniziare?
-
Io voglio sempre giocare. Quello non smette mai. Inizio quando trovo il modo di farlo.
-
Anche io vorrei sempre iniziare. Ma a volte non c'è il modo. Non c'è il modo di trovare il capo e la coda, oppure si è semplicemente bianchi dentro per un po'.
-
Anche tu hai il cuore bianco allora? Come nel tuo libro...
-
«Le mie mani sono come le tue, ma ho vergogna di avere un cuore cosí bianco». Lo dice Lady Macbeth al marito che ha appena ucciso un uomo. Bisogna non essere contagiati dalle colpe degli altri, non conoscere né l'inizio né la fine della colpa.
-
È come far finta di niente?
-
Non si può far finta di niente. Nel momento in cui il segreto è svelato noi diventiamo parte della colpa, dobbiamo decidere come andare avanti nella pagina bianca. Anche lasciarla bianca è un gesto. Anche non fare gesti.
-
Capisco. Io allora ho il cuore bianco perché sono bambina?
-
Alcuni dicevano di sì. Il bambino è una tavola bianca: ma quando? Non mi pare possibile trovare un momento così bianco. Tu sei il risultato di scelte o caso, che non sai. Nessuno di noi sa esattamente da dove viene. Non scegliamo il nostro nome e siamo già alla nascita una pagina su cui è stato scritto da altri.
-
Allora ho deciso. Non ho il cuore bianco, ma lo vorrei con tutti fiorellini. Me lo puoi fare?
-
Ci provo.
L'ossessiva normalità dell'essere speciale
Komikazen 8° Festival internazionale del fumetto di realtà, Ravenna 2012

Svegliati! Esci dall'infanzia.
IMMANUEL KANT (1784)
Se dovessimo trovare un minimo comune denominatore nei tentativi di rappresentare e raccontare la Storia d'Italia, potremmo dire che esso risiede nel ricorrere continuamente alla categoria di eccezionalità. L'eccezione di diventare stato nazione con notevole ritardo e senza una lingua comune, l'eccezione del mezzogiorno, l'eccezione delle mafie, l'eccezione dello stragismo, l'eccezione del PCI, e così ad eccepire. Nel suo considerarsi speciale, si configura la normalità della storiografia italiana e delle sue propaggini. Intendo le forme di narrazione storiche che possono essere ricondotte alla volontà di narrare la Storia, ma che usano forme diverse dalla ricerca scientifica. Come il fumetto.
A fare da sponda alla deriva di una realtà storica apparentemente non consegnabile al presente spesso ci sono state le letterature e le arti: dal verismo di Verga e De Roberto, alla letteratura di realtà al neorealismo cinematografico, c'è una sottile linea che collega queste espressioni. In tutte l'afasia, l'impossibilità del raccontare l'eccezionalità della storia italiana, si è tramutata in traccia che rivendica la possibilità di prendere la parola, di rappresentare l'Italia senza l'ausilio dell'idealismo, della tradizione e senza il sospetto per la scienza e la tecnica. Questi tre ingredienti, idealismo, tradizione e sfiducia nella scienza, sono difatti i tre ingredienti che incontriamo in molta della produzione culturale del nostro Paese. Ci sono stati però modelli e scelte che ne hanno preso le distanze, anche se lo hanno fatto rimanendo anch'essi l'eccezione.
Anche lo scorcio del secolo breve ci aveva consegnato ad un altro paesaggio narrativo: con la fine delle ideologie, dei “grandi racconti”1, la condizione postmoderna si era tramutata in condizione permanente, inconsapevole forse, ma attualizzata proprio nella realtà che essa stessa disconosceva. Le teorie che avevano animato i salotti intellettuali, riempito le librerie dei futuri disoccupati cognitivi, erano diventate l'arma con cui il populismo mediatico si stava preparando da Bush a Berlusconi a Putin, a diventare il nuovo sistema. Un sistema che non prevede alternative e che si basa sull'assunto che il mondo vero è una favola, il futuro è già qui, solo non lo vediamo. E non ha senso vederlo perché la realtà è un'opinione, e come tale può essere espressa in un talkshow, ma non può essere verificata. La realizzazione politica e sociale del postmoderno2si è manifestata con ciò che i postmoderni avevano solo pensato, e l'arte nelle sue varie forme si è fatta interprete di questa visione.
Nel relativismo culturale e artistico è incappato anche il fumetto di quegli anni, vivendo difatti un periodo di ridefinizione, ripetitività e ripiegamento che sembravano quasi segnarne la fine. Il mondo degli anni '80 era finito e non si capiva che cosa e se ci sarebbe stato un nuovo futuro. Eppure successe che l'inemendabilità del reale3, cioè il suo esserci anche se noi riottosamente non vogliamo conoscerlo o crediamo di non poterlo afferrare, o che semplicemente non esista, è rientrato nelle matite dei disegnatori, in particolare della nuova generazione, infettandone le vignette, diventando il segno che ne contraddistingue gran parte della produzione. Non che non esista anche il mondo della favola bella: anzi, chiunque frequenti le grandi fiere del fumetto non può non rimanere stordito dal travestitismo irruente dei cosplayer, dei giocatori di ruolo, di orde di giovani e meno giovani affascinati dalla ideologia pop della mitologizzazione della rappresentazione. In questo campo ovviamente c'è anche un enorme mercato e un indotto economico difficilmente quantificabile. Eppure. Eppure il nuovo non è in questo fenomeno, facilmente assimilabile ad altre forme di entertainment che vanno da Disneyland e i suoi emuli alle sagre finto medioevali. Ma l'elemento di novità e ricostruzione del medium è venuto dalla nascita della cosiddetta Graphic Novel, che può essere riconoscibile sostanzialmente dal cambiamento del formato da albo a libro più tradizionale, e in particolare per l'Italia dalla proliferazione delle narrazioni di storie di realtà che scaturivano sia da episodi classicamente iscritti nella storia nazionale in particolare più recente, che dalla narrazione di micro storie peculiari per la ricostruzione di una storia degli esclusi. E gli incontri tra storie e autori può essere sorprendente.
E sorprendente è il risultato dell'incontro tra un eroe del Risorgimento come Garibaldi, ormai paludato e fermo in marmi su cui svolazzano piccioni e si baciano adolescenti, e Tuono Pettinato, che già nel nome d'arte certifica la sua deliziosa irriverenza. Garibaldi non è nuovo a questi incontri, ha avuto già appuntamenti persino con l'animazione4, molte versioni cinematografiche, ed è una delle icone più importanti dell'idea di Italia, trasformatosi assai presto in nome che richiama la cosa senza bisogno di ulteriori approfondimenti. Il taglio di Tuono, che volutamente demitizza senza però creare una caricatura, ha esplicitamente anch'esso intenti didascalici. Di Garibaldi si mettono in evidenza pecche e limiti, restituendo umanità ai busti e alle lapidi che lo incorniciano come una pietra nella memoria nostrana. E con il Risorgimento ha fatto i conti anche l'istrionico Giuseppe Palumbo: un autore da cui ci potevamo attendere l'azzardo di mettere le mani sulla parte di Storia più bistratta e meno amata delle pagine scolastiche. Il segno di Palumbo, che diventa folgorante e malinconico quando si permette di essere libero dai vincoli della produzione di serie, si addice alla pensosa riflessione del suo approccio alla narrazione delle origini. Un approccio che ritroviamo anche nella storia dedicata al sindaco poeta Rocco Scotellaro, in cui il tema delle origini si interseca con la biografia dello stesso Palumbo.
Nell'ambiguo confine tra narrazione dell'altro e di sé si muove anche Paolo Bacilieri con Sweet Salgari: la biografia del grande autore dell'avventura, ancora oggi uno dei cinque autori più tradotti nel mondo, che ha narrato di mari e monti senza mai muoversi da casa, costituisce una sorta di alter ego per l'autore, che però non si sottrae ad una rappresentazione filologica dell'Italia appena nata e che dopo qualche anno sarà bagnata dal sangue della Prima Guerra Mondiale. Dalla fine consapevole, ma pur sempre drammatica di Salgari alla biografia di un altro personaggio che nella letteratura italiana ha vissuto come un nomade, un oggetto disperso e disamorato: Rocco Lombardi e Simone Lucciola firmano un Campana che riporta, nella sua tensione figurativa data dallo stile delle incisioni di Lombardi, il tratto peculiare della dedizione alla parola che scolpisce l'anima.
Della Seconda Guerra Mondiale nel suo tragico epilogo, che qualcuno ha definito “guerra civile” e non solo guerra di resistenza, si occupa Ultimo. Storia di ordinaria guerra civile di Gianluca Costantini, Andrea Colombari e Saturno Carnoli: la restituzione di una storia rimossa, dei morti ammazzati che “non pianse nessuno”, perché scomodi ad entrambe le parti, è l'obiettivo di questo libro che ripercorre l'uccisione di Leandro Arpinati, squadrista fascista assai noto, e Torquato Nanni, socialista e antifascista, suo amico d'infanzia. Costantini ha disegnato anche Cena con Gramsci, tratto da un testo teatrale, e quindi interessante adattamento dal palco alla matita.
La vita di un uomo e il suo lascito sono al centro di Lo scrittore necessario. Una biografia di Primo Levi dal 1946 al 1987 di Pietro Scarnera: un titolo programmatico, per raccogliere solo una parte degli anni, quelli da lui non direttamente narrati o meno noti.
E di nuovo al centro della narrazione la vita di un uomo che ha tracciato un pezzo di storia economica e culturale dell'Italia in piena ripresa industriale, Adriano Olivetti. Un secolo troppo presto di Marco Peroni e Riccardo Cecchetti, che in qualche modo già nel titolo riprende la lettura storiografica di Eric Hobsbawm che ha periodizzato dal 1914 al 1991 la realtà storica al di là delle date del ventesimo secolo. Furio Colombo lo ha definito forse il più bel testo di politica contemporanea5e in questa immaginaria intervista si riconquista lo spazio dell'indagine, utilizzando una forma narrativa che già nel Pasolini. Un incontro di Toffolo aveva mostrato la sua fertilità. La possibilità proprio di partire dall'incontro con la storia per ripercorrere passi e domandare verità, per aprire strade alla ricerca di risposte.
Questo intrecciarsi dei piani temporali, presente e passato, in un continuo dialogo che mette in scena direttamente il farsi della ricerca storica caratterizza anche il fortunato In Italia sono tutti maschi di Luca De Santis e Sara Colaone. Storia collettiva e al contempo contingente della comunità degli omosessuali al confino all'epoca del fascismo, il centro della narrazione è il silenzio, la dismissione della memoria della reclusione e del moralismo autoritario. Colaone torna alle storie singole che diventano collettive con Ciao, ciao bambina, nato dalla volontà di ricucire la propria storia famigliare di emigrazione, trova la propria forza proprio dall'uscire dal biografismo per diventare storia esemplare che parla di un Paese che è diventato tanti Paesi, dimenticandosi però in fretta quanto è duro partire. Palacinche. Storia di un esule friulana di Caterina Sansone e Alessandro Tota nasce anch'esso da istanze tutto sommato simili: l'esperienza familiare di Sansone, il bisogno di riprendere la matassa delle parole, delle immagini e delle storie singole per ricostruire se possibile una cornice di una storia collettiva rimossa, quella degli esuli istriani. Un pezzo di storia con cui, per motivi ideologici e legati al tempo in cui fu, si fa fatica ancora ad armeggiare e che riappare attraverso l'uso di madeleines: la musica nel caso del libro di Colaone, le frittelle e quindi il cibo nel viaggio a ritroso di Sansone.
Con Il mio Vajont di Marco Pugliese e Paolo Cossi siamo invece di fronte ad una vicenda che è diventata, grazie alla narrazione teatrale di Paolini in particolare, un episodio quasi paradigmatico delle storie di catastrofi del nostro Paese, della sua anormalità: i due autori, Cossi in questo caso sceneggiatore e Pugliese disegnatore, hanno prodotto un lavoro urgente, del presente, che non si sovrappone alla ricostruzione storica, ma che vuole verificare che cosa oggi c'è nella valle del disastro in cui morirono 1917 persone.
Lo spazio che ancora si abita, la comunità che c'era con le comparse, i ricordi d'infanzia che si intersecano alla Storia maiuscola sono la materia viva di Morti di sonno di Davide Reviati: l'utilizzo dell'occhio bambino stempera e apparentemente maschera il senso di perdita di un mondo, i quartieri operai degli anni '60 e '70 che hanno costituito il nuovo villaggio urbano al posto di quello agricolo da cui gli operai provenivano, senza però nostalgie passatiste. Una storia che proprio per il suo essere solo velatamente autobiografica è riuscita a raccontare le molte storie di queste comunità.
Circostanziato e legato ad un evento che è diventato materia di canzoni, slogan, film, Pinelli e Calabresi. Una storia sbagliata di Bepi Vigna e Mattia Surroz si pone invece l'obiettivo di una lettura indipendente dell'episodio che segna la nascita degli anni di piombo. I due protagonisti, il ferroviere anarchico e il commissario, diventano vittime e simboli di un periodo che ancora non è stato né canonizzato, né storicamente veramente narrato. Tant'è che le versioni cinematografiche italiane che hanno tentato di rappresentare gli anni di piombo sono apparse irrisolte e la vicenda di Pinelli e Calabresi nella sua dicotomia, nel suo essere facilmente manipolabile dal punto di vista simbolico è assunta a icona, ma è anche particolarmente rischiosa.
Piazza della Loggia. Non è di maggio di Francesco Barilli e Matteo Fenoglio è un'opera che riprende l'esperienza pregressa dei due autori con il libro su Piazza Fontana: raccontare la storia, sapendo che non è dalle sentenze dei tribunali che può emergere sempre la verità. Perché la via della giustizia segue percorsi strani e contorti, i fatti invece sono ormai certi. Anche se non ci sono colpevoli perché tutti gli imputati sono stati assolti in appello, questo non significa che non si sappia chi sono i responsabili della strage del '74 a Brescia. Con questo intento il lavoro di vera e propria ricostruzione storica attraverso lavoro di archivio, la consultazione diretta del materiale giudiziario, le interviste a testimoni e superstiti ha permesso la realizzazione di questo libro che è solo il volume 1 di questa ricerca.
E sul 1978 ci sono ben due opere, simmetriche perché le vite dei due personaggi protagonisti sono finite nello stesso giorno con alchemica precisione: Peppino Impastato. Un giullare contro la mafia di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso e Il sequestro Moro di Paolo Parisi. Improntato al recupero dell'umanità di Impastato, ai suoi atteggiamenti anticonformisti e alla ricostruzione della personalità del giovane attivista il primo, il libro di Parisi ha invece un taglio più sospeso e meno documentario. Concentrato sul labirinto della ragioni delle “schegge impazzite”, sulla fine apparente di una stagione di fuoco che ritorna con l'omicidio D'Antona, impiega diversi livelli temporali creando un intreccio che lascia aperte molte vie di interpretazione.
Ustica. Scenari di guerra di Leonora Sartori e Andrea Vivaldo ci porta nuovamente nel gorgo putrido dei cosiddetti misteri italiani. Ristampato in occasione del trentennale della strage, il libro segue con delicatezza, ma anche chiarezza le varie ipotesi di indagine. Certo è che uno degli aspetti più disarmanti dell'anormalità italiana è che, pur essendo avvenuta 35 giorni dopo, nessuno mise all'epoca in relazione la strage di Ustica con quella di Bologna. Andrea Laprovitera e Andrea Vivaldo con Il treno sono partiti proprio dalla strage del 2 agosto del 1980, su cui si sono cimentati anche Boschetti e Cimmitti,6 ma hanno scelto una narrazione più volutamente cinematografica, intrecciando tre vicende che partono dal '68 (e ahimé non aiuteranno a modificare la confusione ancora imperante sulla matrice di questa strage) e trovano con un colpo di scena una chiusura d'effetto in quella drammatica giornata alla stazione del capoluogo emiliano. L'idea di una necessità di un bilanciamento politico, che ricorda l'assunto conformista del bisogno di avere “due voci sempre presenti”, in una vicenda che ha avuto un epilogo giudiziario in cui una sentenza ci fu risulta un po' centrifuga Anche se non fu possibile individuare chiaramente i mandanti: tuttavia se si legge l'elenco dei nomi dei condannati per depistaggio non è difficile ricostruire la storia (non la questione legale) di questa vicenda.
Il caso Calvi di Luca Amerio, Luca Baino e Matteo Valdameri rientra nella ridda dei misteri noir che purtroppo infestano le pagine della storia italiana, e non solo dell'ultimo secolo. L'apparente suicidio sotto il ponte dei Frari Neri a Londra aveva tutte le caratteristiche di un film di genere, eppure la realtà ha ancora una volta superato la fantasia. La complessità della materia che investe la biografia del banchiere suicidato non ha spaventato gli autori, che con grande umiltà hanno portato un pezzo di storia scavando nel multiforme materiale che riguarda finanza, P2, Vaticano, politica e chi allora volle chiudere occhi e orecchie.
E si torna invece nel falcidiato sud con Pippo Fava. Lo spirito di un giornale di Luigi Politano e Luca Ferrara. Un meridione che è l'ambientazione di una notevole fetta delle Graphic Novel prodotte negli ultimi anni e che purtroppo non smette di essere lo scenario nel quale i mali dell'Italia giocano una sorta di corrida mortale. Il giornalista coraggioso de I siciliani, ucciso nel 1984, appassiona Politano, anch'egli giornalista che crede ancora nella ricerca della verità: nei giorni in cui il figlio Claudio Fava si candida a governatore della Sicilia, non è scontato tornare a ricordare il padre, riaprire le ferite e gli interrogativi sulle ragioni di questo dissesto prima che politico, morale.
Antonino Caponnetto. Non è finito tutto di Luca Salici e Luca Ferrara e Un fatto umano. Storia del pool antimafia di Manfredi Giffone, Fabrizio Longo e Alessandro Parodi si inseriscono in questa ricostruzione amorevole, tenace e resistente della storia di chi si è opposto all'inevitabilità delle mafie. Riprende al contrario la frase che il giudice Caponnetto proferì uscendo dall'obitorio in cui aveva appena visto il corpo distrutto di Borsellino il titolo del primo libro: dopo lo sconforto per l'uccisione di Falcone e Borsellino, difatti, Caponnetto non si diede per vinto e scelse la strada della divulgazione, del dialogo con le giovani generazioni per tenere viva non solo la memoria, ma soprattutto la coscienza civile. Sempre sul pool antimafia, ma con taglio più filologico e al contempo interpretativo il lavoro di Un fatto umano: frutto di una cospicua ricerca sul campo e di una scelta che riflette l'intenzionalità dell'intervento semiotico sul segno (ovvero la scelta di rappresentare con facce da animali i protagonisti della storia, quasi a dire, “questo è il nostro Maus, questa è la materia calda della nostra memoria”) il voluminoso lavoro su sceneggiatura di Giffone è anche un'opera di ricerca e collazione delle fonti.
Poi arrivarono gli anni del ventennio berlusconiano: di questo periodo, ancora in bilico tra passato e presente, radiografa il mutamento antropologico Riccardo Mannelli: il suo non è un lavoro umoristico, di commento alla notizia, ma è un disegno e parola che diventano strumento di informazione e soprattutto di analisi. In questo senso la sua satira può coesistere con le narrazioni formato libro presenti nella mostra. Anche perché sullo scivoloso pendio del premier italiano più famoso nel mondo ancora nessuno ha osato buttarsi.
Apparentemente fuori dalla lista, ma pur sempre denso di aspetti irrisolti, l'inquietante fine di un mito del ciclismo italiano è il fulcro di Gli ultimi giorni di Marco Pantani di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso. Basato sul libro inchiesta del giornalista francese Philippe Brunel, ne ripropone dubbi, perplessità, punti non chiari: qui si mescola la mitologia e l'importanza sociale che lo sport, e in particolare il ciclismo (insieme al calcio, ovviamente, e questo ce lo ricorda Il ribella granata su Gigi Meroni7) riveste in Italia al tema comune a molti questi lavori, ovvero l'incapacità di conoscere la verità. E ritroviamo sempre Marco Rizzo, insieme a Nico Blunda e Giuseppe Lo Bocchiaro, nel progetto dedicato a un personaggio che davvero ha attraversato fasi e contesti diversi e che raccontano una bella fetta dell'Italia tra anni '70 e la fine degli '80, Mauro Rostagno, prove tecniche per un mondo migliore: la biografia dell'eclettico e instancabile Rostagno va dalla fondazione di Lotta Continua, alla creazione di Macondo, uno dei primi centri sociali autogestiti in Italia, alla comunità Saman in Sicilia, alla morte per mano della mafia.
Ed eccoci a superare la soglia del nuovo millennio, che già odora di fine: Carlo Giuliani. Il ribelle di Genova di Francesco Barilli e Manuel De Carli segna la fine del rapporto conflittuale, ma ancora dialogante tra un movimento multiforme e dalle molte anime come quello no global che si riunì a Genova al G8. Leggerlo tenendo conto anche della sentenza sulla Diaz può in effetti chiarire che cosa in quei giorni si è consumato, oltre alla fine di un ventitreenne di cui in questo libro si delinea una partecipata biografia attraverso gli occhi di chi lo ha conosciuto. E sempre sul G8 si sofferma ZeroCALCARE, l'unico in mostra in veste propriamente autobiografica, quale testimone giovanissimo dei giorni di Genova. Il suo tratto fumettaro non cancella l'intensità di chi presenta la propria storia, il fatto di essere stato presente in carne ed ossa e ora ripresentare gli eventi: sappiamo bene quanto di antistorico possa esserci nei testimoni diretti della storia, eppure in questo tempo di Realityzzazione della vita, un po' di realtà senza finzione mediatica non guasta.
E così anche in Yeti di Alessandro Tota che chiude la mostra ritroviamo lo spaesamento di dover raccontare qualcosa di irrimediabilmente legato al nostro vissuto, alla propria storia di vita, quella nello specifico di un giovane che parte alla volta della miracolosa Parigi e incontra le difficoltà del precariato, del relativamente diverso: e come raccontare una storia così senza diventare narrativamente fragili? Ecco dunque Yeti, il barbapapà del nuovo millennio, luminoso, morbidoso, eppure scomodo: una figura che rientra nella sfera della tenerezza, come la categoria dei “giovani” di cui tutti si riempiono la bocca, che tutti vorrebbero aiutare, supportare e comprendere. Il suo aspetto dolce non gli impedirà di vivere la distanza, di riempire il vuoto, di trovare lo spazio che lo accolga nella strana brezza che oggi aleggia in questa strana Europa, consolante, ma non certo accogliente.
In questa Europa quindi piena di nuovi fantasmi che corteggiano quelli vecchi, sempre pronti ad uscire dagli armadi, c'è una New Wave italiana, che nella rinnovata energia del fumetto internazionale, che vede il fumetto sperimentarsi in modalità che prima non erano mai state tentate e che sembra uscito definitivamente dalla fase dell'infanzia, si presenta con dei caratteri peculiari propri. Case editrici che si dedicano pionieristicamente alla produzione esclusiva di fumetto di realtà, contaminando anche i grandi editori (vedi ad esempio Rizzoli – Lizard e Mondadori), giornalisti e ricercatori che si cimentano nella sceneggiatura, indagini vere e proprie che prendono la forma di sequenze. Un post realismo che si manifesta in un'Italia che sembrava aver preso una piega irrazionalistica e burlesque, e che credo abbia ancora molto da raccontare e disegnare.
1J. F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Milano 1981.
2M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Roma Bari 2012
3Concetto centrale dell'interessante riflessione di Ferraris nell'op.cit.
4 'L'eroe dei due mondi' di Guido Manuli (1994), film d'animazione con forte intento didascalico di un disegnatore, regista e sceneggiatore che aveva collaborato a lungo con Bozzetto e con Nichetti.
5Furio Colombo, L'Olivetti dei sogni perduti, su Il Fatto Quotidiano, 27 novembre 2011.
6Alex Boschetti e Anna Ciammitti, La strage di Bologna, fumetto con prefazione di Carlo Lucarelli. Becco Giallo 2006
7Marco Peroni – Riccardo Cecchetti, Il ribelle granata, Becco giallo 2010
The obsessive normality of being special
Komikazen 8° Festival internazionale del fumetto di realtà, Ravenna 2012

The obsessive normality of being special.
Wake up! Leave your infancy.
Immanuel Kant (1784)
If we had to find a lowest common denominator in attempts to represent and recount the History of Italy we could say that it lies in having continual recourse to the category of exceptionality. The exception of having become a nation state considerably late in life and without a shared language, the exception of the south, the exception of the mafias, the exception of bomb outrages, the exception of the Italian Communist Party and other such pleas. In considering itself special the normality of Italian historiography and its offshoots takes shape. I mean the forms of historical narration which may be traced back to the desire to narrate History but which employ forms different from scientific research. Such as comics.
Literature and the arts have often shored up the drift of a historical reality which apparently cannot be handed over to the present: from the verism of Verga and De Roberto to the literature of reality and the neorealism of the cinema there is a thin line that links these expressions. In all, the aphasia, the impossibility of recounting the exceptionality of Italian history, was turned into a trace that vindicated the possibility of taking the floor, of representing Italy without the aid of idealism, tradition, and without suspicion of science and technique. These three ingredients, idealism, tradition and mistrust of science are de facto the three ingredients we find in much of our country’s cultural production. There have been however models and choices that have kept their distance therefrom, even if they did so by remaining themselves the exception.
Even the brief end of the century had delivered us into another narrative landscape: with the demise of ideologies, of the “grand narratives”1, the postmodern condition had turned into a permanent condition, perhaps unawares, but actualised precisely in the reality which it refused itself to acknowledge. The theories that had animated intellectual circles, filled the bookshops of the upcoming cognitive unemployed, had become the weapon with which mediatic populism was preparing itself, from Bush to Berlusconi and Putin, to become the new system. A system which envisaged no alternatives and was based on the assumption that the real world is a fairytale and that the future is already here only we don’t see it. And there is no sense in seeing it because reality is an opinion and as such can be expressed on a talk show but cannot be verified. The political and social realisation of the postmodern2 was manifested by what the postmodernists had only thought; and art in its various forms became the interpreter of this vision.
The comics of those years also stumbled into cultural and artistic relativism, experiencing in fact a period of redefinition, repetitiveness and retreat that seemed almost to mark their end. The world of the 80s was over and nobody knew what the new future would be or if it would arrive. It nevertheless happened that the incorrigibility of the real3, meaning its being there even if we contentiously do not want to know it or believe that we cannot grasp it or that it simply does not exist, returned to the artists’ pencils, especially those of the new generation, infecting their cartoons and becoming the sign that distinguished much of their production. Not that the world of the fine fairytale does not exist: indeed anybody who frequents the big comics trade fairs cannot fail to be dumbfounded by the bursting transvestism of the cosplayers, role game enthusiasts, hordes of young and not so young people fascinated by the pop ideology of the mythologizing of representation. Of course in this field there’s also a huge market and an economic fallout that is hard to quantify. And yet. And yet the new does not lie in this phenomenon, easily assimilable to other forms of entertainment that range from Disneyland and its emulators to fake mediaeval festivals. But the element of novelty and reconstruction of the medium came from the birth of the so-named Graphic Novel, which may be recognisable substantially by the change in format from comic to the more traditional book, and in particular for Italy by the proliferation of narrations of stories of reality arising both from classical episodes of national history, especially recent, and narrations of micro-stories singular for the reconstruction of a history of the excluded. And the encounters between stories and authors may be surprising.
And surprising indeed is the encounter between a Risorgimento hero like Garibaldi, by now high-flown and frozen in marble statues where pigeons flutter and adolescents kiss, and Tuono Pettinato, whose nom de plume (Well-combed Thunderclap) already certifies his delightful irreverence. Garibaldi isn’t new to these encounters, he’s already had to do even with animation4 and plenty of films. He’s one of the most important icons of the idea if Italy who was very soon transformed into a name that recalls the thing itself without need of going farther into it. Tuono’s approach, which deliberately demythicizes yet without creating a caricature, also has explicitly educational intentions. Garibaldi’s defects and limitations are highlighted, restoring humanity to the busts and commemorative plaques that frame him like a stone in our memory. And the dramatic Giuseppe Palumbo has also come to grips with the Risorgimento: an artist from whom we might expect the risk of laying hands on the part of History that is most mistreated and least beloved in schoolbooks. Palumbo’s sign, which becomes dazzling and melancholic when he frees himself from the constraints of series production, suits the thoughtful reflection of his approach to the narration of origins. An approach we also find in the story dedicated to the poet-mayor Rocco Scotellaro, in which the theme of origins intersects with the biography of Palumbo himself.
Paolo Bacilieri with Sweet Salgari also moves on the ambiguous borderline between narration of the other and of self: the biography of the great adventure writer, still today one of the five Italian authors most translated worldwide, who wrote of seas and mountains while never leaving his home, is a sort of alter ego for Bacilieri who however does not avoid philological representation of the newborn Italy which a few years later would be soaked in the blood of the First World War. From the conscious yet nonetheless dramatic end of Salgari to the biography of another who lived in Italian literature as a nomad, a dispersed and alienated figure: Rocco Lombardi and Simone Lucciola have produced a Campana which, in the figurative tension supplied by the style of Lombardi’s engravings, carries the singular trait of dedication to the word that sculpts the soul.
Ultimo. Storia di ordinaria guerra civile [Last. Story of ordinary civil war] by Gianluca Costantini, Andrea Colombari and Saturno Carnoli, deals with the tragic epilogue to the Second World War which someone has defined as “civil war” and not only war of resistance: the aim of this book is the recovery of a repressed story, of the murdered dead “mourned by no one” because they were troublesome to both sides. It deals with the killing of Leandro Arpinati, a very well known member of a fascist action squad, and his childhood friend Torquato Nanni, socialist and antifascist. Costantini also drew Cena con Gramsci [Dinner with Gramsci], taken from a theatre text and therefore an interesting adaptation from stage to pencil.
The life of a man and his legacy lie at the heart of Pietro Scarnera’s Lo scrittore necessario. Una biografia di Primo Levi dal 1946 al 1987 [The necessary writer. A Biography of Primo Levi from 1946 to 1987]: a programmatic title, bringing together only a portion of the years, the lesser known ones or those not directly narrated by Levi.
And once again at the centre of the narration, the life of a man who carved out a piece of Italian economic and cultural history at the height of industrial recovery: Adriano Olivetti. Un secolo troppo presto [Adriano Olivetti. A Century Too Soon] by Marco Peroni and Riccardo Cecchetti already in its title somehow reprises the historiographic interpretation of Eric Hobsbawm who sets the historical reality of the twentieth century from 1914 to 1991. Furio Colombo5 called it perhaps the best contemporary political text and in this imaginary interview the space of investigation is re-conquered by means of a narrative form which previously demonstrated its fertility in Toffolo’s Pasolini. Un incontro [An encounter]. The possibility precisely of setting out from the encounter with history to go over steps and ask for truths, to open avenues in search of answers.
This interweaving of time planes, present and past, in an ongoing dialogue that directly stages the implementation of historical research, also characterises the felicitous In Italia sono tutti maschi [In Italy They’re All Males] by Luca De Santis and Sara Colaone. A collective and at the same time contingent story of the homosexual community interned under fascism, the centre of the narration is silence, dismissal of the memory of detention and authoritarian moralism. Colaone returns to individual stories that become collective with Ciao, ciao bambina [Bye-bye Little Girl], which grew out of the wish to put together her own family history of emigration. It finds its strength precisely by stepping outside biographism and becoming an exemplary tale that speaks of a Country which has become many Countries, quickly forgetting however just how hard it is to leave. Palacinche. Storia di un esule friulana [Crepes. Story of a Friuli Exile] by Caterina Sansone and Alessandro Tota also grew out of situations all in all similar: Sansone’s family experience, the need to recover a tangle of words, images and individual stories in order to reconstruct if possible the frame of a repressed collective history, that of the Istrian exiles. A piece of history with which, for reasons that are ideological and linked to its time, it is still hard to deal and which reappears through the use of madeleines: music in the case of Colaone’s book, crepes and therefore food in Sansone’s journey back.
With Il mio Vajont [My Vajont] by Marco Pugliese and Paolo Cossi we face instead an event which has become, thanks in particular to Marco Paolini’s theatre narration, an almost paradigmatic episode of our country’s stories of catastrophes, of its abnormality: the two authors, Cossi in this case as scriptwriter and Pugliese as drawing artist, have produced an urgent work, of the present, which does not overlay historical reconstruction but aims at verifying what there is today in the valley of disaster where 1,917 people died.
Space that is still inhabited, the community that was there with the bit-actors, childhood memories that intersect with capital H History: this is the living material of Davide Reviati’s Morti di sonno [Dead from Tiredness]. The use of the child’s eye dilutes and apparently masks the sense of loss of a world, the workers’ quarters of the 60s and 70s which constituted the new urban village in place of the rural one that the workers came from, yet without traditionalist nostalgia. A history which precisely due to its being only covertly autobiographical succeeds in telling the many stories of these communities.
Circumstantiated by and bound to an event that became the subject of songs, slogans and films, Pinelli e Calabresi. Una storia sbagliata [Pinelli and Calabresi. A Mistaken Story] by Bepi Vigna and Mattia Surroz sets itself the task of independently interpreting the episode that marked the beginning of the ‘years of lead’. The two main figures, the anarchist railwayman and the police superintendent, became victims and symbols of a period which has yet to be either ratified or told with historical truth. Well, never mind that Italian cinema versions of the years of lead seemed unresolved, and the Pinelli and Calabresi affair in its dichotomy, in its being easy to manipulate from a symbolic viewpoint, was taken on as an icon, but it is also particularly risky.
Piazza della Loggia. Non è di maggio [Piazza della Loggia. It isn’t like May] by Francesco Barilli and Matteo Fenoglio is a work that reprises their previous experience with a book on Piazza Fontana: to recount history, knowing that it is not always from the court’s sentence that the truth emerges. Because the path of justice follows strange and contorted routes, whereas the facts by now are certain. Although there are no guilty parties, because all the accused were acquitted on appeal, this does not mean that we do not know who were responsible for the 1974 bomb outrage in Brescia. With this intention a job of actual historic reconstruction through consultation of archives, direct reading of trial material, interviews with witnesses and survivors, led to the creation of this book, which is only volume 1 of the authors’ research.
And there are no less than two works on 1978, symmetrical because the lives of the two protagonists ended on the same day with alchemical precision: Peppino Impastato. Un giullare contro la mafia [A Minstrel against the Mafia] by Marco Rizzo and Lelio Bonaccorso and Il sequestro Moro [The Moro Kidnapping] by Paolo Parisi. The first book aims at recovering Impastato’s humanity, his nonconformist attitudes, and at reconstruction of the young activist’s personality, whereas Parisi’s has a more suspended and less documentary slant. Concentrated on the labyrinth of reasons of the “mad splinters”, on the apparent end of a season of fire that returned with the D'Antona homicide, it employs different time levels, creating an interweave that leaves many avenues of interpretation open.
Ustica. Scenari di Guerra [Ustica. Scenarios of War] by Leonora Sartori and Andrea Vivaldo takes us once more into the putrid maelstrom of so-called Italian mysteries. Reprinted for the thirtieth anniversary of the outrage the book follows with delicacy, but also with clarity, the various investigation hypotheses. Certainly one of the most disarming aspects of Italian abnormality is that though it took place only 35 days afterwards, nobody at the time related the Ustica outrage to that of Bologna. Andrea Laprovitera and Andrea Vivaldo with Il treno [The Train] set out precisely from the bombing of 2nd August 1980, with which Boschetti and Cimmitti6 have dealt, but the former have chosen a more deliberately cinematographic narration, interweaving three events that begin in 1968 (and alas they do not help to alter the still reigning confusion about the matrix of this outrage) and find an effective coup-de-scène closure with that dramatic day at Bologna station. The idea of the need for a political balance, which recalls the conformist assumption of the need for “two voices always present”, in a situation which had a judiciary epilogue that included a sentence, seems somewhat centrifugal, even though it was not possible to clearly identify the instigators: nevertheless, if one reads the list of names of those condemned for putting the police on the wrong track, it is not hard to reconstruct the history (not the legal question) of this series of events.
Il caso Calvi [The Calvi Case] by Luca Amerio, Luca Baino and Matteo Valdameri comes under the bedlam of noir mysteries that unfortunately infest the pages of Italian history, and not only over the last century. The apparent suicide under Blackfriars Bridge in London had all the features of a genre film, yet reality had once more exceeded fantasy. The complexity of the material involved in the suicide banker’s biography did not scare the authors off: with great humbleness they have brought forth a piece of history, digging in the multiform material regarding finance, P2, Vatican, politics and those who at the time wanted to close their eyes and ears.
And we return instead to the massacred south with Pippo Fava. Lo spirito di un giornale [The Spirit of a Newspaper] by Luigi Politano and Luca Ferrara. A southern Italy which provides the setting for a considerable number of Graphic Novels produced in recent years and which, unfortunately, does not cease to be the background against which the evils of Italy play out a sort of mortal bullfight. The courageous journalist of the paper I siciliani, killed in 1984, aroused the passion of Politano, he himself a journalist who still believes in seeking the truth: at a time when the son Claudio Fava is a candidate for governor of Sicily, it is not out of place to once more recall the father, to open the wounds and the questions on the reasons behind this unbalance, more moral than political.
Antonino Caponnetto. Non è finito tutto [It isn’t all over] by Luca Salici and Luca Ferrara and Un fatto umano. Storia del pool antimafia [A Human Fact. History of the Antimafia Pool] by Manfredi Giffone, Fabrizio Longo and Alessandro Parodi take their place in this reconstruction, loving, tenacious and tough, of the story of those who stood up against the inevitability of the mafias. The title of the first book references magistrate Caponnetto’s words – It’s all over – as he left the morgue where he had just seen the destroyed body of Borsellino: following his distress at the murder of Falcone and Borsellino, Caponnetto in point of fact did not give in but chose the road of spreading awareness, of dialogue with the young generations, to keep not only memory alive but also and above all civic conscience. Still on the subject of the Antimafia pool, but with a slant that is more philological and at the same time interpretive, is the work of A Human Fact: fruit of considerable research in the field and a choice that reflects the intentionality of semiotic intervention on the sign (which is to say the choice of representing the figures of history by means of animal faces, almost as if to say “this is our Maus, this is the hot material of our memory”), the voluminous job on the script by Giffone is also one of research and collation of sources.
Then came twenty years of Berlusconi: of this period, still balanced between past and present, Riccardo Mannelli X-rays the anthropological mutation: it isn’t a humorous work of comment on the news but rather a drawing and word that become a tool of information and, above all, of analysis. In this sense his satire may coexist with the book-format narratives in the exhibition. Also because nobody has so far dared to leap onto the slippery slope of the world’s most famous Italian premier.
Apparently out of the running, but nonetheless dense in unresolved aspects, the disturbing end of an Italian cycling myth is the fulcrum of Gli ultimi giorni di Marco Pantani [The Last Days of Marco Pantani] by Marco Rizzo and Lelio Bonaccorso. Based on the investigative book by French journalist Philippe Brunel, it raises doubts, perplexities and unclear points: here we have a mixture of mythology and the social importance of sport in Italy, especially cycling (together with soccer of course, and this reminds us of Il ribelle granata on Gigi Meroni7) with the theme common to many of these works, which is to say the inability to know the truth. And again we find Marco Rizzo, together with Nico Blunda and Giuseppe Lo Bocchiaro, in the project dedicated to a figure who truly passed through various phases and contexts. They recount a good slice of Italy between the 70s and the late 80s in Mauro Rostagno, prove tecniche per un mondo migliore [Mauro Rostagno, technical rehearsals for a better world: the biography of the eclectic and tireless Rostagno ranges from the founding of Lotta Continua to the creation of Macondo, one of the first autonomously run social centres in Italy, from the Saman community in Sicily to his death at the hands of the mafia.
And here we are, crossing the threshold of the new millennium which already smells of end: Carlo Giuliani. Il ribelle di Genova [The Rebel of Genoa] by Francesco Barilli and Manuel De Carli marks the end of the relationship of conflict, while still maintaining dialogue, among a multiform movement with many souls like the anti-globalists that met in Genoa for the G8 summit. Reading it while also taking into account the verdict on the Diaz School may in effect clarify what took place during those days, over and above the death of a twenty-three year old whose shared biography is set out in this book through the eyes of those who knew him. Again on the G8 summit, the only strictly autobiographical participant in the exhibition is ZeroCALCARE who was a very young eyewitness of those days in Genoa. His comics artist’s stroke does not cancel out the intensity of someone presenting his own story, the fact of having been there in flesh and blood and now re-presenting the events: we well know just how much of the anti-historical there can be in direct eyewitness accounts of history, yet in these times of the Realityzation of life, a bit of reality without media fiction does no harm.
Thus also in Alessandro Tota’s Yeti, which closes the show, we once more find the bewilderment of having to speak of something irremediably linked to our living experience, our own life story, in this specific case that of a young man who sets out for miraculous Paris and runs into the difficulties of the precarious, of the relatively different: and how to tell such a story without becoming narratively fragile? So behold Yeti, the Barbapapa of the new millennium, bright, soft and cuddly yet troublesome: a figure that comes into the sphere of tenderness, like the category of the “young” whom everyone spouts about and wants to help, support and understand. His sweet appearance will not prevent him from living the distance, filling the emptiness, finding the space that welcomes him in the strange breeze that stirs today in this strange Europe, consoling but certainly not welcoming.
In this Europe then, full of new ghosts that pay court to the old ones, always ready to emerge from the cupboards, there’s an Italian New Wave which, in the renewed energy of international comics, with comics experimenting in ways never before attempted and seeming to have definitely left their infancy behind, steps forward with its own singular features. Pioneering publishers who devote themselves exclusively to the production of reality comics, also infecting the big publishing houses (for example Rizzoli Lizard and Mondadori), journalists and researchers who try their hand at scripts, actual investigations that take the form of sequences. A post-realism manifested in an Italy which appears to have taken an irrationalistic and burlesque turn, and which I believe still has much to recount and to draw.
Elettra Stamboulis
1J. F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Milan 1981.
2M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Laterza Roma-Bari 2012
3Central concept of the interesting reflection by Ferraris in op. cit.
4 'L'eroe dei due mondi [The Hero of Two Worlds]' by Guido Manuli (1994), animated film with a strong educational intent by an artist, director and scriptwriter who had long collaborated with Bozzetto and with Nichetti.
5 Furio Colombo, L'Olivetti dei sogni perduti, in Il Fatto Quotidiano, 27 November 2011.
5
6Alex Boschetti and Anna Ciammitti, La strage di Bologna, comic with foreword by Carlo Lucarelli. Becco Giallo 2006
7Marco Peroni – Riccardo Cecchetti, Il ribelle granata, Becco giallo 2010
Lo strabismo dell'altro
testo in “Cairo Blues”, Giuda edizioni (2012)

Rappresentare l’altro è uno di quei temi che ha interessato l’arte del novecento e messo a dura prova quella del nuovo millennio.
L’Altro, come diceva Lévinas, venendoci incontro ci “espelle” dalla nostra solitudine.
Le storie di Creanza ci impegnano all’incontro, all’andare verso l’umanità dell’altro, che esce dalla sua porzione di anonimato, dal suo essere “l’egiziano”, la “donna velata”, il “giovane”, e diventano volto e sguardo che si interseca al nostro guardare. I frammenti di vita quotidiana che con tratto realistico compongono questo blues, termine che non connota un sottofondo musicale, formano un quadro che non aspira alla frigida oggettività, ma alla poetica vicinanza.
Il blues prende il nome dall’espressione “avere i diavoli blu” per esprimere un senso di tristezza e profonda malinconia, ed è una musica detta anche stonata. Come stonate sono le visioni di Creanza, fuori dall’immaginario precotto di media che cercano lo spettacolo e l’effetto emotivo facile; accordi stonati come la storia sulla minoranza copta, tema scottante e sospeso, che viene presentato in modo funzionale ad ideologie di sistema in Europa, e che diviene invece attraverso questa breve storia un pezzetto comprensibile, attuale, con visi e occhi. Stonato è sbagliarsi nella metropolitana e andare come “uno stupido turista” nel vagone riservato alle donne.
Con il suo sguardo “strabico” Pino guarda con empatia, ma anche con una distanza partecipe, un paese che è tuttora sconosciuto ai nostri connazionali, che non vedono nulla oltre alle piramidi e ai fondali del Mar Rosso, turisti gated community, non molto diversi dalle comunità chiuse dai cancelli dei nuovi businessmen egiziani. E ne coglie con grande sintesi elementi di contraddizione, cartografando le pulsioni nascoste. Queste radiografie visive hanno dimostrato quanto lo strabismo della curiosità sia una specie di qualità mantica.
Così nella storia “Kifaya”, pubblicata nel 2010, Creanza evidenziava lo stridente contrasto tra interessi comuni dei poteri forti egiziani e americani, la banalità dell’occidentalizzazione globalizzante e l’utilizzo degli stessi mezzi per ritrovare la propria voce del popolo del dissenso. All’epoca, ovvero neanche un anno fa, gli osservatori prezzolati di questi paesi non prevedevano cambiamenti in atto, parlavano quasi con stima di Mubarak, considerandolo un “filoccidentale democratico” contrapposto ai fondamentalisti. Eppure, sono bastati pochi mesi per ribaltare completamente la situazione e far vedere il marcio che bolliva sotto l’aura di apparente legittimità politica. L’autorità che si sorregge sull’autoritarismo spesso è mascherata di una parvenza decorosa; utilizza rituali comuni e nasconde nella procedura democratica l’assenza di valori democratici come la difesa delle minoranze, la coesistenza con il dissenso, il ricambio generazionale e sociale. Tutti ingredienti assenti nel paese del generale deposto, e che purtroppo latitano anche alle nostre latitudini.
L’efferato omicidio della pop star libanese Suzanne Tamim nel 2008, che ha interessato la stampa ufficiale e scandalistica di tutto il mondo arabo per circa due anni è un episodio che evidentemente fa venire “i diavoli blu”. Ha scosso l’opinione pubblica, è stato utilizzato come calmiere sociale per dimostrare che la giustizia esiste anche per i potenti, ha messo in discussione indirettamente il movimento contro la pena di morte in Egitto. L’epilogo, che ovviamente non compare nella storia di Creanza perché scritta prima, la dice lunga. Il potente imprenditore e affarista incriminato alla pena capitale non è stato sentenziato per un vizio di forma ed è stato condannato a 15 anni di reclusione. Pare che durante le rivolte del 2011 sia riuscito ad evadere di prigione.
Così aspettiamo il secondo episodio di questa storia paradigmatica e struggente, che porta in sé tutte le pillole del foiletton, purtroppo tragicamente reale. Successo, affari, politica, amore, gelosia, sangue. Quello che rimane sono le parole “I will not shut up” di una nota canzone della Tamim e che è anche il titolo della storia di Pino: “non starò zitta”, parole che suonano profetiche per la scelta di alzare la voce di tante giovani nelle piazze del Cairo.
Del buon uso del tradimento
Pubblicato sul catalogo del Festival Comicon, Napoli (2012)

Giuda indaga il tradimento delle immagini. Lo fa con animo dark, ma ottimista. C'è nel tradimento un aspetto sotteso, importante, non negativo: il suo denunciare la possibilità
dell'interpretazione soggettiva, del segno che restituisce una realtà che è rimasta fino ad allora inesplorata. Nella radice di tradire c'è anche il significato di tramandare.
Giuda si pone come obiettivo implicito il denunciare attraverso la propria esistenza che resiste alla targettizzazione, al prodotto, al merchandising, al mercato, alla distribuzione,e a molte
altre cose, la posizione di privilegio che nel tradimento ha il disegno. Un tradimento che fa buon uso della mano di chi lo guida: in opposizione alla falsificazione ipocrita della fotografia o
del reportage che non ammettono, se non indirettamente, la propria limitata visuale, la rappresentazione disegnata si costituisce innanzi ai giudici della credibilità e dichiara con innocenza
l'autore della nuova cosa, il disegno.
Che è la cosa. Ma è anche altro. Così questa rivista, che fa della figurazione narrativa la propria materia di lavoro, si oppone con intransigenza e candore al format. È affascinata dalla geografia, dal suo essere la mappa concettuale di un territorio che racconta storie. La Geografia, materia non a caso scomparsa dalle aule di scuola, perché intimamente sovversiva, nel suo essere un magma di tanti saperi, storia, economia, tradizioni popolari, scienze e soprattutto disegno. Giuda si innamora di mappe dimenticate, che rappresentano a loro volta cumuli di storie sotterrate (non a caso il primo numero saccheggia il cimitero di Montparnasse, ricostruendo una sequenza narrativa di microritratti degli illustri ospiti di questo quadrato di Parigi) senza però ammalarsi di necrofilia. È più una sorta di rivolta contro l'astrazione, la piccola sensazione, il narcisismo ombelicale, che a tratti occupa molta della produzione disegnata europea. Nella ricerca di confini nuovi da esplorare attraverso il disegno, conta il mosaico collettivo che nasce da una rivista che vede operare un gruppo fisso di disegnatori e un ospite, su un terreno comune, uscendo dalla gabbia della storia autoconclusiva, o a puntate, ma che indaga dove il genere nuovo e incandescente della nona arte può arrivare. Un tentativo indagatore sui processi memoriali nella costruzione di sequenze. Una cosa ben diversa dalla costruzione della sequenza narrativa tradizionale. La memoria non opera in senso lineare, concatenando in modo logico e comprensibile gli eventi, tra un prima e un dopo. Giuda segue un movimento territoriale, ma anche il movimento centrifugo del processo di appropriazione della memoria. Il numero 2 della rivista si incaponirà sulla confraternita dei preraffaelliti, un movimento a più riprese osteggiato dalla critica d'arte, eppure ampiamente recepito nello stile (anche se non nella sostanza) da molta figurazione di genere, tra cui quella delle carte gioco o del fantasy in generale. La confraternita ispira i disegnatori di Giuda per l'aura cospiratoria che ne caratterizzò la prima parte della loro storia, ma anche per la vocazione di bricoleur, intesa in senso lato, dell'Art & Crafts, per la forte sensibilità etica e politica, che non semplificò le forme, il simbolismo spinto, l'attenzione costante per l'estetica. Perché spesso tra etica ed estetica sembra frapporsi una voragine precipitosa, quella dell'antitesi. Ovvero, se c'è etica e politica, scompare l'attenzione estetica. Mentre per i preraffaelliti, così come per il gruppo di Giuda, non c'è l'una senza l'altra. Non a caso Borges, che terminava Finzioni con Tre versioni di Giuda, evoca il lavoro di Dante Gabriel Rossetti come ultimo di una catena di pensieri e lo sintetizza con la frase “disse con musica memorabile”.
Il visionario cieco argentino considerava il futuro irrevocabile, ma non così il passato, giacché ogni volta che ricordiamo qualcosa l a modifichiamo per povertà o ricchezza della nostra memoria, secondo come la si voglia vedere.E la visione non ha sempre bisogno della retina, anche se Giuda si impegna nello sviluppo di questa parte del corpo umano.
Arrivals and Departures – Mediterranean
Published in catalog, Giuda edizioni, Ravenna (2012)
A man has to be born somewhere!
Ivo Andrić
Metamorphosis often appears as a metaphor that has remained latent for a whole lifetime and is suddenly understood in visual terms1: the metaphoric process that leads to transformation passes decisively from the visual in the context of mythological tradition, precisely in order to render rationally comprehensible something that might otherwise remain relegated to the exclusive sphere of faith. In the metaphoric process, which leads to a change that translates this latency into matter, a deep idea of crisis is implicit; the unease perceived in the transformation may be condensed into anguish, pain of loss or, more sentimentally and profitably, into nostalgia. But the mythological argument, and substantially also the artistic one, feeds on transformation and metamorphosis.
And the very notion of Europe, from which we draw to define boundaries, transitory and presumed identities, and which constitutes an imaginary embankment against otherness, has its roots in a metamorphic voyage: young Europa abducted by Zeus in the form of a white bull. A voyage whose starting point was the coast of modern Lebanon. Young Europa, unaware of the long line of abducted voyaging women who would follow her, bore in her name the etymology of “broad face, broad gaze”, which is what we who are sick in vision feed on. And it is precisely from this concept of broad gaze that our curatorial voyage set out on this arbitrary mapping of the metamorphic visions of the artists invited. But let’s begin at the beginning. From that Europa who lingered with her handmaidens to play on the shores of Tyre. There’s a great deal of irony in the mythological construction of the arché, of the narration of the first cause: the same that drives the works of many of the selected artists. A light and disenchanted irony, a play of unexplored references and queries which seeks the way to finding names and combinations that are new but feed on a nostalgia without ID card.
Precise perception of the transeunt, of the temporary and sandy consistency of the glance, of one’s own glance, which draws on the visions of others but at the same time remains forever anchored to one’s own retina, is one of the codes binding works which are evidently marked by differences and resistances to the narration of a glance that is unique and included in one’s point of view. Yet in working with a visual grammar that employs many shared references it is possible that the metamorphic process of artistic creation might lead to assonant solutions.
In inhabiting a glance we cannot preclude the space we inhabit, but at the same time the space chosen as ideal geography for this exhibition project has a sea at its centre which, antonomastically, is a place of transit and movement. A sea which we have named “the sea in the middle of the lands” but which in modern cartography is relegated, is no longer at the centre. This is why the first artistic act of “Arrivals and Departures” is a new cartographic survey by Riccardo Clementi who, with the humbleness imposed by the “broad glance”, sets the sea at the centre of his map, with its trenches and bathymetries, the white sea as it is called in Turkish (Akdeniz). Because in the act of naming there is also the act of creating, and we are reminded of this by Alban Muja, an artist from Pristina who concentrates his action on this different geography of names, running with the times, encountering places or making their bearings difficult. The dizziness of identity and naming lies at the heart of Dor Guez’s artistic inquiry which strongly features autobiographical events. In his videos and installations he returns continually to the question “Who am I? And who are you who calls me?”: the maelstrom created by the need for a category of people to exist and to know who they are in this case becomes a prison. The same identitary prison probed by Nilbar Gϋreş: the one created by perception of the female image and the female image itself, especially in a country of Islamic tradition. Gϋreş’ irreverent, sly and acute eye leaves no room for easy labels: apparel, place of the symbolic par excellence, and body, place of the human, become two favoured working materials.
In this possible geography of the irreverent glance there is space for sound devices that cancel out the physical sign, as the installation by Younes Baba Ali which, in Morse code, takes the place of the muezzin’s call in summoning the faithful to prayer; or the Carillon by the collective Orthographe, a group hard to categorise since they are constantly nomadic between experimental theatre, visual art and near-dadaist actions. In this exhibition Orthographe will be putting on a table game, inviting spectators into a playful and estranging dimension: a hybrid version of Monopoly and Snakes & Ladders (which obviously harks back to the nostalgia code, needless to repeat at this point...) in which the players are called on to resolve the enigma of Curt Cobain’s death.
On the ethicality of play as a liberating mode and indispensable cognitive tool, Adelita Husni Bey intervenes with a complex work inspired by educationist Francisco Ferrer who was executed in 1909: Ferrer’s Escuela Moderna was based on antiauthoritarianism, free expression of the individual and scientific and lay training. Aspects which constitute a leitmotif of the countries that overlook Ancona’s sea and which return in waves to question their citizens: education as liberation or coercion, quality and merit or happiness and relationship. Husni Bey’s A Holiday from Rules stands on the borderline between representation of power (or anti-power of liberating pedagogy) and the past that does not pass. Although in her active research at a Paris high school that practises today’s version of the Spanish martyr’s anarchic educational theories there is a clear desire to tackle the hic et nunc, she does not conceal a deeply nostalgic thread in the aesthetic vision, in the artistic rendering of the work. And nostalgia without memory is certainly a trait in many works. Her artistic transformation renders these options visible and recognisable, placing them in a dimension that is immediately comprehensible in the act of looking.
Powerful narrative tension emerges clearly in the collective piece TouchStories by Isabella Mara, Camilla Monga, Serena Porrati, Maria Giulia Serantoni, Domenico Stranieri and Ramona Zordini, which grew out of a workshop with Studio Azzurro: a story will save our lives and thus link up with our history. Narrators, narratees and public become one.
The breadth of the glance and its stubbornness in being intangible are also the subject matter of Clio Casadei, an Italian artist who exhibits the bare result of her irremediably lost artistic actions, and Almudena Lobera who, through drawing in particular, materialises the frustration of this impossible mediation.
There’s a progressive falling silent of artistic practice in the face of the still prevailing analysis of the postmodern and its epigones, a form of delegitimization which moreover clashes with the high number of people who may be identified by the name of artist. There is a reaction to this impasse by groups like /barbaragurrieri/group, a collective well known for its actions of sedimentation and iterations of language, and individuals that are difficult to categorise (unless by the forces of law and order) such as Ganzeer, renowned for his martyrs of the revolution graffiti project in Cairo.
A multitude of wide ranging glances characterised by powerful individual identities which cannot be hooked up to a shared movement except by the arbitrariness of the curator’s eye. So to say “Mediterranean” is an authoritarian action; better to say the multiple sea.
But in spite of these individual vocations, this probing the space of the visual with one’s own voice in the context of the wide code of the contemporary, there are several traces which guided this authoritarian act of selection. A cartographic vocation that wanted to investigate representations of the mental landscape, for example. A concept which in itself came late in our culture. What is “landscape” for us today was initially a grouping of natural forces controlled by superior forces to which man submitted. Right down to the times of Caesar and Cicero2 there was no word for it, and when the word came it would always maintain (from landscape to Landschaft and paysage) “a fundamental ambiguity between the two semantic components, the naturalistic-environmental and the aesthetic.” Meaning that landscape is in our idea of landscape, it does not correspond to nature. And being “geography transported to the moral” it enveloped the idea of a “good”, of an aesthetic positive, which is perhaps one of the traces extinct in these landscape events intercepted and retransmitted by artists such as Randa Mirza, who transfers her own questions into landscape deceptions on the existence of the townscape of a city like Beirut, or the aestheticizing Noemie Goudal in whom we find the same vocation for the fictitious scenario, the construction of imaginary symbioses between places of anthropic abandon and human figures from the memories of fable. In both cases the photographic spectre does not record, it imposes its own glance without absolution.
The predominant line in this artificial and synthetic geography has been the representation of power, understood as a device which contains fetishes and with which the artist has the possibility of dialoguing precisely by virtue of its transposition into icon, into an already naked image. Thus Ganzeer managed to preserve the murals – which represented the dead of the days of revolt in Egypt – from the purifying fury of the army by using the word “martyrs”: a word that halted the iconoclasm, arrested the anxiety to cleanse, to attack the “deterioration” (to employ a term much loved by our local purifiers). The clash between a word that speaks and that represents is at the heart of the work of Héla Lamine, who was also inspired by the Arab spring, particularly in Tunisia. In her work Nous ne mangerons plus de ce pains là she actually uses bread to reconstruct the former national icon Ben Ali, against whom the crowd chanted a slogan about bread. Power has become thing: bread that goes bad and shows putrefaction also marks the temporary nature of power. The hourglass has run out, irony remains in re-chewing words that become objects.
Explicit in Mary Zygouri’s triptych is the metaphorical matching of animal/political – animal/poetic. The animal’s unpredictable reaction is startling for the spectator: the connection possibility of the event establishes a nexus of responsibility and skill. If the animal is unpredictable, might not man also be? Is there a prescribed and taken for granted fate, as is actually outlined today in the economic measures undertaken by delegitimized governments, but acting in virtue of this hypothetical predestination of the act? Zygouri acts as devastator. She does not bring answers but permits the suspension of the predictable. The anaesthesia of vision is replaced by the synaesthesia of action. Yael Plat interacts with the spectator through direct provocation towards political action: No Entry leaves no room for ambiguity. The door is closed to all the named categories, even to you who are reading the writing.
A protagonist of change and also an inquirer into the forms that power assumes and that involve those subject to it, Wafa Hourani uses ironic forms to transpose history into pop metaphor, the history of a people substantially imprisoned and obliged to exile in their own land which has by now been worn down by mediatization. Slave to a past that does not pass, to a geography that interweaves power and bodies, Borjana Mrdja examines the breakdown and recomposing of the Bosnian frontiers, transferring the borderline onto the wound of her own hand, which is also subject to the wear and tear of time. A wear and tear which Bisan Abu-Eisheh attempts to resist by containing – by means of museographic and classificatory tension – the dispersion of the dust of the vanquished: for three years he collected the rubble of demolished houses in Jerusalem owned by Palestinian families and set it in a museum. Recomposing memory is one of the most latent anxieties of our contemporaneity, destined to an ethical Alzheimer’s, to a murmuring forgetfulness.
Thus also Zoulika Bouabdellah who, in drawing up sumptuous and ironic representations of the geographies of female commonplaces in the Arab world, does not shrink from the illness of memory recovery in the form of ethical nostalgia, in works like Genie Lady, inspired by a sentimental Arab cult movie of 1948, redesigned with evident ironic references to the Orientalist tradition. Nostalgia for the future is found in the work of Danilo Correale who touches on a city – Istanbul – which reappears in many biographies and productions of these migratory artists.
Naming and dreaming, the possibility of controlling the imagination and everything pertaining thereto through attribution of a name, and the loss of control through oneiric activity (or perhaps its acquisition in more interesting forms...): these are the questions that involve artists such as Jovana Komnenić, with her Book of Dreams, and are also traceable to Goudal. The step to Almudena Lobera, seeking manuals for mental places, is a short one: in her images of sober and suspended beauty, from this exercising of visual synthesis that is not closed to aestheticism, there emerge series that amaze with their philosophic cleanness and expository clarity. The drawing of a tree does not portray a tree but a tree that is observed3: the mental place is not shown but its observation is. Thus Mito Gegič re-evokes observation as method of interpretation in the digitalisation of a classically pictorial subject, in the apportioning of an image of hunting and hunters, animals destroyed and turned into still lifes against their will.
Tiberi, Strappato and Nicolai, different in codes and references, take their place in the project Porta Pia – Open Academy, as mirrors of the glance, cultivators of the apparent abandonment of places: rather like guides of vision, without however a predetermined aim but, to quote Alex Langer, leapers of walls.
And so we come back to the origins, to the wide gaze of Europa: the appearance of this journey of love cannot remain silent about the misfortunes her abduction brought about in subsequent stories. Pasiphaё, the Minotaur, Ariadne seduced and abandoned are only the first defeats of apparent harmony in the vision of this sea where the idea of Europe was founded, which for political and economic reasons would then shift its centre of gravity farther north, and then west and now – who can tell? – perhaps to the east. None of the invited artists believes in the apparent and sweetening ideology of a reconciled Mediterranean. Some concentrate on stating it through their art, others denounce it in their reticence about naming the country they were born in. In some cases the country’s name has changed: so it is not in political geography that we may find a line, since it deceives, but in the geography of poetics and questions, in momentary stylistic intermingling that denote a background in which, though noisy and acoustic, the figure has become background. The electronic environment has overturned point of view, no longer private, no longer comprised in one’s own point in time but immersed in a flow, with instantaneous access to all pasts and futures, in which one’s own point of view becomes irremediably irrelevant: and it is therefore in this resistance to volatilisation of the self that the identified traces link up and find a possible efficient cause. The need to classify, to map out and preserve is an artistic device with strong ethical connotations, a medicine to stem the dominant ideology of the substantive “present”, of the “necessary choice”.
Nilbar Güreş
Published in catalog Arrivi e Partenze_Mediterrano, GIUDA edizioni (2012)

Sono sport sconosciuti quelli che praticano le donne per sopravvivere alla quotidiana erosione di possibilità, agli infiniti ostacoli che una società profondamente maschilista ha prodotto nei millenni.
La verve ironica, e a tratti comica, è vivida e inequivocabile.
Per le moderne Dee Kali dalle mille braccia il fitness non è inteso come il processo di mortificazione del corpo a cui si sottopongono in molte per corrispondere ad ideali modelli di una femminilità plastificata, ma piuttosto è l’olimpionica abilità di coniugare identità, aspettative, impegni e ruoli ogni giorno. Unknown Sports, come molti altri lavori dell’artista turca, non necessita di particolari sottotitoli. Parla un linguaggio iconico immediato, anche se stilisticamente ineccepibile. L’esposizione pubblica, la teatralità accentuata, la ridondanza da soap opera (è la stessa storia signore, ma raccontata da più protagoniste) crea un tableau vivant in cui in posa c’è la femminilità quotidiana, reale e tangibile. Lo spazio sconosciuto evocato dal titolo e che diventa pubblico, esteso, surreale, è l’invitato di pietra. Ad esso il ruolo di sipario strappato che inevitabilmente mostra qualcosa che di norma si vuole celare dietro la tenda.
La versatilità di Güreş, che utilizza fotografia, disegno, video e collage, non deve ingannare. Il punto di vista è focalizzato, concentrato e la poetica coerente. Il centro propulsivo del suo multiforme lavoro, che l’ha portata in poco tempo ad una presenza qualitativamente significativa a livello internazionale, è la decostruzione dei luoghi comuni, degli stereotipi e delle mappe codificate che definiscono l’identità politica, culturale e di genere. Dagli interventi performativi, che la vedono protagonista di azioni dirette al disegno, la vulnerabilità delle maschere sociali è il centro ideale della ricerca di quest’artista che sottolinea attraverso “ la grammatica dell’ironia e della comicità involontaria”, come scrive Başak Şenova,
“la brutalità della vita”. In questo scrutare da una serratura volutamente serrata, non c’è moralismo o preconcetto. C’è piuttosto una farsa tragica in cui è sempre possibile la caduta nel gorgo del comico, inteso in senso pirandelliano, come “avvertimento del contrario”, ovvero come contrasto tra apparenza e realtà. L’apparenza e la codifica imbalsamata, che ci viene trasmessa dell’immagine femminile nel mondo di tradizione islamica e in particolare turco, viene qui completamente capovolta, rendendoci partecipi di una femminilità che ci appartiene in quanto donne che vengono svelate nella loro comune condizione di subordinazione, ma allo stesso tempo di olimpioniche atlete del destino.
Born in Istanbul / Turkey in 1977
Lives and works in NY, Vienna and İstanbul
Selected solo exhibitions (last 3 years)
2011 Zwölf im Zwölften, Tanas, Berlin / Germany
Self-Defloration, Künstlerhaus Stuttgart, Stuttgart / Germany
Nilbar Güreş, Rampa, İstanbul / Turkey
EIKON SchAUfenster: Nilbar Güreş - Undressing, Museumsplatz 1, Vienna / Austria
2010 Nilbar Güreş: Window Commision 2010, Rivington Place, London / UK
2009 Unknown Sports, Indoor Exercises, Salzburger Kunstverein, Salzburg / Austria
Selected group exhibitions (last 3 years)
2012 Desiring the Real, MOCAB Museum Of Contemporary Art Belgrad, Belgrad / Serbia
Wie zusammen leben? Salzburger Kunstverein, Salzburg / Austria
Der Mensch der Fluß Malerei der Donauländer, National Gallery Sofia, Sofia / Bulgaria
İstanbul Modern – Rotterdam, Museum Boijmans, Rotterdam / Netherland, Zwölf im Zwölften - Tanas, Berlin / Germany, Galerie Martin Janda, Vienna / Austria
2011 Dream and Reality - Modern and Contemporary Women Artists from Turkey, Museum Istanbul
Modern, İstanbul / Turkey
Responding to the New Moon, Galerie Tanja Wagner, Berlin / Germany
1st International Photo Festival, Bursa / Turkey
Tolerabilis, Toskanische Säulenhalle im Zeughaus, Augsburg / Germany
Der Mensch der Fluss, Donauschwäbisch Central Museum Ulm / Germany
The Daily Uprising, < rotor > association for contemporary art, Graz / Austria
Austria Davaj!, Schusev State Museum of Architecture, Moscow / Russia
Tactics of Invisibility, ARTER, İstanbul / Turkey
2010 Ex-Territory, Tel Aviv / Israel
Tactics of Invisibility, TANAS, Berlin / Germany
Where do we go from here?, Secession Vienna, Vienna / Austria
6th Berlin Biennale, Berlin / Germany
Curated by, Galerie Ernst Hilger, Vienna / Austria
Starter, Arter, İstanbul / Turkey
On Paper, Stalke Gallery, Kirke Sonnerup / Denmark
Not a Lens But a Prisma, Eugenio de Almeida Foundation, Evora / Portugal
The Others, Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia
Derriére le rideau, une génération hors d’elle …, Ecole des Beaux-Arts, Paris / France
Tactics of Invisibility, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Vienna / Austria, Ankara-Vienna, Gallery Nev, Ankara / Turkey
www.nilbargures.com | http://www.rampaistanbul.com/artists/nilbar-gures
Nilbar Güreş
Published in catalog Arrivi e Partenze_Mediterrano, GIUDA edizioni (2012)

Unknown sports are the ones practised by women to survive the daily erosion of possibilities, the infinite obstacles that a deeply male chauvinist society has produced over the millennia.
The ironic and at times comic verve is vivid and unequivocal. For modern Goddesses Kali of the thousand arms, a fitness workout is not understood as the process of mortifying the body to which many submit in order to approach ideal models of plasticized femininity: rather it is the Olympic ability to conjugate identities, expectations, commitments and roles day after day. Unknown Sports, like many other works by this Turkish artist, needs no special subtitles. It speaks an iconic language that is immediate, although stylistically beyond criticism. Public exhibition, accentuated theatricality, soap opera excess (it’s the same story ladies, but told by more protagonists) creates a tableau vivant in which everyday femininity is posing, real and tangible. The unknown space evoked in the title, and which becomes public, extended, surreal, is the stone guest which takes the role of ripped away drape that inevitably displays something normally intended to be concealed behind the curtain.
We should not be deceived by Güreş’ versatility in employing photography, drawing, video and collage. The point of view is focalised, concentrated, and the poetics coherent. The propulsive centre of her multiform work – which has taken her in a short time to a qualitatively significant presence at international level – is the deconstruction of commonplaces, of stereotypes and of the codified maps that define political, cultural and gender-related identities. From her performance interventions, in which she takes direct actions, to her drawing, the vulnerability of social masks is the imaginary centre of this artist’s research. Through “the grammar of irony and of involuntary comicality,” writes Başak Şenova, she underscores “the brutality of life.” In this scrutinizing from a wilfully narrow keyhole there is neither moralism nor preconception. Rather a tragic farce in which it is always possible to fall into the whirlpool of the comic, understood in the Pirandello sense as “awareness of the contrary”, which is to say as contrast between appearance and reality. The appearance and the embalmed codification transmitted to us of the female image in the world of Islamic and in particular Turkish tradition, is completely overturned here, making us part of a femininity which belongs to us inasmuch as we are women who are revealed in their shared condition of subordination, but at the same time of Olympic athletes of destiny.
Born in Istanbul / Turkey in 1977
Lives and works in NY, Vienna and İstanbul
Selected solo exhibitions (last 3 years)
2011 Zwölf im Zwölften, Tanas, Berlin / Germany
Self-Defloration, Künstlerhaus Stuttgart, Stuttgart / Germany
Nilbar Güreş, Rampa, İstanbul / Turkey
EIKON SchAUfenster: Nilbar Güreş - Undressing, Museumsplatz 1, Vienna / Austria
2010 Nilbar Güreş: Window Commision 2010, Rivington Place, London / UK
2009 Unknown Sports, Indoor Exercises, Salzburger Kunstverein, Salzburg / Austria
Selected group exhibitions (last 3 years)
2012 Desiring the Real, MOCAB Museum Of Contemporary Art Belgrad, Belgrad / Serbia
Wie zusammen leben? Salzburger Kunstverein, Salzburg / Austria
Der Mensch der Fluß Malerei der Donauländer, National Gallery Sofia, Sofia / Bulgaria
İstanbul Modern – Rotterdam, Museum Boijmans, Rotterdam / Netherland, Zwölf im Zwölften - Tanas, Berlin / Germany, Galerie Martin Janda, Vienna / Austria
2011 Dream and Reality - Modern and Contemporary Women Artists from Turkey, Museum Istanbul
Modern, İstanbul / Turkey
Responding to the New Moon, Galerie Tanja Wagner, Berlin / Germany
1st International Photo Festival, Bursa / Turkey
Tolerabilis, Toskanische Säulenhalle im Zeughaus, Augsburg / Germany
Der Mensch der Fluss, Donauschwäbisch Central Museum Ulm / Germany
The Daily Uprising, < rotor > association for contemporary art, Graz / Austria
Austria Davaj!, Schusev State Museum of Architecture, Moscow / Russia
Tactics of Invisibility, ARTER, İstanbul / Turkey
2010 Ex-Territory, Tel Aviv / Israel
Tactics of Invisibility, TANAS, Berlin / Germany
Where do we go from here?, Secession Vienna, Vienna / Austria
6th Berlin Biennale, Berlin / Germany
Curated by, Galerie Ernst Hilger, Vienna / Austria
Starter, Arter, İstanbul / Turkey
On Paper, Stalke Gallery, Kirke Sonnerup / Denmark
Not a Lens But a Prisma, Eugenio de Almeida Foundation, Evora / Portugal
The Others, Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia
Derriére le rideau, une génération hors d’elle …, Ecole des Beaux-Arts, Paris / France
Tactics of Invisibility, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Vienna / Austria, Ankara-Vienna, Gallery Nev, Ankara / Turkey
www.nilbargures.com | http://www.rampaistanbul.com/artists/nilbar-gures
Ganzeer
Published in catalog Arrivi e Partenze_Mediterrano, GIUDA edizioni (2012)

Numerous artistic activities, hard to label under any one category, are attributable to the pseudonym Ganzeer. He produces and edits a highly popular online magazine, does graffiti, is a designer and creates fonts and many other things which he refuses to give up just to find himself “trapped by a category”, as he himself has often declared.
After coming to the attention of the public at large for his graffiti on the walls of Cairo during the days of the revolution, Ganzeer has actually never stopped. Everything interests him, from fanzines to digital art,
and in common with many others like himself worldwide he is equally good at all of them.
Arrested and then released for having drawn a tank aiming at a man on a bicycle carrying bread, he belongs to a generation of Egyptian artists who see no separation between political and artistic action. “People forget,”
he stated when he was arrested, “that the streets are people.
They think the streets are a sort of entity controlled by the official government. I feel it’s important to remind citizens that the streets are actually their own property”.
A very clear principle lies at the heart of Ganzeer’s work: there is no public art, Street Art, without a message. And this conviction goes so deep that he does not sign his own street works. The preparatory figure created for the catalogue, to be subsequently reinterpreted and exhibited on a main thoroughfare in Ancona, is in this sense explicit: a turbaned man visibly subjected to fatigue, almost resigned, with a look of atavistic weariness and a T-shirt referring to global culture, is carrying a weight or is a modern caryatid. The writing in Italian plays on the ambivalence of the site where the image will be displayed, a highly frequented underpass.
Bridges are built by immigrants, a subjugated and docile workforce.
But it also harks back to the rhetoric of international cooperation where this phrase is enunciated with persuasive and oratorical facility, and then its meaning disappears when international diplomacy and foreign policies of the various countries take action and decide.
All works by Ganzeer and other graffitists can be viewed by following
the map he created, http://ganzeer.com/cairostreetart/index.html: this map is of interest not only to tourists and spectators, because you can also see the opinions and comments of passers-by who tweet their impressions of what they have seen.
For Arrivals and Departures in Ancona he will be doing a wall in the city, adding to the open air “collection” that includes works by Blu, Paper Resistance, Ericailcane and many others.
1982 in Giza, Egypt
Lives in Cairo, Egypt
Group exhibitions ( last 3 years)
2010 Cairo Documenta - Cairo, Egypt
Noord - Mediamatic, Amsterdam, The Netherlands
Why Not? - Palace of the Arts, Cairo, Egypt
Ganzeer
Pubblicato nel catalogo Arrivi e Partenze_Mediterrano, GIUDA edizioni (2012)

Allo pseudonimo Ganzeer corrispondono numerose attività artistiche, difficilmente etichettabili sotto un’unica categoria. Ganzeer produce e dirige una rivista online molto seguita, realizza graffiti, fa il designer, realizza font e molte altre cose a cui non vuole rinunciare solo per potere essere “intrappolato da una categoria”, come egli stesso ha più volte dichiarato.
Diventato noto al largo pubblico per la realizzazione dei graffiti sui muri de Il Cairo durante i giorni della rivoluzione, Ganzeer non si è in realtà mai fermato. Dalle fanzine all’arte digitale tutto gli interessa e, come molti altri suoi simili nel mondo, riesce ugualmente in tutto.
Arrestato e poi rilasciato per avere disegnato un carro armato che punta un uomo che porta del pane in bicicletta, fa parte di una generazione
di artisti egiziani che non vede soluzione di continuità tra azione politica
e artistica.
“La gente dimentica” – ha dichiarato quando è stato arrestato –“che le strade sono della gente. Pensano che siano una sorta di entità controllata dal governo ufficiale. Penso che sia importante ricordare ai cittadini che le strade sono invece di loro proprietà”.
Alla base del lavoro di Ganzeer c’è un principio molto chiaro: non c’è arte pubblica, Street Art, senza messaggio. E tale convinzione è talmente profonda che l’autore non firma i propri lavori in strada. La figura preparatoria realizzata per il catalogo per poi essere reinterpretata per apparire su una delle arterie principali di Ancona è in questa senso esplicita: un uomo con un turbante visibilmente subordinato alla fatica e quasi rassegnato, con uno sguardo di una stanchezza atavica, con una t-shirt che richiama alla cultura globale, sta trasportando un peso oppure è una moderna cariatide. La scritta in italiano gioca sull’ambivalenza del sito nel quale l’immagine sarà collocata, ovvero un sottopassaggio ad alta frequentazione. Sono gli immigrati i costruttori di ponti, forza lavoro sottomessa e docile.
Ma è anche un richiamo alla retorica della cooperazione internazionale, che pronuncia con facilità suadente e oratoria questa frase, per poi vederne sparire il senso quando la diplomazia internazionale e le politiche estere dei vari paesi agiscono e decidono.
È possibile vedere tutti i lavori realizzati da Ganzeer e dagli altri graffitisti seguendo la mappa da lui realizzatahttp://ganzeer.com/cairostreetart/index.html: l’interesse di questa mappa non è solo turistico o per lo spettatore. È possibile difatti visionare le opinioni e i commenti dei passanti che twittano le proprie impressioni su quanto vedono.
Ad Ancona per Arrivi e Partenze realizzerà un intervento su un muro della città, che andrà ad ampliare la “collezione” all’aperto che comprende lavori di Blu, Paper Resistance, Ericailcane, e molti altri.
1982 in Giza, Egypt
Lives in Cairo, Egypt
Group exhibitions ( last 3 years)
2010 Cairo Documenta - Cairo, Egypt
Noord - Mediamatic, Amsterdam, The Netherlands
Why Not? - Palace of the Arts, Cairo, Egypt
Borjana Mrdja
Published in catalog Arrivi e Partenze_Mediterrano, GIUDA edizioni (2012)

Mrdja is a Bosnian artist who already has exhibitions and projects to her credit in various parts of the world, from Berlin to New York and Milan.
She mainly uses photography to document an artistic oeuvre created through close contact with the public and the relationship with her own body. The theme of boundary and identitary limit supplies one of the most profitable sources of her work.
Body is boundary and boundary becomes body: this is the point made by The Border, in which the wound on the artist’s hand is compared with the frontiers of Bosnia in 2010. Borders as unstable as those of a wound as it gradually changes form, diminishes and follows the passage of time. Hers is a kind of “counter-cartography”, as Claudia Zanfi puts it, which identifies the body as unique boundary, or which perhaps sees the ambiguity of physical confinement reflected in the ambiguity of corporeal limit: a boundary continually under discussion, brought into play, redrawn, with real or invisible barriers, by hands that take no account of the scars. Human geography becomes an actual map reflected on a body, her own. The state of exception, as Agamben defines it, becomes the subject represented by this work, which draws its greatest force from synthesis and from the simultaneous possibility of rising to the perfect symbolic form of the Bosnian situation.
In Artists at Work, part of the INTRADA/modes of speech project curated by Karin Rolle, the encounter between the Bosnian artist and the Germans with whom she collaborated led to the creation of the light box on show here in Ancona: a photograph in which the human figures have been cut out. So the light shines from their silhouettes, indicating how in the artist’s vision the exclusion of identitary elements – in this case artists from different countries – may be a positive point of departure.
What remains and defines the creative action of the individuals is the landscape, which unites the bodies without concern about their background. The artist is born and acts in sociological and cultural space that reflects a light in which the artist acts and becomes somehow shadow.
Born in 1982 year , in Bosnia & Herzegovina.
Lives in Banja Luka.
Solo exhibitions (last 3 years)
2012 Changeable body, Sarita Vujkovic, Museum of Contemporary Art, Banja Luka
2010 Intrada/Modes of speech, Karin Rolle, Galery Terzic, Banja Luka
Group exhibitions (last 3 years)
2011 CYBERFEST, Kuryokhin Modern Art Center, St. Petersburg
URBAN MAPS, Festival savremene umjetnosti, Prag
OPEN CITY, aMAZElab Art&Culture, Sarajevo
The border/performance, Ms Dockville festival, Hamburg
OPEN CITY, aMAZElab Art&Culture, Tirana
Cut-out moments, Marin Gallery, Umag
Clothes as a symbol of identity, City Gallery, Bihac
OPEN CITY, aMAZElab Art&Culture, Skopje
Algebra/ Life path number, ITS-Z1 Gallery, Belgrade
Not So Distant Memory, The Big Screen Project, New York
2010 #5 Neunundneunzig, Freunde Imnamendesraumes, Berlin
OPEN CITY, aMAZElab Art&Culture, Milan
Women’s Writing, Remont Gallery, Belgrade
BiH Video art, Photon Gallery, Ljubljana
2009 EMYAN 2 / Artifice, International Online Arts Festival
NamaTRE.ba 3 project, B&H Video art, Visual TV Container, Milan
NamaTRE.ba 3 project, B&H Video art, Academy of Fine Arts - Trebinje
ZVONO exhibition/award for the best young artist in B&H, Museum of contemporary art, Banja Luka
Borjana Mrdja
Pubblicato nel catalogo Arrivi e Partenze_Mediterrano, GIUDA edizioni (2012)

Mrdja è un’artista bosniaca che ha già all’attivo mostre e progetti artistici in molte parti del mondo, da Berlino a New York a Milano.
Utilizza prevalentemente la fotografia per documentare un lavoro artistico che è realizzato attraverso lo stretto contatto con il pubblico e la relazione con il proprio corpo. Il tema del confine e del limite identitario costituisce uno dei nutrimenti più proficui del suo lavoro.
Il corpo è il confine e il confine diviene corpo: è questo il quesito che pone The Border, in cui la ferita presente sulla mano dell’artista viene messa a confronto con i confini della Bosnia nel 2010. Confini labili anch’essi, quanto quelli di una ferita che piano piano cambia forma, si assottiglia e segue il passaggio del tempo. La sua è una forma di “contro-cartografia”, per dirla con Claudia Zanfi, che individua il corpo come unico confine, o forse che vede nell’ambiguità del limite corporale riflessa l’ambiguità del confine fisico: un confine continuamente ridiscusso, messo in gioco, ridisegnato, con barriere vere o invisibili, da mani che non tengono conto delle cicatrici. La geografia umana diventa mappa vera e propria riflessa su un corpo, il proprio. Lo stato d’eccezione, nella definizione che ne dà Agamben, diviene il soggetto rappresentato da questo lavoro, che dalla sintesi e dalla contemporanea possibilità di assurgere a forma simbolica perfetta della condizione bosniaca trae la sua maggiore forza.
In Artists at Work, progetto nato nel contesto del progetto INTRADA/ modes of speech curato dalla tedesca Role, il confronto tra l’artista bosniaca e i tedeschi con cui ha collaborato, ha portato alla realizzazione della light box esposta ad Ancona: una fotografia in cui le figure umane sono state tagliate. La luce quindi traspare dalle loro silhouette, indicando come nella visione dell’artista l’esclusione degli elementi identitari, in questo caso artisti provenienti da diversi paesi, possa essere un punto di partenza positivo. Quello che rimane e che definisce l’azione creativa dei singoli è il paesaggio, che accomuna i corpi senza interessarsi
al loro background.
L’artista nasce e agisce nello spazio sociologico e culturale, esso riflette
una luce, in cui l’artista agisce e diventa in qualche modo ombra.
Born in 1982 year , in Bosnia & Herzegovina.
Lives in Banja Luka.
Solo exhibitions (last 3 years)
2012 Changeable body, Sarita Vujkovic, Museum of Contemporary Art, Banja Luka
2010 Intrada/Modes of speech, Karin Rolle, Galery Terzic, Banja Luka
Group exhibitions (last 3 years)
2011 CYBERFEST, Kuryokhin Modern Art Center, St. Petersburg
URBAN MAPS, Festival savremene umjetnosti, Prag
OPEN CITY, aMAZElab Art&Culture, Sarajevo
The border/performance, Ms Dockville festival, Hamburg
OPEN CITY, aMAZElab Art&Culture, Tirana
Cut-out moments, Marin Gallery, Umag
Clothes as a symbol of identity, City Gallery, Bihac
OPEN CITY, aMAZElab Art&Culture, Skopje
Algebra/ Life path number, ITS-Z1 Gallery, Belgrade
Not So Distant Memory, The Big Screen Project, New York
2010 #5 Neunundneunzig, Freunde Imnamendesraumes, Berlin
OPEN CITY, aMAZElab Art&Culture, Milan
Women’s Writing, Remont Gallery, Belgrade
BiH Video art, Photon Gallery, Ljubljana
2009 EMYAN 2 / Artifice, International Online Arts Festival
NamaTRE.ba 3 project, B&H Video art, Visual TV Container, Milan
NamaTRE.ba 3 project, B&H Video art, Academy of Fine Arts - Trebinje
ZVONO exhibition/award for the best young artist in B&H, Museum of contemporary art, Banja Luka
Clio Casadei
Pubblicato nel catalogo Arrivi e Partenze_Mediterrano, GIUDA edizioni (2012)

You in space are the parameter, the maximum limit,
the end of my stroke
Clio Casadei ha cominciato la propria attività artistica con il disegno, dedicandosi poi all’istallazione, come strumento che segna maggiormente la fugacità dell’intervento artistico, e convertendo questa fase artistica in un audiolibro, una forma narrativa ed espositiva che unisce queste due anime.
Tu nello spazio sei il parametro, il limite massimo, la fine della mia corsa
è costituito di 112 pagine e 11 minuti di traccia audio, in cui l’artista
curatrice e narratrice di se stessa. È un’opera che lavora sulla fugacità dell’immanenza e tesse un dialogo curatoriale con lo spettatore.
Può l’atto espositivo essere inteso non come l’oggetto esposto, ma come la comunicazione dello stesso? Partendo da questo quesito, l’artista ha deciso di agire esclusivamente nello spazio del tempo dato dall’occasione e di distruggere successivamente tutte le tracce di tale passaggio. L’audiolibro costituisce la testimonianza narrativa di questo percorso, che comprende 5 lavori: Della distanza nella definizione (On Distance into Defining)
2008-2010, La storia è degli uomini (History belongs to human kind) 2008, La mia affezione, la mia eclissi (My affection, my eclipse) 2009, Prendi il mio tempo (Take my time) 2008, Trilogia (Trilogy) on-going, realizzati in diverse occasioni e luoghi. Il viaggio narrativo parte da un progetto legato ad Istanbul, città alla quale molti degli artisti invitati sono in qualche modo legati, e che conferma quanto la capitale culturale dell’odierna Turchia costituisca uno snodo ineludibile nella pratica artistica del Mediterraneo. Osservando la forma luminosa dal satellite della metropoli turca è possibile registrare il suo profondo mutamento, non percepibile dal piano urbanistico, che viene giornalmente disatteso, ma segnato dall’aumento vertiginoso della luminescenza che mostra dallo spazio quanta umanità nuova accolga la città ogni giorno. Anche nei successivi interventi dell’artista il centro pulsante è la narrazione, il cogliere la vertiginosa spinta del racconto per trasferirla in un atto, che per forza deve scomparire per inseguire il tempo.
In La storia è degli uomini tale elemento viene sottolineato da una cartografia che segna non il limite spaziale, dei luoghi, ma che disegna lo spostamento degli uomini, il loro migrare. Il disappunto dell’ineludibile erosione del tempo che scorre è evidente anche in Prendi il mio tempo, dove il generoso dono enunciato nel titolo altro non è che la dichiarazione di una sconfitta.
L’atto espositivo viene concepito come una natura morta: uno still life che segna un punto nel processo creativo, ma non ne coglie il dispiegarsi.
Born in 1984 in Faenza
Lives in Forlì
Solo exhibition (last 3 years)
2011 Tu nello spazio sei il parametro, il limite massimo, la fine della mia corsa,
Curated by Trial Version, Florence, Italy
Group exhibitions (last 3 years)
2010 In Between, Arada, Tra, MSGU Tophane I-Amire Culture Center, Curated by C. Vecchiarelli, Istanbul, Turkey
2009 Rodeo#2. Un-limited, Palazzo Carminati. Curated by Blauer Hase, M.Lupieri, N.Vasiljievich, Venice, Italy
www.produzioni.cc
Clio Casadei
Published in Catalog Arrivi e Partenze_Mediterrano, GIUDA edizioni (2012)

You in space are the parameter, the maximum limit,
the end of my stroke
Clio Casadei began her artistic activity with drawing, subsequently going on to installation as a tool that better marks the fugacity of the artistic intervention, and converting this artistic phase into an audiobook, a narrative and expository form that unites these two cores.
You in space are the parameter, the maximum limit, the end of my stroke consists of 112 pages and an 11 minute soundtrack where the artist herself is curator and narrator. It is a work that deals with the fugacity of immanence and weaves a curatorial dialogue with the spectator.
Can the act of exhibiting be understood not as the object exhibited but as the communication thereof? Setting out from this question the artist decided to act solely within the space of time given by the occasion and to subsequently destroy all traces of that passage. The audiobook is the narrative testimony of this itinerary which comprises 5 works:
Della distanza nella definizione (On Distance into Defining) 2008-2010, La storia è degli uomini (History Belongs to Humankind) 2008, La mia affezione, la mia eclissi (My Affection, My Eclipse) 2009, Prendi il mio tempo (Take My Time) 2008, Trilogia (Trilogy), ongoing works created on various occasions and in various places.
The narrative journey starts out from a project linked to Istanbul,
a city with which many of the invited artists are somehow connected, confirming that the capital of modern Turkey is an ineluctable centre of artistic practice in the Mediterranean. Observing the luminous form of the Turkish metropolis from a satellite its profound mutation can be recorded, not perceptible from the town plan, which is daily disregarded, but marked by the vertiginous increase of luminescence which from space shows just how much new humanity the city is accommodating every day. Also in the artist’s subsequent interventions the pulsating centre is narration, grasping the dizzying thrust of the story to transfer it into an act, which must necessarily disappear to pursue time.
In History Belongs to Humankind this element is underscored by a cartography that does not mark the spatial limit of places but traces the movements of people, their migration. The vexation of the ineluctable erosion of time running by is also evident in Take My Time, where the generous gift stated in the title is none other than a declaration of defeat.
The exhibitory act is conceived as a still life: one that indicates a point in the creative process but does not grasp the unfolding thereof.
Born in 1984 in Faenza
Lives in Forlì
Solo exhibition (last 3 years)
2011 Tu nello spazio sei il parametro, il limite massimo, la fine della mia corsa,
Curated by Trial Version, Florence, Italy
Group exhibitions (last 3 years)
2010 In Between, Arada, Tra, MSGU Tophane I-Amire Culture Center, Curated by C. Vecchiarelli, Istanbul, Turkey
2009 Rodeo#2. Un-limited, Palazzo Carminati. Curated by Blauer Hase, M.Lupieri, N.Vasiljievich, Venice, Italy
www.produzioni.cc
Almudena Lobera
Published in Catalog Arrivi e Partenze_Mediterrano, GIUDA edizioni (2012)
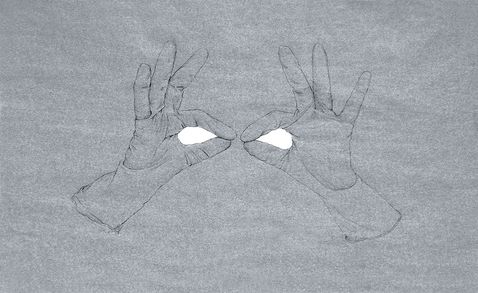
Manual de la imagen mental
Lugar Entre
This versatile and in certain ways virtuoso artist’s favoured field of inquiry is the relationship between representation and reality, mirror and hypothetically real object, madness and its squint-eyed, perturbing glance.
The work of this very young artist fits perfectly into the age-old line running through Hispanic culture from Calderόn de La Barca and Gόngora, right down to Maria Zambrano’s reflections on time.
With candour and lightness, and without ever renouncing a refined and impeccable aesthetic, she succeeds in tackling typically philosophical themes. Her production however sits firmly in the international visual grammar which, besides the specific cultural range, feeds on the questions posed by Walter Benjamin: in the age of reproducibility of the art work it is necessary to establish a dialectical relationship with artistic creation.
All Lobera’s works turn around these thematic hubs: from the performance/event PORTADORES. La imagen en el campo ampliado del cuerpo – created with Isabel Martínez Abascal, a tattoo artist from the other side of the Atlantic – to Procedencia desconocida, a conceptual map and installation which constitutes a visual reflection on different methods of representation among “normal” people and those considered mentally ill, especially psychotics and schizophrenics.
Strongly influenced by surrealism, and Man Ray in particular, Lobera carries out her own re-creation of a visual almanac in Manual de la imagen mental, a series presented in Ancona, which dialogues with spectators by inviting them to execute a positive and ironic action, which is to say create their own mental image by means of a series of drawn gestures. This classificatory and normative obsession obviously clashes with the spirit powerfully oppositive to the sense of fetish: as if it were possible to touch with the hand, manipulate and assign the mental image.
The theme of the place of images returns in Lugar Entre, but with different methods: drawing, photography, installation.
The artist decontextualizes objects belonging to different moments of communication, the subject in this case being digital photography. Dissolution of the object is sustained by its decomposition in three moments, from the dialogue it establishes with the spectator: the female subject is seen from behind (and there is a clear pictorial citation in this choice) and is looked at from the camera viewfinder that also observes
the spectator, in a play of mirrors further underscored by the glass.
Lobera, an artist who widely employs drawing as well as installation and performance, won the Premio Generación 2012 - Proyectos de Arte Caja Madrid.
1984 Spain. Lives in Madrid, Spain
Solo exibitions (last 3 years)
2012 Somewhere between, Eva Ruiz Gallery, Madrid (Spain)
2011 Manual of the mental image, Rafael Pérez Hernando Gallery, Madrid (Spain)
2010 Reflection-Reflexion, UCL Slade School of Fine Art, London (UK)
Desvelatorio, Brita Prinz, Madrid (Spain)
Group exhibitions (last 3 years)
2012 Iceberg #1, Cur, Bernardo Sopelana / Ignacio Chávarri, Matadero, Madrid (Spain)
The Solo Project Fair, Eva Ruiz Gallery, Basel (Switzerland)
Peregrinatio, Art in the chapels of Sagunto, Cur, Fernando Castro Flórez, Sagunto, Valencia (Spain)
DKV Drawings collection, Sala Bretón, El Astillero, Santillana del Mar, Cantabria (Spain)
A work in search of empathy, Cur, Emma Brasó, Sala de Arte Joven Avenida de América, Madrid (Spain)
Gravity, Money, Concrete, Fabric, Cur, Vappu Jalonen, Suvi Lehtinen Gallery, Berlin (Germany)
Generation 2012, La Casa Encendida, Madrid (Spain)
Circuitos’11, Cur, Javier Hontoria, Sala de Arte J, A, de América, Madrid (Spain)
2011 Arqueologías temporales, Teatro de La Aurora, Santiago de Chile (Chile)
Projeto Imóvel, Edificio Copan, Bloco A, Cur, Alessandra Terpins, São Paulo (Brazil)
Tijuana - Feira de Arte Impressa, Vermelho Gallery, São Paulo (Brazil)
ArteLisboa, João Esteves de Oliveira Gallery, Lisbon (Portugal)
Multiplied Christie’s, Contemporary Editions Fair, Ogami Press, London (UK)
Aventuras de líneas, Cur, Juan Manuel Bonet, Eva Ruiz, Gallery, Madrid (Spain)
XVIth International Graphic Triennial Frechen, Köln (Germany)
Regresso ao Acervo+Rita Magalhães e Almudena Lobera, João Esteves de Oliveira Gallery, Lisbon (Portugal)
Do not disturb, Mi alma en otra parte, Centro Galileo, Madrid (Spain)
Arts Libris, Art and Design Books Fair, Ogami Press’ booth, Barcelona (Spain)
Justmad2 Contemporary Art Fair, Blanca Berlín Gallery / Ogami Press, Building Velázquez 29, Madrid (Spain)
XII Premios ABC de Arte, Museo ABC, Madrid (Spain)
2010 Intransit, CAC Complutense Art Center, Madrid (Spain)
MAC+I 09/10, Faculty of Fine Arts UCM, Madrid (Spain)
Graphic Grants’ Show, Nuevoarte Gallery, Sevilla (Spain)
Todo Disfraz, Cur, Marlon de Azambuja, Espacio de Arte OTR, Madrid (Spain)
Estampa International Print and Contemporary Art Edition Fair, Ogami Press’ booth, Madrid (Spain)
Youth Art Award UCM, Museo de América, Madrid (Spain)
Almudena Lobera
Pubblicato sul catalogo Arrivi e Partenze_Mediterrano, GIUDA edizioni (2012)

Il campo di indagine prediletto da questa artista versatile e per certi aspetti virtuosistica, è il rapporto tra rappresentazione e realtà, specchio e oggetto ipoteticamente reale, la follia e il suo sguardo strabico e conturbante.
Si inserisce a pieno in quella scia secolare che ha attraversato la cultura ispanica, da Calderon de La Barca e Gongora, per arrivare alle riflessioni sul tempo di Maria Zambrano, il lavoro di questa giovanissima artista che riesce ad attraversare con candore e leggerezza, senza rinunciare mai ad un’estetica raffinata e impeccabile, tematiche squisitamente filosofiche. La sua produzione si inserisce tuttavia a pieno titolo nella grammatica visiva internazionale che si nutre, oltreché del portato culturale specifico, dei quesiti posti da Walter Benjamin: nell’epoca della riproducibilità dell’opera d’arte è necessario instaurare un rapporto dialettico con la creazione artistica.
Tutti i lavori di Lobera ruotano intorno a questi centri tematici: dalla performance / evento PORTADORES. La imagen en el campo ampliado del cuerpo, realizzato insieme a Isabel Martínez Abascal, tatuatrice d’oltre oceano, a Procedencia desconocida, mappa concettuale e istallazione che costituisce una riflessione visiva sulle diverse modalità di rappresentazione tra le persone “normali” e quelle considerate inferme mentali, in particolare psicotici e schizofrenici.
Fortemente influenzata dal surrealismo, in particolare da Man Ray, Lobera opera una propria ricreazione di un almanacco visivo in Manual de la imagen mental, serie presentata ad Ancona, che dialoga con
lo spettatore invitandolo ad un’azione positiva ed ironica, ovvero a creare la propria immagine mentale utilizzando una serie di gesti disegnati. Questa ossessione classificatoria e normativa si scontra ovviamente con lo spirito fortemente oppositivo al senso del feticcio: come se fosse possibile toccare con mano, manipolare e destinare l’immagine mentale.
In Lugar Entre ritorna il tema del luogo delle immagini, ma con modalità differenti: disegno, fotografia, istallazione. L’artista decontestualizza oggetti che appartengono a momenti diversi della comunicazione, in questo caso il soggetto è la fotografia digitale. La dissoluzione dell’oggetto è sostenuta dalla sua decomposizione in tre momenti, dal dialogo che instaura con lo spettatore: il soggetto femminile è di spalle (e in questa scelta c’è una evidente citazione pittorica) e viene guardato dal mirino fotografico che osserva anche lo spettatore, in un gioco di specchi sottolineato ulteriormente dal vetro.
Lobera ha vinto il Premio Generación 2012 - Proyectos de Arte Caja Madrid, ed è un’artista che utilizza moltissimo il disegno, oltre all’istallazione e la performance.
1984 Spain. Lives in Madrid, Spain
Solo exibitions (last 3 years)
2012 Somewhere between, Eva Ruiz Gallery, Madrid (Spain)
2011 Manual of the mental image, Rafael Pérez Hernando Gallery, Madrid (Spain)
2010 Reflection-Reflexion, UCL Slade School of Fine Art, London (UK)
Desvelatorio, Brita Prinz, Madrid (Spain)
Group exhibitions (last 3 years)
2012 Iceberg #1, Cur, Bernardo Sopelana / Ignacio Chávarri, Matadero, Madrid (Spain)
The Solo Project Fair, Eva Ruiz Gallery, Basel (Switzerland)
Peregrinatio, Art in the chapels of Sagunto, Cur, Fernando Castro Flórez, Sagunto, Valencia (Spain)
DKV Drawings collection, Sala Bretón, El Astillero, Santillana del Mar, Cantabria (Spain)
A work in search of empathy, Cur, Emma Brasó, Sala de Arte Joven Avenida de América, Madrid (Spain)
Gravity, Money, Concrete, Fabric, Cur, Vappu Jalonen, Suvi Lehtinen Gallery, Berlin (Germany)
Generation 2012, La Casa Encendida, Madrid (Spain)
Circuitos’11, Cur, Javier Hontoria, Sala de Arte J, A, de América, Madrid (Spain)
2011 Arqueologías temporales, Teatro de La Aurora, Santiago de Chile (Chile)
Projeto Imóvel, Edificio Copan, Bloco A, Cur, Alessandra Terpins, São Paulo (Brazil)
Tijuana - Feira de Arte Impressa, Vermelho Gallery, São Paulo (Brazil)
ArteLisboa, João Esteves de Oliveira Gallery, Lisbon (Portugal)
Multiplied Christie’s, Contemporary Editions Fair, Ogami Press, London (UK)
Aventuras de líneas, Cur, Juan Manuel Bonet, Eva Ruiz, Gallery, Madrid (Spain)
XVIth International Graphic Triennial Frechen, Köln (Germany)
Regresso ao Acervo+Rita Magalhães e Almudena Lobera, João Esteves de Oliveira Gallery, Lisbon (Portugal)
Do not disturb, Mi alma en otra parte, Centro Galileo, Madrid (Spain)
Arts Libris, Art and Design Books Fair, Ogami Press’ booth, Barcelona (Spain)
Justmad2 Contemporary Art Fair, Blanca Berlín Gallery / Ogami Press, Building Velázquez 29, Madrid (Spain)
XII Premios ABC de Arte, Museo ABC, Madrid (Spain)
2010 Intransit, CAC Complutense Art Center, Madrid (Spain)
MAC+I 09/10, Faculty of Fine Arts UCM, Madrid (Spain)
Graphic Grants’ Show, Nuevoarte Gallery, Sevilla (Spain)
Todo Disfraz, Cur, Marlon de Azambuja, Espacio de Arte OTR, Madrid (Spain)
Estampa International Print and Contemporary Art Edition Fair, Ogami Press’ booth, Madrid (Spain)
Youth Art Award UCM, Museo de América, Madrid (Spain)
Alban Muja
Publishing in catalog Arrivi e Partenze_Mediterrano, GIUDA edizioni (2012)

With irony Alban Muja pursues the infinite possibility of naming as a creative and autonomous act, an indisputable artistic form granted to all of us.
In the multiple and transitory identitary drift that has overturned part of eastern Europe (and to which the remaining geography too is not insensible) the theme of names has become a disturbing and sometimes barbaric leitmotif, but it can also find an ironic lightness, a positive value, when observed with this young artist’s melancholic gaze.
In Tonys the camera immortalizes, in a snapshot that recalls traditional festivals or official occasions, a group of children born in 1999 whose parents named them “Tonyblair” in honour of the former British prime minister who vigorously backed independence for Kosovo and is considered a hero by Albanians in this part of the world. Palestina and Tibet also come out of the same inquiry: a young woman and man from Pristina who tell why they bear the names of foreign countries. Naming, says a son, is a sort of primary creative act, and in these deviations from tradition Muja seems to catch a glimpse of change: what prevails in these choices is a break with the tradition of naming children after deceased relatives; but there is also the search for history within history, for a hidden omen/nomen which sometimes plays nasty tricks. How does it feel to be an Albanian from Kosovo with the name of a nation that doesn’t exist? Official geography plays nasty tricks, and the fragile and precariously balanced identity of Kosovo seems, in the interpretation of Muja, to be a refraction of the Palestinian situation. In Blue Wall Red Door the name confuses places and orientation: the inhabitants use other systems, since in recent years the street names have changed continually and can no longer be an anchor for reaching one’s destination.
Growing up in an artistic space subsequent to the international acclaim achieved by artists such as Anri Sala and Marina Abramovic, Muja shares the same concern about ethical impact and political reflection in the high sense of art, coupled with a new weapon, indubitably painless, which is irony. Also evident is concentration on the private, individual aspect of inquiry: micro-stories that forcefully emanate the international political dialectic, but at the same time they are tiny grains and not a beach.
His works have appeared in public spaces in Vienna and Berlin and numerous galleries in the countries of former Yugoslavia.
Born 10. 09.1980 in Mitrovica, Kosovo, Lives in Prishtina, Kosovo
Solo exhibitions (last 3 years) :
2012 Its all about names, Muzej in Galerije Mesta KC Tobacna 001’, Ljubljana Slovenia
2011 Politics of naming, Myymala2 Gallery Helsinki, Finland
2010 What’s In A Name?, UnionDocs NY, USA
From east to the southwest, Able Kulturverein, Berlin Germany
2009 All around, Siz Gallery, Rijeka, Croatia
Group exhibitions (last 3 years) :
2012 Cross-Time Stories, Wallach Art Gallery – Columbia University, New York
Archive V - Security and insecurity, Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi, Istanbul Turkey
White, CDA Projects, Istanbul Turkey
2011 Pixxelpoint 2011, Nova Gorica Slovenia
Roaming, Teatro Margherita, Bari Italy
Not So Distant Memory, Delaware Contemporary Center for Arts, USA
Cross Border Experience, Škuc Gallery, Ljubljana Slovenia
Not So Distant Memory, Cyberfest, St Petersburg Russia
URBAN MAPS, Tina B, Prague Contemporary Art Festival, Prague Czech Republic
VIDEO/ COLLAGE: Architecture, DAZ / Architect’s association, Zagreb Croatia
Ironapplause.net, exhibition of the YVAA, Slovak National Gallery, Bratislava Slovakia
Spaceship Yugoslavia, NGBK Berlin Germany
Re-Locate’ Apartment Project, Istanbul Turkey
LAMPEMUSA, Archeological Museum, Lampedusa Italy
PRIVATE | PUBLIC taking space -- > making space, Skopje Macedonia
255 804 km², Brot Kunsthalle, Vienna Austria
6th VIENNAFAIR, Wien, Austria
Balkan Trafik, Brussels, Belgium
Supermarket 2011 – the artist-run art fair in Stockholm, Sweden
Big Screen Project, The Center For Book Arts, ARTspace Media Art NY USA
2010 14 international short film, Winterthur Switzerland
Double bind, Center for contemporary art ‘Casa Masaccio’ Corso Italy
Sings of Futility, -Multimeridijan ’10, Pula Croatia
Art forum Berlin, Germany
Word for Word, Without Words’ Mestna Galerija / City Museum, Ljubljana Slovenia
SCREENSAVER, Open Video Projects, Gorizia - Italy
255.804 km2, Mestna Galerija / City Museum, Ljubljana Slovenia
Qui Vive?, Moscow International Biennale, Moscow Russia
The Another Side of The Coin, Škuc Gallery, Ljubljana Slovenia
LONDON LOVES, Vitrine Gallery. London UK
5th VIENNAFAIR, Wien, Austria
Contemporary art fair artbrussels Brussels, Belgium
Berlinale, 60 film festivale, Berlin Germany
5th Video Festival ‘Catodica, Trieste Italy
Biennale Quadrilaterale 3/Biennale OFF, Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka Croatia
Spasticus Artisticus, Ceri Hand Gallery, Liverpool UK
albanmuja.blogspot.com
Alban Muja
Pubblicato sul catalogo Arrivi e Partenze_Mediterrano, GIUDA edizioni (2012)

Alban Muja insegue con ironia la possibilità infinita della nominazione, come atto creativo e autonomo, forma indiscutibilmente artistica consegnata a ciascuno di noi.
Nella deriva identitaria molteplice e transitoria che ha travolto parte dell’Europa orientale (ma a cui non è insensibile anche la restante geografia), il tema dei nomi è diventato un leitmotiv inquietante e a volte barbarico, ma che può trovare anche una leggerezza ironica, un valore positivo se indagata con lo sguardo malinconico del giovane artista
In Tonys l’obiettivo fotografico immortala in un’istantanea che ricorda feste tradizionali o occasioni ufficiali, un gruppo di bambini, nati tutti nel 1999, chiamati dai genitori “Tonyblair” in onore dell’ex primo ministro inglese, politico che sostenne con vigore l’indipendenza kosovara e che è considerato un eroe dagli albanesi di questa parte del mondo. Anche Palestina e Tibet partono dalla stessa indagine: un giovane uomo e una giovane donna di Pristina che raccontano le motivazioni per cui portano il nome di un Paese estero. Nominare sostiene un figlio è una sorta di atto creativo primario e in queste deviazioni dalla tradizione Muja sembra intravedere il cambiamento: in queste scelte prevale la cesura rispetto alla tradizione di nominare i bambini con i nomi dei parenti defunti, ma c’è anche la ricerca di una storia nella storia, di un omen/nomen nascosto, che gioca a volte brutti scherzi. Come ci si sente ad essere albanese del Kosovo e chiamarsi con il nome di uno stato che non esiste? La geografia ufficiale gioca brutti scherzi e l’identità fragile e in bilico del Kosovo sembra essere una rifrazione della vicenda palestinese nella lettura di Muja. .In Blue Wall Red Door il nome confonde i luoghi e l’orientamento: gli abitanti utilizzano altri sistemi, visto che i nomi delle strade negli ultimi anni sono cambiati continuamente e non possono essere l’ancora per raggiungere il proprio obiettivo.
Cresciuto in uno spazio artistico successivo all’internazionale affermazione di artisti come Anri Sala e Marina Abramovic, Muja condivide la stessa attenzione all’impatto etico e alla riflessione politica in senso alto dell’arte, coniugata ad una nuova arma, senza dubbio indolore, che è l’ironia. È evidente inoltre la concentrazione sull’aspetto privato, individuale della ricerca: microstorie che emanano con forza la dialettica politica internazionale, ma che allo stesso tempo sono piccoli granelli e non una spiaggia.
I suoi lavori sono stati esposti a Vienna e Berlino in spazi pubblici e in molte galleria dei Paesi dell’ex Yugoslavia.
Born 10. 09.1980 in Mitrovica, Kosovo, Lives in Prishtina, Kosovo
Solo exhibitions (last 3 years) :
2012 Its all about names, Muzej in Galerije Mesta KC Tobacna 001’, Ljubljana Slovenia
2011 Politics of naming, Myymala2 Gallery Helsinki, Finland
2010 What’s In A Name?, UnionDocs NY, USA
From east to the southwest, Able Kulturverein, Berlin Germany
2009 All around, Siz Gallery, Rijeka, Croatia
Group exhibitions (last 3 years) :
2012 Cross-Time Stories, Wallach Art Gallery – Columbia University, New York
Archive V - Security and insecurity, Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi, Istanbul Turkey
White, CDA Projects, Istanbul Turkey
2011 Pixxelpoint 2011, Nova Gorica Slovenia
Roaming, Teatro Margherita, Bari Italy
Not So Distant Memory, Delaware Contemporary Center for Arts, USA
Cross Border Experience, Škuc Gallery, Ljubljana Slovenia
Not So Distant Memory, Cyberfest, St Petersburg Russia
URBAN MAPS, Tina B, Prague Contemporary Art Festival, Prague Czech Republic
VIDEO/ COLLAGE: Architecture, DAZ / Architect’s association, Zagreb Croatia
Ironapplause.net, exhibition of the YVAA, Slovak National Gallery, Bratislava Slovakia
Spaceship Yugoslavia, NGBK Berlin Germany
Re-Locate’ Apartment Project, Istanbul Turkey
LAMPEMUSA, Archeological Museum, Lampedusa Italy
PRIVATE | PUBLIC taking space -- > making space, Skopje Macedonia
255 804 km², Brot Kunsthalle, Vienna Austria
6th VIENNAFAIR, Wien, Austria
Balkan Trafik, Brussels, Belgium
Supermarket 2011 – the artist-run art fair in Stockholm, Sweden
Big Screen Project, The Center For Book Arts, ARTspace Media Art NY USA
2010 14 international short film, Winterthur Switzerland
Double bind, Center for contemporary art ‘Casa Masaccio’ Corso Italy
Sings of Futility, -Multimeridijan ’10, Pula Croatia
Art forum Berlin, Germany
Word for Word, Without Words’ Mestna Galerija / City Museum, Ljubljana Slovenia
SCREENSAVER, Open Video Projects, Gorizia - Italy
255.804 km2, Mestna Galerija / City Museum, Ljubljana Slovenia
Qui Vive?, Moscow International Biennale, Moscow Russia
The Another Side of The Coin, Škuc Gallery, Ljubljana Slovenia
LONDON LOVES, Vitrine Gallery. London UK
5th VIENNAFAIR, Wien, Austria
Contemporary art fair artbrussels Brussels, Belgium
Berlinale, 60 film festivale, Berlin Germany
5th Video Festival ‘Catodica, Trieste Italy
Biennale Quadrilaterale 3/Biennale OFF, Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka Croatia
Spasticus Artisticus, Ceri Hand Gallery, Liverpool UK
albanmuja.blogspot.com
Arrivi e Partenze_Mediterraneo
Curatela e testo in catalogo, Giuda edizioni, Ravenna (2012)

Un uomo deve pur nascere da qualche parte!
Ivo Andrić
La metamorfosi appare spesso come una metafora che è rimasta latente per tutta una vita e che viene improvvisamente compresa in termini visivi1 : il processo metaforico che porta alla trasformazione passa decisamente dal visivo nell’ambito della tradizione mitologica, proprio per rendere comprensibile razionalmente qualcosa che diversamente potrebbe rimanere relegato nella sfera esclusiva della fede. Nel processo metaforico, che porta a un cambiamento che traduce in materia questa latenza, è sottinteso una profonda idea di crisi; l’inquietudine che si avverte nella trasformazione può essere condensata in angoscia, dolore per la perdita o, più sentimentalmente e proficuamente, in nostalgia. Ma è della trasformazione e della metamorfosi che si nutre il discorso mitologico, e sostanzialmente anche quello artistico.
E la nozione stessa di Europa, della quale ci alimentiamo per definire confini, identità transitorie e presunte e che costituisce un argine immaginario all’alterità, ha le proprie radici in un
viaggio metamorfico: la giovane Europa rapita da uno Zeus trasformatosi in toro bianco. Un viaggio che ebbe come partenza le coste dell’odierno Libano. La giovane Europa, ignara della stirpe di
donne rapite e viaggiatrici che l’avrebbero seguita, portava nel suo nome l’etimologia di “ampio viso, ampio sguardo”, che è quello di cui noi malati della visione ci nutriamo. Ed è proprio da
questo concetto di ampio sguardo che il nostro viaggio curatoriale è partito per questa mappatura arbitraria delle visioni metamorfiche degli artisti invitati. Ma cominciamo dall’inizio. Da
quell’Europa che si attarda a giocare con le ancelle sulla spiaggia di Tiro. C’è molta ironia nella costruzione mitologica dell’arché, della narrazione degli inizi: la stessa che guida i lavori
di molti degli artisti che sono stati selezionati. Un’ironia lieve e disincantata, un gioco di rimandi e quesiti inesplorati, che chiede la via per trovare nomi e combinazioni nuove, ma che si
nutrono di una nostalgia senza carta d’identità.
La precisa percezione del transeunte, della consistenza temporanea e sabbiosa dello sguardo, del proprio sguardo, che si alimenta delle visioni degli altri, ma allo stesso tempo rimane perennemente ancorato alla propria retina, è uno dei codici che accomuna lavori evidentemente segnati da differenze e resistenze alla narrazione di uno sguardo unico e compreso del proprio punto di vista. Eppure, nel lavorare con una grammatica visiva che usa molti rimandi comuni, è possibile che il processo metamorfico della creazione artistica porti a soluzioni assonanti.
Non si può precludere dallo spazio abitato per abitare uno sguardo, ma allo stesso tempo lo spazio che si è scelto come geografia ideale per questo progetto espositivo ha al proprio centro un mare, che per antonomasia è un luogo di transiti e di movimento. Un mare che nella nostra nominazione è “il mare che sta in mezzo alle terre”, ma che nelle odierne cartografie viene relegato in basso e non al centro. Per questa ragione il primo atto artistico di “Arrivi e partenze” è una nuova rilevazione cartografica, quella di Riccardo Clementi, che con l’umiltà che ci impone “l’ampio sguardo”, pone nella sua cartina al centro il mare, con le sue fosse e le sue altimetrie, bianco come lo vuole il turco (Akdeniz). Perché nell’atto di nominare c’è quello di creare, e ce lo ricorda Alban Muja, artista di Pristina che concentra il proprio agire su questa diversa geografia dei nomi, che corre con i tempi incontrando luoghi o facendoli diventare di difficile orientamento. La vertigine dell’identità e della nominazione è alla base della ricerca artistica, fortemente connotata da vicende autobiografiche, di Dor Guez, che sia nei video che nell’istallazione ritorna continuamente alla domanda “Chi sono io? E chi sei tu, che mi chiami?”: il gorgo creato dal bisogno di una categoria per esistere e sapere chi si è diventa in questo caso una prigione. La stessa prigione identitaria che scandaglia Nilbar Gϋreş: quella creata dalla percezione dell’immagine femminile e dell’immagine femminile, in particolare se proviene da un paese di tradizione islamica. Lo sguardo irriverente, acuto e sornione di Gϋreş non lascia spazio alle facili etichette: l’abito, luogo del simbolico per eccellenza, e il corpo, luogo dell’umano, diventano due dei suoi materiali preferiti di lavoro.
In questa possibile geografia dello sguardo irriverente, c’è spazio per dispositivi sonori che cancellano il segno fisico, come nell’istallazione di Younes Baba Ali, che con segnali morse chiama alla preghiera sostituendosi al canto del muezzin, o nel Carillon del collettivo Orthographe, gruppo che difficilmente si può confinare in una categoria, essendo costantemente nomade tra teatro sperimentale, arte visiva e azione quasi dadaista. Proprio gli Ortographe espongono in mostra un gioco da tavolo, che invita alla dimensione ludica e straniante: una versione ibrida tra il Monopoli e il gioco dell’oca (che ovviamente rimanda al codice nostalgia, ma questo ormai è inutile ripeterlo...) in cui i giocatori sono chiamati a risolvere l’enigma della morte della rock star.
Sull’eticità del gioco come modalità liberatoria e strumento cognitivo indispensabile interviene anche Adelita Husni Bey, con il complesso lavoro ispirato al pedagogista Francisco Ferrer giustiziato nel 1909: nella Escuela Moderna di Ferrer la base è l’antiautoritarismo e la libera espressione dell’individuo, la formazione scientifica e laica. Aspetti questi che costituiscono un leitmotiv dei paesi sul mare su cui si affaccia Ancona, e che a ondate tornano ad interrogare i cittadini: istruzione come liberazione o coercizione, la qualità e il merito oppure la felicità e la relazione. Le vacanze dalle regole di Husni Bey si pongono sul confine tra rappresentazione del potere (o antipotere della pedagogia liberatoria) e il passato che non passa. Anche se nella ricerca attiva all’interno di un liceo parigino che pratica la versione odierna delle teorie pedagogiche anarchiche del martire spagnolo è evidente la volontà di confrontarsi con l’hic et nunc, non si cela una corda profondamente nostalgica nella visione estetica, nella resa artistica del lavoro. E certamente la nostalgia senza ricordo è un tratto presente in molte opere. La trasformazione artistica di questa artista rende visibili e riconoscibili queste opzioni, posizionandole in una dimensione immediatamente comprensibile nell’atto di guardare. La forte tensione narrativa emerge chiaramente nel lavoro collettivo TouchStories di Isabella Mara, Camilla Monga, Serena Porrati, Maria Giulia Serantoni, Domenico Stranieri e Ramona Zordini, nato in seguito ad un laboratorio con Studio Azzurro: una storia ci salverà la vita, e come si collegherà alla nostra storia. Narratori, narratari e pubblico diventano un unico.
L’ampiezza dello sguardo e la sua caparbietà nell’essere intangibile sono la materia anche di Clio Casadei, artista italiana che espone lo scarnificato risultato delle proprie azioni artistiche irrimediabilmente perdute, e Almudena Lobera, che attraverso il disegno in particolare materializza la frustrazione di questa impossibile mediazione.
C’è un progressivo ammutolirsi del fare artistico di fronte all’analisi ancora imperante del postmoderno e dei suoi epigoni, una forma di delegittimazione, che si scontra peraltro con l’alto numero di persone che si possono identificare con l’epiteto di artisti. A questa impasse reagiscono gruppi come i /barbaragurrieri/group, collettivo noto per le sue azioni di sedimentazione e iterazioni del linguaggio, e personaggi difficilmente schedabili (se non dalle forze dell’ordine...) come Ganzeer, noto per il progetto di graffiti sui martiri della rivoluzione a Il Cairo.
Un moltitudine di larghi sguardi, caratterizzati da forte identità singole, che non possono ricollegarsi ad un movimento comune, se non per l’arbitrarietà dell’occhio della curatrice. È quindi un’azione autoritaria dire “Mediterraneo”, meglio sarebbe il molteplice mare.
Ci sono però, malgrado queste vocazioni individuali, questo scandagliare nell’ambito del largo codice del contemporaneo, con voce propria lo spazio del visivo, alcune tracce che hanno guidato questo atto autoritario della selezione. Una vocazione cartografica che ha voluto indagare le rappresentazioni del paesaggio mentale, ad esempio. Un concetto che di per sé nasce tardi nella nostra cultura. Inizialmente quello che per noi oggi è “paesaggio” era un’insieme di forze naturali controllate da forze superiori che l’uomo subiva. Fino a Cesare e Cicerone2 non esisteva la parola per dirlo, e quando la parola si comporrà manterrà sempre (da landscape, a Landshaft a paysage) “un’ambiguità di fondo tra le due componenti semantiche, quella naturalistico – ambientale e quella estetica”. Ovvero, il paesaggio c’è nella nostra idea di paesaggio, non coincide con la natura. Ed essendo “geografia trasportata al morale” aveva in seno l’idea di un “bene”, di un’estetica positiva, che forse è una delle tracce estinte in questi eventi paesaggistici intercettati e ritrasmessi da artisti come Randa Mirza, che trasferisce in inganni paesaggistici i propri interrogativi sulla sussistenza del paesaggio di una città come Beirut, o nell’estetizzante Noemie Goudal, in cui la stessa vocazione allo scenario fittizio, alla costruzione di immaginarie simbiosi tra luoghi dell’abbandono antropico e figure umane uscite dai ricordi di fiaba. In entrambi i casi lo spettro fotografico non registra, impone il proprio sguardo senza assoluzione.
La linea preponderante di questa geografia artificiale e sintetica è stata la rappresentazione del potere, inteso come dispositivo che contiene feticci e con il quale l’artista ha la possibilità di dialogare proprio in virtù di questa sua trasposizione in icona, in immagine già nuda. Così Ganzeer è riuscito a preservare i murales che rappresentavano i morti dei giorni della rivolta in Egitto dalla furia purificatrice dell’esercito utilizzando la parola “martiri”: una parola che ha fermato l’iconoclastia, arrestato l’ansia di pulire, assalire il “degrado” (per utilizzare un termine tanto amato dai nostri locali purificatori). Lo scontro tra parola che dice e che rappresenta è il cuore del lavoro di Héla Lamine, ispirata anch’essa dalla primavera araba e in particolare tunisina, che nell’opera Nous ne mangerons plus de ce pains là utilizza proprio il pane come materia per ricostruire l’ex icona nazionale di Ben Ali, contro il quale le folle gridavano proprio slogan sul pane. Il potere è diventato la cosa: il pane che marcisce e mostra la sua putrefazione ne segna anche la temporalità. La clessidra è finita, l’ironia rimane nel rimasticare parole che diventano cose finite.
È esplicito nel trittico di Mary Zygouri l’accostamento metaforico animale / politico – animale /poetico. La reazione imprevedibile dell’animale è spiazzante per lo spettatore: stabilisce un nesso di responsabilità e abilità la connessione possibilità dell’evento. Se l’animale è imprevedibile, potrà esserlo anche l’uomo? Esiste un destino scontato e prescritto, come viene oggi adombrato addirittura nelle misure economiche intraprese da governi delegittimati, ma agenti in virtù di questa ipotetica predestinazione dell’atto? Zygouri agisce come una guastatrice. Non porta risposte, ma permette la sospensione del prevedibile. L’anestesia della visione viene sostituita dalla sinestesia dell’azione. Yael Plat interagisce con lo spettatore attraverso la provocazione diretta, d’azione politica: No Entry non lascia spazio ad ambiguità. La porta è chiusa per tutte le categorie nominate, persino per te, che leggi la scritta.
Attore del cambiamento e indagatore anch’egli delle forme che il potere prende e che coinvolgono anche chi il potere lo subisce, Wafa Hourani utilizza forme ironiche per trasporre in metafore pop una storia, quella di un popolo sostanzialmente incarcerato e costretto all’esilio nella propria terra, ormai logorata dalla mediatizzazione. Succube di un passato che non passa, di una geografia che intreccia potere e corpi, Borjana Mrdja esamina la scomposizione e la ricomposizione dei confini della Bosnia, trasferendo la linea dei confini sulla ferita sulla propria mano, anch’essa sottoposta all’usura del tempo. Un’usura cui tenta di resistere Bisan Abu- Eisheh, contenendo tramite la tensione museografica e classificatoria la dispersione della polvere di vinti: egli ha raccolto per tre anni le macerie delle case demolite a Gerusalemme delle famiglie palestinese e le ha racchiuse in un museo. Ricomporre la memoria è una delle ansie più latenti della nostra contemporaneità destinata ad un Alzheimer etico, ad una smemoratezza mormorante.
Così anche Zoulika Bouabdellah nell’elaborare sontuose e ironiche rappresentazioni delle geografie dei luoghi comuni femminili nel mondo arabo, non si sottrae alla malattia del recupero memoriale in forma di nostalgia etica, in opere come Genie Lady, ispirato a un cult movie sentimentale arabo del 1948, ridisegnato con evidenti rimandi ironici alla tradizione orientalista. La nostalgia del futuro è presente nel lavoro di Danilo Correale, che tocca una città, Istanbul, che ricompare in molte biografie e produzioni di questi artisti migratori.
La nominazione e il sogno, la possibilità di controllare l’immaginario attraverso l’attribuzione del nome e la perdita del controllo attraverso l’attività onirica (o forse la sua acquisizione in forme più interessanti...), sono la materia che vede impegnati artisti come Jovana Komnenić con il suo Book of Dreams, e a cui può essere ricondotta anche Goudal. Il passo alla ricerca di manuali per i luoghi mentali di Almudena Lobera è breve: nelle sue immagini dalla bellezza sobria e sospesa, da questo esercizio di sintesi visiva che non si chiude all’estetismo, nascono serie che stupiscono per il loro lindore filosofico, per la loro chiarezza espositiva. Il disegno di un albero non mostra un albero, ma un albero che viene osservato3 : il luogo mentale non viene mostrato, ma si mostra la sua osservazione. Così Mito Gegič nella digitalizzazione di una materia classicamente pittorica, nella parcellizzazione di un’immagine di caccia e cacciatori, animali annichiliti e diventati forzatamente nature morte, rievoca l’osservazione come metodo di interpretazione.
Tiberi, Strappato e Nicolai, diversi nei codici e nei riferimenti, si pongono nel progetto Porta Pia – Open Academy, come specchi dello sguardo, coltivatori dell’apparente abbandono dei luoghi: una sorta di guide della visione, senza però un obiettivo prestabilito, ma saltatori di muri, per citare Alex Langer.
E così torniamo all’origine, allo sguardo ampio di Europa: l’apparenza di questo viaggio d’amore non può tacere delle disgrazie che questo rapimento porta nelle storie successive. Pasifae, il Minotauro, Arianna sedotta e abbandonata, sono solo le prime sconfitte dell’apparente armonia della visione di questo mare in cui l’idea di Europa si fonda, e che poi per ragioni politiche ed economiche sposterà il proprio baricentro più a nord, e poi a ovest, e ora chissà forse ad est. Nessuno degli artisti invitati crede nell’apparente ed edulcorante ideologia di un Mediterraneo pacificato. Chi si concentra a dichiararlo attraverso il proprio lavoro artistico, chi lo denuncia nella propria reticenza a dichiarare il nome dello Stato in cui è nato. Per qualcuno lo stesso nome del paese d’origine è cambiato: non è quindi nella geografia politica che si può trovare una linea, che essa inganna, ma nella geografia delle poetiche e dei quesiti, in momentanei incroci stilistici, che denunciano uno sfondo anche se rumoroso e acustico, in cui la figura è diventata sfondo, L’ambiente elettronico ha rovesciato il punto di vista, non più privato, non più compreso dal proprio punto temporale, ma immerso in un flusso in cui con accesso istantaneo a tutti i passati e futuri, in cui il proprio punto di vista diventa irrimediabilmente irrilevante: ed è quindi in questa resistenza alla volatilizzazione del sé che le tracce individuate si collegano e trovano una possibile causa efficiente. La necessità di classificare, mappare, preservare è un dispositivo artistico con forti connotati etici, un farmaco per arginare l’ideologia imperante del sostantivo “presente”, della “scelta necessaria”.
Una mappa di volti - Felipe H. Cava e Raùl
Catalogo "Marjane Satrape ovvero dell'ironia dell'Iran"
Edito da Lizard Edizioni, 2003

Leningrado, dicembre 1990. Un mondo che si sta per disgregare, assumere nuovi nomi, nuovi contorni, abbracciare nuovi simboli. Il tratto di Raul trova carne per la sua traccia: appaiono nelle sue sintesi in filigrana gli echi di una Spagna che ha conosciuto bambino o che ha immaginato dai racconti delle storie familiari. Un mondo di volti contadini che si contraggono in narrazioni visive in una mappa iniziale che considera la storia il condensato del vissuto nello sguardo e nel labirinto delle linee che compongono i volti.
Finestra sull'occidente è un viaggio iniziatico che testimonia una fine e compone una sinfonia intensa di nostalgia. Nel Paese in cui il fumetto ha avuto destino alterno, censurato ma comunque presente in una tradizione figurativa iconico quale quella bizantina che spesso utilizza sequenze affini, protostoriche, del fumetto, la narrazione vera e propria si apre con una metafora tra modalità di pensiero e comportamento sociale e fumetto che sarebbe piaciuta a Orlando Figes, lo studioso inglese che ha provato a ricostruire in un'opera recente1 il privato e il non detto dell'epoca staliniana e sovietica in genere. Un'epoca che viene presentata dall'estesa ricerca del docente britannico come un periodo nel quale ciò che si dice e ciò che si pensava non corrispondevano, o perlomeno andava fatta una selezione continua e attenta, una rimozione perspicace del verbale: come dice il protagonista della prima storia, ciò che penso può stare solo nelle didascalie, non nei balloon. Questo breve romanzo è una estesa metafora sulla forza del fumetto e sulla narrazione, che allo stesso tempo ci regala una delle più coinvolgenti letture sulla fine di un mondo.
La radiografia dei volti continua, nei piccoli gesti dell'apparecchiare una tavola, un gesto antico che prepara il fuoco intorno al quale le storie nascono. La narrazione come salvezza, l'ironia come salvagente. È un decameron moscovita in cui fuori imperversa una tempesta da cui i protagonisti si proteggono con la vodka e le storie. Ogni narrazione ricrea ogni volta un mondo che si compone del momento e che scioglie la possibilità della memoria in una tormentata nostalgia in cui le immagini diventano simboli, si dilegua l'ossessione dell'ombra e la parca geometria intrisa di macchie diventa la nota visiva che ci ricorda quanto è perduto della linea. E la storia ha bisogno di un inizio. Delle storie prime: perché siamo diventati cristiani? E poi con un salto che dimentica consapevolmente vari secoli gli anni venti, quelli del disincanto, con una storia di amore, poesia e calcolo differenziale. E poi, per non affogare nel melodramma, una storiella, di quelle sovietiche. Quelle che fanno ridere fino alle lacrime. E poi? Poi arriva Napoleone, virtuoso e manierista nella linea. Cavalli barocchi. Animali che ci guardano negli occhi. E dopo il silenzio di Napoleone rimane Larissa, l'unica donna, l'armena di minoranza. “Racconta una storia”. E la storia diventa una storia che potrebbe essere popolare, con i tratti della fiaba, con la morte che ci ripensa. Mentre il mondo è distratto da altro, da nuovi slogan, da nuove armi. Neanche la ghigliottina funziona più: la Francia l'ha usata per l'ultima volta nel 1980, sono passati ormai dieci anni. E neanche la potenza funziona più come arma in questa ultimo appartamento sovietico in cui si raccontano storie. Rimane la finestra attraverso cui continuare a guardarsi. Una finestra che è quella del fumetto.
1 Orlando Figes, Sussurri e sospetti
Abecedario della storia sotto il tappeto
Pubblicato nel catalogo R.A.M. 2011, GIUDA edizioni, Ravenna

RAM è la selezione biennale curata da Associazione Mirada per conto del Comune di Ravenna, che permette ai giovani artisti visivi del nostro territorio da ormai dieci anni di crescere e farsi conoscere a livello regionale, nazionale e internazionale.
RAM non è solo la mostra, che costituisce sicuramente il momento più importante ma non conclusivo di questo percorso, ma è un progetto complessivo di affiancamento e crescita degli artisti coinvolti, attraverso il confronto con i curatori e i critici, la proposta progettuale e la costruzione di un processo di comunità artistica più in generale.
Il tema individuato per l’edizione 2011 si rapporta ancora una volta con la città e i suoi umori, recuperando temi, simboli, suggestioni che appartengono all’humus di Ravenna, rivisitati con l’occhio e le mani degli artisti. Partendo dalla prolusione di Sauro Mattarelli in occasione della visita del Presidente della Repubblica alTeatro Alighieri, che produceva una serie di esempi di nodi storici e lasciti piuttosto nascosti che gridati nella nostra città, i vincitori di RAM hanno lavorato confrontandosi con i critici, su questo ipotetico abecedario “sotto il tappeto” che forma la nostra identità culturale. Alberi della libertà, permanenza dell’esilio a partire dal più famoso profugo politico ovvero Dante, movimenti anarchici e socialisti, accoltellatori, sono alcune delle suggestioni che hanno condotto alla realizzazione delle opere.
RAM non finisce con la conclusione della mostra, ma continua attraverso l’attività dell’ufficio giovani artisti del Comune di Ravenna che si occupa di diffondere e sostenere la partecipazione degli artisti under 35 locali alle occasioni per loro pensate a livello nazionale. La comunità artistica è fatta di voci e incontri, perché come diceva Lévinas l’Altro venendomi incontro mi espelle dalla mia solitudine.

Uomini e donne il cui esilio viene connotato con troppo facilità con altri nomi, con quasi titubanza nell'attribuire un termine che ha una vocazione intellettuale a chi è fuggito dal proprio Paese non per scelta, ma per l'impossibilità di essere cittadini.
Adorno sosteneva a sua volta che “le case sono sempre provvisorie” per l'esule e per il profugo: la provvisorietà ha permesso a molti degli esiliati che anche in anni passati sono stati ospiti silenziosi della nostra città di fare ritorno, il ritorno che, come diceva sempre l'intellettuale palestinese, non può essere mai un ritorno totale e un rimpatrio definitivo, perché l'esperienza dell'altrove ci cambia e torneremo lasciandoci alle spalle un altro passato.
Pochi in realtà sono rimasti, anche se Ravenna è stata terra ospitale in diverse occasioni negli ultimi decenni, ed anche per questi la provvisorietà data l'esperienza della Terra – Patria è diventata spazio in cui costruire una vita.
Nel lavoro di Molinari, che ha scelto di interrogare proprio questo nodo dell'abecedario del rimosso, emergono tutti questi elementi, fermati in un'istantanea che non dimentica un'altra delle qualità invocate da Said, ovvero l'ironia. Le immagini continuano ad essere interrogative e non didascaliche. Il volto dell'Altro (con la maiuscola come voleva Lèvinas) è coperto dalla maschera simbolica di un personaggio che evoca ibridazioni. La personalità della maschera dialoga con la figura del protagonista della foto, fa emergere possibilità, radica la profondità dei vissuti. Difficile infatti attribuire immaginario alle vite dei profughi, sempre costretti dal cartellino che li ingabbia, da un passaporto simbolicamente bianco. La maschera, nella sua teatralità e nel suo valore antropologico, restituisce spessore e narrazione, fa scattare una reazione ironica. “E se fosse lui, Einstein, effettivamente esule, in questa provvisoria dimora che capita nella nostra città?”. E se fossimo umani, troppo umani. La valvola dell'empatia è spesso occlusa dalla potente colla del preconcetto, che agisce in positivo o negativo, non prendiamoci in giro. Le fotografie di Molinari hanno valore euristico nel senso primo della parola: ci fanno recuperare profondità e vissuto, attraverso lo scarto propulsivo dell'ironia, che è un potente dispositivo di comprensione.
José Antonio Vargas, premio Pulitzer negli USA e uno dei più importanti giornalisti a stelle e strisce, ha fatto il suo scoop più significativo dichiarando sul New York Times la sua condizione di clandestino. Che è ovviamente cosa diversa dall'asilo politico, ma forse dovremmo cominciare a ragionare in termini diversi di cittadinanza planetaria, di patria terra per dirla con Morin.
Nell'opportunità di essere altrove e creare relazioni e tracce sta la possibilità della crescita, della disseminazione delle storie e l'implosione dei significativi del visivo antropologico di Molinari, fotografo indagatore e costruttore di ponti.
La maschera dell'esilio. Filippo Molinari nello sguardo di Dante.
Pubblicato nel catalogo R.A.M. 2011, GIUDA edizioni, Ravenna

Ho sostenuto che l'esilio può produrre rancore e risentimento, ma anche una visione più acuta delle cose. Edward Said, Nel segno dell'esilio,
Esiste una tradizione e una permanenza dell'esilio? Said interpretava la condizione dell'esilio come uno spazio in cui praticare la critica. L'esilio e la memoria, diceva, vanno a braccetto. E condizionano la modalità con cui si guarda al futuro, perché essa dipende dal modo con cui ci approcciamo al passato. Nella permanenza dell'esilio dantesco che è data dalla dimora funeraria del poeta fiorentino, proprio la condizione dell'espatriato per ragioni politiche è stata spesso sommessa, detta sottovoce e non acquisita come elemento sostanziale della volontà di attribuire un'identità dantesca alla città di Ravenna. Anche se nell'ultimo periodo è stato scelto proprio D.A.N.T.E. come acronimo per il progetto SPRAR del Comune di Ravenna che vede oggi fornire asilo politico a 45 persone.

Uomini e donne il cui esilio viene connotato con troppo facilità con altri nomi, con quasi titubanza nell'attribuire un termine che ha una vocazione intellettuale a chi è fuggito dal proprio Paese non per scelta, ma per l'impossibilità di essere cittadini.
Adorno sosteneva a sua volta che “le case sono sempre provvisorie” per l'esule e per il profugo: la provvisorietà ha permesso a molti degli esiliati che anche in anni passati sono stati ospiti silenziosi della nostra città di fare ritorno, il ritorno che, come diceva sempre l'intellettuale palestinese, non può essere mai un ritorno totale e un rimpatrio definitivo, perché l'esperienza dell'altrove ci cambia e torneremo lasciandoci alle spalle un altro passato.
Pochi in realtà sono rimasti, anche se Ravenna è stata terra ospitale in diverse occasioni negli ultimi decenni, ed anche per questi la provvisorietà data l'esperienza della Terra – Patria è diventata spazio in cui costruire una vita.
Nel lavoro di Molinari, che ha scelto di interrogare proprio questo nodo dell'abecedario del rimosso, emergono tutti questi elementi, fermati in un'istantanea che non dimentica un'altra delle qualità invocate da Said, ovvero l'ironia. Le immagini continuano ad essere interrogative e non didascaliche. Il volto dell'Altro (con la maiuscola come voleva Lèvinas) è coperto dalla maschera simbolica di un personaggio che evoca ibridazioni. La personalità della maschera dialoga con la figura del protagonista della foto, fa emergere possibilità, radica la profondità dei vissuti. Difficile infatti attribuire immaginario alle vite dei profughi, sempre costretti dal cartellino che li ingabbia, da un passaporto simbolicamente bianco. La maschera, nella sua teatralità e nel suo valore antropologico, restituisce spessore e narrazione, fa scattare una reazione ironica. “E se fosse lui, Einstein, effettivamente esule, in questa provvisoria dimora che capita nella nostra città?”. E se fossimo umani, troppo umani. La valvola dell'empatia è spesso occlusa dalla potente colla del preconcetto, che agisce in positivo o negativo, non prendiamoci in giro. Le fotografie di Molinari hanno valore euristico nel senso primo della parola: ci fanno recuperare profondità e vissuto, attraverso lo scarto propulsivo dell'ironia, che è un potente dispositivo di comprensione.
José Antonio Vargas, premio Pulitzer negli USA e uno dei più importanti giornalisti a stelle e strisce, ha fatto il suo scoop più significativo dichiarando sul New York Times la sua condizione di clandestino. Che è ovviamente cosa diversa dall'asilo politico, ma forse dovremmo cominciare a ragionare in termini diversi di cittadinanza planetaria, di patria terra per dirla con Morin.
Nell'opportunità di essere altrove e creare relazioni e tracce sta la possibilità della crescita, della disseminazione delle storie e l'implosione dei significativi del visivo antropologico di Molinari, fotografo indagatore e costruttore di ponti.
Elogio della visionarietà
testo in Macchina Suprema, Giuda edizioni, 2011

“Che cosa c'è di più coerente della follia che canta le proprie lodi?”, si chiedeva Erasmo da Rotterdam nel famoso Elogio della follia: nell'epoca assennata degli umanisti il dotto olandese interrogava la cerchia dei sapienti sul tema di chi è il vero folle, domanda inevasa direi e che ancora oggi ci diletta. E che ancora produce storie affabulatorie, dove l'amore, la morte e le coincidenze la fanno da padrone.
In questo originale plot di Giovanni Barbieri gli ingredienti ci sono tutti: l'abbandono, il ritorno, le strane alchimie del sogno che diventa vita, la vita che diviene sogno, specchi che si infrangono e fanno emergere disegni più reali della realtà.
Questo materiale evocativo è tenuto insieme coerentemente dalla presenza di vari livelli linguistici e narrativi. Ai nomi citazionisti dei protagonisti, che rievocano letterature russe cadute nelle botole della nostra memoria, si impigliano situazioni quotidiane stranianti: “chiedo il cambio liceo”, dice uno dei personaggi, “entro il 26”. Il linguaggio forbito e cangiante ogni tanto cade in un parlare sommesso. Luoghi fantasmatici, anch'essi da prurito nelle orecchie dei lettori, si alternano a situazioni che rimandano ad una quotidianità distratta e banale. La carne desiderante si scontra con le romantiche passeggiate sulla barca e con i doni simbolici di uomini colpiti dal sacro furore. Ma saranno loro i folli? O forse gli occhiali del prevedibile ci distolgono dal vedere la notevole macchina suprema?
Lo stesso Cartesio, d'altro canto, che propugnò una visione meccanicistica e razionale del mondo, fu agitato da sogni e visioni mentre scriveva il Discorso sul metodo. Anche l'uomo del “Cogito ergo sum” insomma aveva le sue inquietudini e si pose il problema di rilevare un'unica legge suprema per la lettura del mondo. Anche il nostro Milos insegue un ordine supremo, una via di cui non intravediamo i confini, ma che rimanda alle ricerche olistiche e assolute. Ma in questa storia di assoluto sembra esserci solo l'amore, che abbandona, illude, ritorna e si nasconde. E porta a follie perpetue o intermittenti. Di cui vediamo i segni sui muri e sui corpi. Un romanzo romantico, che si compone di diversi stili perché è composto di diverse materie, che solo prendendo forma rappresentata in diversi registri visivi poteva trovare completezza.
Per dirla sempre con Erasmo, questo libro non è “per le scimmie ammantate di porpora o gli asini vestiti con la pelle del leone”, ma per gli arcifolli guardatori, per coloro che sanno che la stessa vita si deve alla medesima dea, Follia.
L'inchiostro di Saturno
Pubblicato sul catalogo di Selvatico, Cotignola (2011)

Il disegno assomiglia a una sorta di scrittura. Nell'antichità si usava anche il termine “antigrafia” per indicare sia l'atto di disegnare quanto quello di scrivere. Questa contiguità permette
con minore senso di vergogna di spendere parole sull'atto del disegnare. Spesso l'effettiva limitatezza del discorso, scritto o parlato, la mutilazione delle frasi sull'arte, mi spingono a
pensare che il miglior lavoro critico sul disegno dovrebbe essere disegnato. È un percorso che il fumetto sta intraprendendo, quello di esplorare le possibilità con cui la sequenza disegnata può
“dire” qualsiasi cosa. C'è molta confusione in merito. Alcuni usano etichette come “Graphic Novel” o “Graphic Journalism” (rigorosamente in inglese, of course) per il loro valore intrinseco di
marketing, senza posare lo sguardo su quanto stanno catalogando. Ma la strada è aperta. Il giardino è ampio e incolto e la crescita dei frutti dipende dai giardinieri.
Il disegno è anche la documentazione autobiografica della scoperta di un evento. Che cosa rimane di quell'autobiografia in quel nuovo evento che è il disegno? Quanta parte dell'autore, della sua traccia del mondo si consolida nell'atto di disegnare e viene restituita al guardatore? Questa è un'indagine che può portare al nero come categoria interpretativa, come forma assoluta della ricerca del colore. Il nero non esiste in natura.
C'è anche il livello metaforico: il buco nero che si produce quando la propria storia si misura con l'atto di disegnare, con il creare il buco narrativo sostanziale alla creazione di una sequenza disegnata (la vera differenza tra fumetto e cinema: tra una vignetta e l'altra c'è sempre un buco da riempire. E questo riempimento è il lavoro attivo del lettore), ha una dimensione di difficile misurazione. E fino a dove questo buco costituisce una possibilità, e quando invece il buco, l'assente, il nero, diventa provocazione stilistica che infrange il genere e crea un nuovo evento, di difficile nominazione? Nel processo di costruzione di una sequenza narrativa classica ci sono alcuni passaggi che sono quasi ineludibili se si vuole ottenere un certo tipo di narrazione. Eppure questi canoni oggi sembrano accantonati da moltissimi autori, in particolare autori del bianco/nero, dell'underground, che scelgono questa cifra stilistica non per ragioni di preferenza, ma di costi diretti di stampa. Non c'è nulla di consapevole ed elegante in tutto ciò, ma lo splendido utilizzo di necessità che diventa per forza virtù. Dunque, in una sequenza il buco nero narrativo può crescere a dismisura, stimolare il lettore (o forse meglio, il guardatore) a fare di ogni singola immagine e parola/e un'esperienza unica, che pure si muove in una direzione che l'autore ha deciso. L'autore mantiene in questo modo ben saldo il controllo della proprio evento autobiografico, la propria voce, ci guida nell'ordine delle immagini, ma al tempo stesso ha reciso quel discorso narrativo continuo e lineare che aveva recepito un certo tipo di codice. Non faccio nomi, l'elenco c'è. E anche alcuni autori in mostra seguono questo ripido processo.
La melanconia è il nero, dentro la parola stessa (da melan che significa proprio nero ma anche inchiostro): il sole nero della Kristeva, l'inchiostro che attrae la malattia di Saturno. La malattia dell'inchiostro.
Nel disegno in bianco e nero, dove sappiamo che il nero assoluto non esiste, esiste un altro soggetto che prende decisioni ed influisce: la carta. Il disegno non è altro che annotazione su carta: ci sono dipinti, fotografie che possono essere riconosciuti da animali ma questo non vale per il disegno in bianco e nero. Il disegno non compete con la realtà, anzi attiva altri meccanismi, dichiara un'esperienza temporale. Qualsiasi immagine registra un'apparenza che scomparirà, ma il disegno aumenta la nostra consapevolezza della fugacità, dell'assenza. È più ciò che manca che quanto c'è. Riattiva l'attenzione, la memoria, dialoga con la caducità e la rende esplicita.
Il disegno è nero, perché è l'adunata dell'assenza.
Lo strabismo dell’altro - Pino Creanza
Pubblicata su Egitto senza piramidi, GIUDA edizioni (2011)

Rappresentare l’altro è uno di quei temi che ha interessato l’arte del novecento e messo a dura prova quella del nuovo millennio.
L’Altro, come diceva Lévinas, venendoci incontro ci “espelle” dalla nostra solitudine.
Le storie di Creanza ci impegnano all’incontro, all’andare verso l’umanità dell’altro, che esce dalla sua porzione di anonimato, dal suo essere “l’egiziano”, la “donna velata”, il “giovane”, e diventano volto e sguardo che si interseca al nostro guardare. I frammenti di vita quotidiana che con tratto realistico compongono questo blues, termine che non connota un sottofondo musicale, formano un quadro che non aspira alla frigida oggettività, ma alla poetica vicinanza.
Il blues prende il nome dall’espressione “avere i diavoli blu” per esprimere un senso di tristezza e profonda malinconia, ed è una musica detta anche stonata. Come stonate sono le visioni di Creanza, fuori dall’immaginario precotto di media che cercano lo spettacolo e l’effetto emotivo facile; accordi stonati come la storia sulla minoranza copta, tema scottante e sospeso, che viene presentato in modo funzionale ad ideologie di sistema in Europa, e che diviene invece attraverso questa breve storia un pezzetto comprensibile, attuale, con visi e occhi. Stonato è sbagliarsi nella metropolitana e andare come “uno stupido turista” nel vagone riservato alle donne.
Con il suo sguardo “strabico” Pino guarda con empatia, ma anche con una distanza partecipe, un paese che è tuttora sconosciuto ai nostri connazionali, che non vedono nulla oltre alle piramidi e ai fondali del Mar Rosso, turisti gated community, non molto diversi dalle comunità chiuse dai cancelli dei nuovi business men egiziani. E ne coglie con grande sintesi elementi di contraddizione, cartografando le pulsioni nascoste. Queste radiografie visive hanno dimostrato quanto lo strabismo della curiosità sia una specie di qualità mantica. Così nella storia “Kifaya”, pubblicata nel 2010, Creanza evidenziava lo stridente contrasto tra interessi comuni dei poteri forti egiziani e americani, la banalità dell’occidentalizzazione globalizzante e l’utilizzo degli stessi mezzi per ritrovare la propria voce del popolo del dissenso. All’epoca, ovvero neanche un anno fa, gli osservatori prezzolati di questi paesi non prevedevano cambiamenti in atto, parlavano quasi con stima di Mubarak, considerandolo un “filoccidentale democratico” contrapposto ai fondamentalisti. Eppure, sono bastati pochi mesi per ribaltare completamente la situazione e far vedere il marcio che bolliva sotto l’aura di apparente legittimità politica. L’autorità che si sorregge sull’autoritarismo spesso è mascherata di una parvenza decorosa; utilizza rituali comuni e nasconde nella procedura democratica l’assenza di valori democratici come la difesa delle minoranze, la coesistenza con il dissenso, il ricambio generazionale e sociale. Tutti ingredienti assenti nel paese del generale deposto, e che purtroppo latitano anche alle nostre latitudini.
L’efferato omicidio della pop star libanese Suzanne Tamim nel 2008, che ha interessato la stampa ufficiale e scandalistica di tutto il mondo arabo per circa due anni è un episodio che evidentemente fa venire “i diavoli blu”. Ha scosso l’opinione pubblica, è stato utilizzato come calmiere sociale per dimostrare che la giustizia esiste anche per i potenti, ha messo in discussione indirettamente il movimento contro la pena di morte in Egitto. L’epilogo, che ovviamente non compare nella storia di Creanza perché scritta prima, la dice lunga. Il potente imprenditore e affarista incriminato alla pena capitale non è stato sentenziato per un vizio di forma ed è stato condannato a 15 anni di reclusione. Pare che durante le rivolte del 2011 sia riuscito ad evadere di prigione.
Così aspettiamo il secondo episodio di questa storia paradigmatica e struggente, che porta in sé tutte le pillole del foiletton, purtroppo tragicamente reale. Successo, affari, politica, amore, gelosia, sangue. Quello che rimane sono le parole “I will not shut up” di una nota canzone della Tamim e che è anche il titolo della storia di Pino: “non starò zitta”, parole che suonano profetiche per la scelta di alzare la voce di tante giovani nelle piazze del Cairo.
Lo sguardo della sfinge del fumetto - Magdy El Shafee
Pubblicata su Egitto senza piramidi, GIUDA edizioni (2011)

Metro è la prima Graphic Novel egiziana ed è per questo che sulla copertina era specificato nella versione araba “solo per grandi”. Il fumetto nel mondo arabo e in particolare in Egitto, ha una storia travagliata e strettamente connessa al clima politico.
Indubbiamente la vicenda figurativa dell’Egitto contemporaneo, e in parte anche di tutto il Maghreb, ha inizio con l’arrivo di Napoleone Bonaparte. Come sempre, un incontro, anche se conflittuale, fa sempre scaturire anche qualcosa di nuovo. L’innovatore Mohamed Alì avvia un’intensa attività di scambi culturali, traduzioni e invia studenti a formarsi in Europa, anche in Arte. Questo passaggio storico, chiamato “la Rinascita”, costituisce un punto di svolta importante per la cultura figurativa di tradizione islamica, perché permette di superare in parte il tabù visivo legato alla rappresentazione realistica di figure animate, escluse per secoli dall’ambito pubblico, e tollerate in ambito strettamente privato. Divieto dovuto all’interpretazione dei teologi e non ad una indicazione del Corano, tuttavia esso ha avuto un valore e un significato che costituisce il trait d’union di una tradizione visiva che condotto un mondo amplissimo geograficamente e diverso per tradizione e cultura ad attestarsi per secoli a rappresentazioni geometriche e alla cura della calligrafia come forme alternative d’arte. Questa premessa è fondamentale per comprendere perché nel mondo arabo e in particolare in nord Africa i disegnatori siano stati così spesso e duramente colpiti dal potere.
La prima pubblicazione illustrata, ovviamente per bambini, nasce comunque in Egitto nel 1893, Al-Samir Al-Saghir, seguita poi negli anni ‘40 da altre due pubblicazioni sempre per l’infanzia e sempre nate in Egitto.
Curioso notare che pochi mesi prima del colpo di stato di Nasser nasce sempre in Egitto il primo giornalino a fumetti propriamente detto, Sindabad. Curioso notare la simmetria geografica e storica di eventi di per sé così diversi e lontani: la nascita di una rivista a fumetti per bambini e l’uscita di Metro, primo romanzo grafico del mondo arabo, sono entrambi strettamente connessi a cambiamenti politici in corso, come se l’immagine e la retina percepissero in anticipo l’arrivo del terremoto. Cosa che non si può dire per molti osservatori politici e giornalisti, che certo non avevano predetto la fine di Mubarak.
Negli anni ‘60 si riversa una grande produzione di origine belga e francese, che però non mina completamente la produzione in lingua araba. Anzi, il partito Baath, al potere in Iraq e in Siria, finanzia direttamente due riviste Majallaty e Usamat.
Ci sono poi ovviamente le traduzioni dal francese e dall’americano, ma non mancano importanti autori, anche di ambito politico soprattutto di impronta satirica a calcare la scena. Ad esempio il famosissimo e sempre egiziano Ashraf Hamdi, che ha come personaggio principale oggetto della sua satira Gheddafi: “Vorrei dire al popolo libico che con la rivoluzione sta facendo un grave danno a noi disegnatori satirici. Come faremo senza Gheddafi?” ha ironicamente sostenuto in un’intervista. E difatti è la satira a farla da padrone per diversi decenni in tutto il mondo arabo ed anche in Egitto.
La scelta di Magdy di raccontare una storia lunga, senza tratti satirici, che ha come fondo la critica sociale, ma che al contempo si muove sulla trama consolidata dell’amore e dell’avventura, è un discrimine importante per la forma fumetto in lingua araba, dove c’è sicuramente un movimento tellurico di giovani disegnatori che producono riviste (vedi ad esempio i libanesi di Samandal), storie brevi, vignette, ma ancora non era uscita un’opera Paese. Ci sono difatti disegnatori che provengono dal nord Africa o dal Medio Oriente e che in Francia o in altri Paesi europei hanno disegnato storie lunghe, ma sono testi che non si rivolgono al pubblico dei loro connazionali. Spesso infatti hanno un forte tratto malinconico, un acerbo senso di spaesamento, e l’intento è di parlare una lingua che comunichi questa identità in movimento a chi è nel paese ospite.
Il romanzo grafico di formazione Persepolis, scritto non in farsi ma direttamente in francese, dalla disegnatrice iraniana Satrapi non si rivolge agli iraniani per sua esplicita dichiarazione. È un lavoro nato con l’intento di dimostrare che non tutti i persiani sono brutti, cattivi e terroristi. E che si può sopravvivere avvalendosi della potente arma dell’ironia, anche quando si è costretti all’esilio.
Il traduttore italiano di Metro fa bene a sottolineare anche l’aspetto prettamente linguistico di questa diversa scelta: El Shafee non ha deciso di scrivere in arabo classico, una lingua frigida e lontana dalla strada, che come tutte le lingue generate a tavolino e che devono dimostrare senza alzare il dito uno status sociale, poco o niente hanno di pathos e di profondità. Invece senza paura Magdy sceglie il dialetto egiziano, quello che parla la gente, quello che risuonava a piazza Tahrir.
Metro segna il territorio, lo si vede dalla lingua scelta, dal linguaggio utilizzato, dalla scelta narrativa di seguire le stazioni della metropolitana. Un luogo lontano dalle piramidi e dalle spiagge per turisti del Mar Rosso. Un luogo in cui i nomi delle fermate evocano chiaramente la storia recente dell’Egitto, Nasser, Sadat, addirittura Mubarak. Come se la metro di Milano avesse la fermata Berlusconi.
La geografia è una rappresentazione grafica di un territorio che mai potremo possedere in altro modo, è il nostro sguardo sulla terra e la nostra interpretazione. Muoversi nelle fermate della metropolitana e conoscere simbolicamente l’underground de Il Cairo è possibile attraverso le strisce di Magdy, che si rivolge principalmente ai lettori del suo Paese, che sfortunatamente per colpa della censura non lo possono leggere. È un’occasione per noi di godere di un privilegio ad altri negato.
The traveller with binoculars - Aleksandar Zograf
Komikazen 6° Festival internazionale del fumetto di realtà, Ravenna 2010

Zograf, well-known not only to readers of comic strips, but also to those who have carefully followed events in the countries on the other side of the Adriatic, represents one of the best
examples of how comics, contemporary history and reporting by pictures, can be correlated. The artistic work of this journalist-cartoonist is centred on the representation of reality, seen with
the oneiric eye of a cartoonist who wants to represent himself as the candid eye of observation. This oneiric aspect and that of the research into the processes behind the development of dreams
and the mechanisms implicit in them constitute one of the themes that is transversal to his work (as evidenced also by the book Psiconauta, also published in Italian).
Certainly Zograf became famous during the 1990s following the bombardment of his little town, Pancevo, and the letters and stories in comic form that were published in the USA and then also in
Italy, while NATO was launching its so-called intelligent missiles. But Zograf had already been active since the end of the 1980s and thanks to this previous activity of his he had contact with
numerous cartoonists around the world.
He was published at that time in publications with limited circulations or that he produced himself, but the fundamental elements of his style were already there in embryo. The disenchanted and wide-eyed view, the strong subjectivity with which the reader finds himself looking at and reading the stories, the line that recaptures a certain naive way of drawing. All this was already present even then.
Certainly the difference in his comic strip production lies elsewhere, that is in putting himself at the centre of the narration of his own stories. This aspect became a distinguishing feature of the Serb cartoonist immediately after the bombardments. His incredulity in the face of what he was experiencing and the need to recount how daily life was carried on while the “unwritten” rules of war-time were being broken, motivated him to make himself the principal character of his comic strip. He wanted in this way to emphasise his highly subjective approach (he was not trying to be a journalistic or historical chronicler) and at the same time he certainly sharpened his perception of reality in what he was recounting, given that one of the things that one loses most quickly in war-time conditions is a recognition of what is happening to the enemy and wherein lies truth in information. Hence there appeared both a sense of limitation (I am telling you this story solely from my modest point of view), and of truthfulness (it is my life and I am in it).
This way of story telling then became Zograf’s stylistic monogram, whether he recounts to us brief and thunderous snippets about the cities that he visits, or when he causes us to break into his dreams. This traveller with the binoculars of the visual metaphor leads us to discover details and continents that our eyes, myopic from the habit of seeing things half asleep, could not otherwise know.
Logica delle figure. Logicomix
Komikazen 6° Festival internazionale del fumetto di realtà, Ravenna 2010
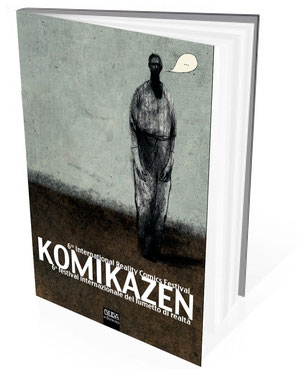
Ho partecipato a molte presentazioni del libro Persepolis con Satrapi quando uscì in Italia e posso testimoniare che tutte le volte c'era qualcuno che faceva la stessa domanda all'autrice:
“Perchè non ha fatto un libro e ha fatto un fumetto per raccontare questa storia?”. Marjane prendeva in mano il volume e ripeteva la stessa frase: “Ma io ho fatto un libro”. C'è dietro questo
apparente fraintendimento, un preciso blocco culturale, un pregiudizio inconscio o latente, ovvero il fumetto anche se assume la forma libro non è ancora adulto per poter essere considerato tale.
Come se la forma diventasse per forza il contenuto. Come se le figure automaticamente ne abbassassero la qualità e l'affidabilità. Le immagini tradiscono, tuttavia le immagini sono da sempre
state le prime forme narrative del genere umano. E il fumetto non è altro che una delle evoluzioni della narratività figurativa. Ma è come se la potenza magica e sovversiva, non controllabile
(anche se su questo bisognerebbe soffermarsi...) dell'immagine ne condannasse la fruizione e ne limitasse la possibilità di raccontare storie e soggetti.
È vero che ci sono esempi di presenza della matematica e dei suoi temi nel fumetto, anche in quello popolare come Martyn Mistere, Lazarus Ledd e altri: in alcuni esempi l'aspetto evocativo, fortemente metaforico di locuzioni o lemmi della matematica vengono utilizzati per acuire elementi di mistero o fascinatori del racconto. Ci sono anche storie più ampie, anche se un po' didascaliche, come Ultima lezione a Gottinga dove l'intreccio parte da un'ambientazione durante il nazismo (sembra che per il fumetto sia diventato un leit motiv) per parlare della teoria dell'infinito di Cantor. La matematica, ma anche la fisica e la scienza hanno fornito non solo qualche spunto, ma anche provocazioni visive al mondo del fumetto.
Logicomix apre sicuramente un altro capitolo nella possibilità del fumetto di narrare: non tanto per la forma (lo stile del disegno è tradizionalmente francese), ma certamente per la modalità con cui si affronta il contenuto, che non è solo la biografia di genio e follia, ma la possibilità di rappresentare questioni di logica ed etica, raccontando una storia.
Incentrato sulla figura di Bertrand Russell, Logicomix. Un'epica ricerca della verità, è stato un caso editoriale sia in Grecia, dove è uscito nel 2008 per la prestigiosa casa editrice Ikaros, ma anche in Olanda e soprattutto negli Stati Uniti, dove il giorno dell'uscita della prima edizione è andato esaurito, entrando nella top list anche di amazon.com.
Il successo editoriale del progetto risiede probabilmente nella verve che permette anche ai non addetti alla materia di avvicinarsi a temi affascinanti e complessi. La narratività che usa la cornice degli autori come guide nelle domande che conducono il racconto della vita di Russell, la scelta di approfondire in modo diretto e coinvolgente gli aspetti biografici dello stesso Russell, facendoli raccontare da questi in prima persona, possono in parte spiegare come questo libro abbia appassionato un pubblico ben più ampio di quello del fumetto d'autore.
L'obiettivo finale di Russell, la creazione di un fondamento assoluto per la matematica e la logica, è sempre stato un inafferrabile sogno ossessivo e gli autori di Logicomix sono riusciti perfettamente a rendere il senso di nostalgia nella vita di Russell per questo obiettivo che risulta impossibile Si delinea così il tema principale del libro: la tensione tra la razionalità, la precisione, la certezza e l'umano mondo delle passioni. Nel definire i termini e la verifica dei sistemi di coerenza, Russell non si muove in un contesto isolato e attraverso il suo racconto incontriamo altri padri della logica moderna, personaggi del calibro di Frege, Cantor, Dedekind, Hilbert e ancora Whitehead, Wittgenstein. La grande abilità degli sceneggiatori, Apostolos Doxiadis e Christos H. Papadimitriou, sta nel sapiente processo di rielaborazione, semplificazione, riduzione e invenzione, non raccontando semplicemente una storia della matematica e del pensiero logico, ma intervenendo in prima persona nel flusso del racconto, ponendo dubbi e domande sul proprio lavoro e riflettendo a voce alta sullo sviluppo della storia. La forza di questo libro sta nel suo riflettere sulla narrazione, porre quindi un'ulteriore provocazione alla possibilità del fumetto: di fatto poi questo atteggiamento metanarrativo coincide in un certo senso con la competenza logica e con la riflessione sulla matematica.
Il fumetto di realtà tra figurazione narrativa e giornalismo
Komikazen 6° Festival internazionale del fumetto di realtà, Ravenna 2010

Da quando è nato Komikazen, 6 anni fa, e dalle prime mostre di Mirada su Sacco e Satrapi, molte cose sono cambiate nel mondo poliedrico e strutturalmente “povero” del fumetto.
Il termine “fumetto di realtà”, coniato da noi per definire un oggetto che intravedevamo come nuovo e aperto a un diverso pubblico di lettori e autori, è diventato un soggetto capace di attirare l'attenzione di editori sempre più alla ricerca di nuove vene narrative, di riviste che cercano spazi di rappresentazione diversa del reale, di un mercato dell'arte fagocitatore e votato al global market, di ONG e organizzazioni umanitarie che cercano nuove vie per raccontare i temi che costituiscono il cuore del loro lavoro o strumenti per attività sul campo.
Se da un lato questo costituisce indubitabilmente una ricchezza e una nuova frontiera, allo stesso tempo non sempre è presente una capacità di lettura del medium all'altezza della sfida: tale
povertà di lettura del mezzo si può così sintetizzare.
Il fumetto non è affrontato come linguaggio a se stante, prevale la “grandezza del mezzo”, la valutazione della serietà del tema, mentre non sempre il risultato è coerente con il soggetto. Non basta parlare di povertà per fare un bel fumetto. Non basta affrontare un tema importante perché la storia funzioni. Se da una parte autori che hanno indubitabilmente contribuito alla creazione di questo scenario, come Joe Sacco, dichiarano che lo spazio di ricerca del fumetto è ancora un continente inesplorato, dall'altra spesso i risultati presentati anche da progetti editoriali importanti scivolano su una banalità didascalica difficile da mettere in discussione.
Gli aspetti sicuramente più significativi e di qualità emersi tuttavia non mancano. L'approccio di “realismo dialettico” capace di produrre un processo critico nel lettore emerge in alcune produzioni, come ad esempio nel libro collettivo Gaza. Una rappresentazione che prende le distanze, denunciando la propria incapacità di essere testimone diretto e significativo, che però non demorde dalla volontà di stabilire un processo di decostruzione di un realismo propagandistico, fatto di semplificazioni e slogan.
In un rapporto di incontri e abbandoni, il fumetto ritorna alla Figurazione Narrativa, la corrente artistica della fine degli anni '60, che era partita anche da una mostra di Bande dessinée e che dal fumetto ha molto saccheggiato. Nell'uscita dal mondo a strisce, nel limitare figurativo di uno stile come quello di Auladell, che mette a dura prova la tradizionale sequenzialità per stare anche immoto in una narrazione che si concentra anche in un'unica immagine, vediamo concentrarsi le nuove potenzialità di questo nuovo modo di narrare.
Autori invece che hanno nelle proprie bibliografie storie che sono nate da trasfigurazioni di realtà come Igort, hanno proceduto ad un lavoro di certosina purificazione della fiction per cercare una voce vera nella trascrizione dei testimoni incontrati in viaggio. Mentre un autore come Zograf, antesignano del genere e membro ormai a pieno titolo della nouvelle vague balcanica della nona arte, hanno messo a punto una tecnica narrativa che mescola visivamente la realtà sperimentata con il sogno e l'immaginazione. Fenomeni editoriali come quello di Logicomix denotano come non esistano più peraltro riserve di argomenti inviolabili da parte del fumetto. E la piccola finestra aperta sul mondo delle ONG che utilizzano il fumetto come strumento di lavoro per conseguire risultati etici, il cambiamento della realtà in cui operano e non solo la sua rappresentazione, è solo un piccolo assaggio di un territorio che sta diventando abitato da un folto numero di abitanti...
The Geography of the Confession. Igort’s Ukrainian Notebooks
Komikazen 6° Festival internazionale del fumetto di realtà, Ravenna 2010

Stories about hunger all reek of the same privation and the same sadness. When hunger strikes it suppresses the ability to react, it makes people passive and aggression is consumed in a trice, immediately overcome by a feeling of tiredness. When it comes to hunger the populace finds it difficult to single out a culprit: in traditional societies there generally prevails a feeling of being punished because of having been unfaithful to their gods/god, or a sense of unyielding impotence. The story of the famine of 1932-33 in Ukraine has certain peculiarities that contrast with this tragic scenario. Although historians are not unanimous on the theories relating to the Ukrainian genocide, the idea that the collectivisation enforced by Stalin was one of the principal causes of this famine called the Holodomor that mowed down a still uncertain number (between one and a half million and ten million), is nevertheless a fact recognised by all. Even the scholar Douglas Tottle, who was interested in the use of the Ukrainian famine as a propaganda tool of Nazi fascism, does not dispute the fact that the famine actually occurred and that it wiped out an awfully large number of people nor that the role of Stalinist policies was a determining factor.
The political and physical confrontation between the Kulaks, the landowners, and the regime took place in one of the most fertile places in the world, that in just a few months became a sterile, unyielding land. There was a swift laying of blame by the Ukrainians for this terrible tragedy. This apportioning of blame contributed to the creation of a national identity for the modern-day Ukrainian state that officially commemorates that tragic period with a national ceremony.
Igort, a curious traveller, stumbled upon the stories of life in Ukraine, Russia and Siberia, and began to do what artists who tell stories do, that is to convert the pictures and the people he met into his own images. The first book is dedicated, however, solely to the Ukraine and in particular to the Holodomor, the great homicidal famine.
The majority of the testimonies relegate into second place the presence of the author and the reasons that moved him to carry out this intricate work drawn from the personal memories of the witnesses he met. Nevertheless this book is still primarily a travel journal. Igort is not a pupil of Duccio Demetrio, the landscape of the inner person that emerges from the x-rays he takes of others people’s memories is not conscious. He does not just listen to the words of the witnesses he meets on this two year journey, but he creates for them a visual aide memoire, that obviously is nothing more that his memory imagined from the life experiences of others. A journey is dangerous territory, it is a ford, a transitional bridge towards a foothold in the place that lies at journey’s end. A travel journal is a form of support for this esoteric path, the tangible proof of it having been travelled. Furthermore, ever since the time of Ulysses, within its genetic makeup a journey has an insistence on having an audience, someone to whom to narrate the things discovered, transfiguring them. The transfiguration finds its substance in its comic-strip format: the medium self-condemns this work of subjective representation of the memory.

The logic of the pictures. Logicomix
Komikazen 6° Festival internazionale del fumetto di realtà, Ravenna 2010

I have participated at many presentations of the book Persepolis with Marjane Satrapi when it was published in Italy and I can testify that on each occasion there was someone who asked the author
the same question: “Why, instead of producing a comic strip, did you not produce a book to tell this story?” Marjane took the tome in hand and repeated the same words: “But I have made a book.”
Behind this apparent misunderstanding there is a definite cultural block , a sub-conscious and latent prejudice, that is that a comic strip even in the form of a book is still not adult enough to
be considered as such. As though the form perforce becomes the content. As though the pictures automatically lower the quality and the reliability. The images betray, and yet images have always
been the primary narrative form of the human race. And the comic strip is no more than a part of the evolution of narrative imagery. But it is as though the magical and subversive power, the
uncontrollable force (even though we would need to think about that…) of the images condemn their usage and limit their ability to recount stories and discuss matters.
It is true that there are examples of the presence of mathematics and its themes in the comic strip, even in popular ones such as Martyn Mistere, Lazarus Ledd and others: in certain examples the evocative, highly metaphorical nature of the expressions or key words of mathematics are used to sharpen the elements of mystery and fascination of the tale. There are also more expansive stories, even if they are somewhat didactic, such as Ultima lezione a Gottinga in which the interweaving diverges from a setting in the Nazi era (it seems that it has become a leitmotiv for the comic strip) in order to address Cantor’s theory of infinity. Mathematics, but physics and science too, has not only supplied the world of the comic strip with some ideas, but also with visual challenges.
Logicomix certainly opens up another chapter on the comic strip’s capability to narrate: not so much in terms of its form (the style of drawing is traditionally French), but certainly in the way in which it addresses the content, that is not just the biography of genius and folly, but the possibility of representing questions of logic and ethics, by telling a story.
Centred on the figure of Bertrand Russell, Logicomix. An Epic Search for Truth, was a publishing event not only in Greece, where it was published in 2008 by the prestigious publishing house Ikaros, but also in Holland and particularly in the United States, where it sold out on the day the first edition was released, also getting onto the best seller list of amazon.com.
The publishing success of the project probably lies in the vitality that enables even those not used to the matter to get to grips with fascinating and complex themes. The narrativity that uses the authors’ framework as a guide in the questions that conduct the recounting of the life of Russell, the choice of expanding the biographical aspects of Russell himself in a direct and involving manner, making them recount them in the first person, may in part explain how this book has excited a much wider audience than that of designer comic strips.
Russell’s ultimate objective, the creation of an absolute foundation for mathematics and logic, has always been an elusive and obsessive dream and the authors of Logicomix have succeeded perfectly in conveying the sense of nostalgia in Russell’s life for this goal that turned out to be impossible. The main theme of the book can be summarised like this: the tension between rationality, precision, certainty and the human world of passions. In defining the terms and the testing of the systems of correspondence, Russell does not budge in an isolated context and through his story we meet other fathers of modern logic, characters of the stature of Frege, Cantor, Dedekind, Hilbert and further Whitehead and Wittgenstein. The great ability of the screenwriters, Apostolos Doxiadis and Christos H. Papadimitriou, lies in the skilful process of re-elaboration, simplification, reduction and invention, not simply narrating a story of mathematics and logical thought, but intervening in the flow of the story in the first person, posing doubts and questions on the work itself and reflecting out loud on the development of the story. The strong point of this book is its reflecting on the narration, to pose therefore another challenge to the capability of the comic strip: in fact then, this metanarrative approach matches to some extent the logical capability and the reflection on mathematics.
The reality comic between narrative depiction and journalism
Komikazen 6° Festival internazionale del fumetto di realtà, Ravenna 2010
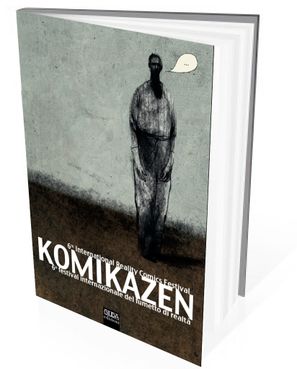
Since the inception 6 years ago of Komikazen and of Mirada’s first exhibitions on Sacco and Satrapi, many things have changed in the multi-faceted and structurally “impoverished” world of the comic.
The term “reality comic”, coined by us to define an object that we saw to be new and open to a different world of readers and authors, has become a subject capable of attracting the attention of publishers who are increasingly on the lookout for new forms of narrative, of magazines that are seeking presentation methods that differ from the real, of an all-consuming art market destined to become a global market, of NGOs and humanitarian organisations that are looking for new ways to recount the themes that form the heart of their work or for instruments for activities in the field.
If on the one hand this undoubtedly constitutes something highly positive and a new frontier, at the same time the ability to read the medium at its highest levels is not always there: this poverty of the reading of the medium can be summarised thus. The comic is not approached like a language in its own right, what predominates being the “importance of the medium”, the evaluation of the seriousness of the theme, whereas the result does not always match the subject. Discussing poverty is not sufficient to make a good comic. Addressing an important matter is not sufficient to make the story work. Although on the one hand authors who have undoubtedly contributed to the creation of this scenario, like Joe Sacco, state that the comic’s scope for investigation is still an unexplored continent, on the other the results produced even by major publishing projects often fall down on a didactic banality that is hard to deny.
Nevertheless, the aspects certainly of most significance and quality that have emerged are not lacking. The “dialectic realism” approach capable of producing a critical process in the reader emerges in some productions, such as for example the collective book Gaza. A representation that distances itself, denouncing its own incapability to be a direct and significant witness, that does not however waver from a determination to establish a process of dismantling of a propagandistic realism, made up of simplifications and slogans.
In a relationship of encounters and abandonments, the comic returns to the Narrative Depiction, the artistic current of the end of the 1960s that also began from an exhibition of ‘bande dessinée’ and that has plundered much from the comic. In coming out of the world of comic strip, we see the new potential of this new way of narrating coming together in the visual limitation of a style such as that of Auladell, that seriously tests traditional sequentiality in order to remain stationary in a narrative that is centred on just a single image. Instead authors who in their own bibliography have stories that were conceived from the transfigurations of reality, such as Igort, have moved on to a work of painstaking purification of fiction in order to find a true voice in the transcription of the witnesses encountered on the journey. Whereas an author like Zograf, a forerunner of the genre and now a fully fledged member of the Balkan nouvelle vague of the ninth art, has perfected a narrative technique that visually blends tried and tested reality with dreams and imagination. Publishing phenomena such as Logicomix indicate, on the other hand, that there are no longer any subject matters that are beyond the reach of the comic. And the small window opened onto the world of NGOs that use the comic as a working tool in order to achieve ethical results, the changing of the reality in which they operate and not just its representation, is just a small foretaste of a world that is coming to be inhabited by a significant number of residents…
Il viaggiatore con il binocolo - Aleksandar Zograf
Komikazen 6° Festival internazionale del fumetto di realtà, Ravenna 2010
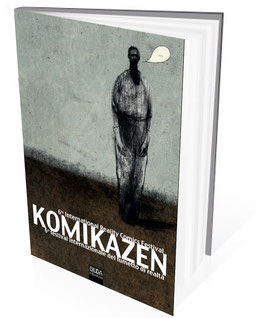
Zograf, conosciuto non solo dal pubblico del fumetto, ma anche da coloro che hanno seguito con attenzione le vicende del Paese oltre Adriatico, rappresenta uno dei migliori esempi di come fumetto, storia contemporanea e reportage ad immagini, possono essere correlati. Il lavoro artistico di questo giornalista - disegnatore è centrato sulla rappresentazione della realtà, letta dagli occhi onirici di un disegnatore che vuole autorappresentarsi come occhio ingenuo di osservazione. L’aspetto onirico e di ricerca dei processi di elaborazione del sogno e dei meccanismi a questo sottesi costituiscono una delle tematiche trasversali al suo lavoro (come testimonia anche il libro Psiconauta, pubblicato anche in italiano).
Certo Zograf è diventato famoso negli anni ’90 a seguito del bombardamento della sua cittadina, Pancevo, e delle lettere e delle storie a fumetti che venivano pubblicate negli USA e poi anche in Italia, mentre la NATO gettava i cosiddetti missili intelligenti. Ma Zograf era attivo già dalla fine degli anni ’80 e grazie a questa sua precedente attività aveva contatti con numerosi disegnatori nel mondo.
Veniva pubblicato all’epoca su pubblicazioni di piccola tiratura o in autoproduzioni, ma gli elementi fondamentali del suo stile erano già tutti presenti in nuce. Lo sguardo disincantato e stupito, la soggettiva forte con cui il lettore si trova a guardare e leggere le storie, il tratto che riprende un certo modo di disegnare dei naif. Tutto questo era già presente anche allora.
Sicuramente lo scarto nella produzione a fumetti è stato di altro tipo, ovvero nel mettere se stesso al centro della narrazione delle proprie storie. Tale aspetto è diventato un tratto peculiare del disegnatore serbo proprio a seguito dei bombardamenti. L’incredulità di fronte a quanto stava vivendo e la necessità di raccontare il procedere della quotidianità nella rottura delle regole “non scritte” del tempo di guerra lo spinsero a scegliere di diventare lui stesso il personaggio principale dei suoi fumetti. Egli in questo modo desiderava sottolineare il forte sguardo soggettivo (non puntava alla cronaca giornalistica o storica) e acuiva sicuramente allo stesso tempo la percezione di realtà di quanto stava raccontando, visto che una delle cose che si perde più presto quando si sta in guerra è la cognizione di cosa accada al nemico e dove stia la verità dell’informazione. Quindi comparivano sia il senso del limite (vi racconto questa storia unicamente dal mio modesto punto di vista), sia della veridicità (è la mia vita e io ci sono dentro).
Questa modalità narrativa è poi diventata la cifra stilistica del lavoro di Zograf, sia che lui ci racconti brevi e fulminanti frammenti delle città che visita, sia che ci faccia irrompere nei suoi sogni. Questo viaggiatore con il binocolo della metafora visiva ci porta a scoprire dettagli e continenti che i nostri occhi miopi da un'abitudine allo sguardo assopito diversamente non potrebbero conoscere.
Geografia della confessione. Quaderni Ucraini di Igort
Komikazen 6° Festival internazionale del fumetto di realtà, Ravenna 2010

I racconti di fame odorano tutti della stessa assenza e della stessa malinconia. La fame quando colpisce attutisce la reattività, rende passivi e l'aggressività si consuma in pochi attimi, subito vinta dalla stanchezza. Verso la fame di solito le popolazioni faticano a trovare colpevoli: in genere prevale nelle società tradizionali il senso di punizione dovuta al tradimento degli dei/dio, oppure un senso di implacabile impotenza. La narrazione della carestia tra il '32 e il '33 in Ucraina ha alcune peculiarità rispetto a questo tragico canovaccio.
Sebbene gli storici non siano concordi sull'ipotesi di genocidio ucraino, l'idea che la collettivizzazione forzata di Stalin sia stata una delle cause principali di questa carestia chiamata Holodomor e che ha falciato un numero ancora imprecisato (tra un milione mezzo e dieci milioni di persone), è ormai un dato riconosciuto da tutti. Anche lo studioso Douglas Tottle1, che si è interessato all'uso propagandistico della fame ucraina da parte del nazifascismo, non mette in discussione il fatto che la carestia ci sia stata e che abbia falcidiato un numero altissimo di persone e che il ruolo della politica staliniana sia stato determinante. Lo scontro politico e fisico tra kulaki, ovvero proprietari terrieri, e regime si consumò su una delle regioni più fertili del mondo, che in pochi mesi divenne una terra sterile e taccagna. C'è stata un'attribuzione di colpa repentina da parte degli ucraini per questa terribile tragedia. Questa attribuzione di colpa ha contribuito a creare l'identità nazionale dell'odierno stato ucraino che commemora ufficialmente quel tragico periodo con una cerimonia nazionale.
Igort viaggiatore curioso si è imbattuto nelle storie di vita tra Ucraina, Russia e Siberia, e ha cominciato a fare quello che fanno i disegnatori che raccontano storie, ovvero trasferire in segno proprio le immagini e gli uomini incontrati. Il primo libro è dedicato però unicamente all'Ucraina e in particolare all'Holodomor, la grande fame omicida.
La prevalenza delle testimonianze mette in secondo piano la presenza dell'autore e le ragioni che l'hanno spinto a questo lavoro di ricamo disegnato della memoria singolare dei testimoni incontrati.Tuttavia questo libro è pur sempre prima di tutto un diario di viaggio. Igort non è un allievo di Duccio Demetrio, la geografia del privato che traspare dalla sua radiografia del ricordo altrui non è consapevole. Egli non solo ascolta le parole dei testimoni incontrati in questo viaggio di due anni, ma crea per loro un materiale mnemonico disegnato, che ovviamente non è altro che la propria memoria immaginata dell'esperienza di vita altrui. Il viaggio è un territorio rischioso, è un guado, un ponte di transizione verso un appiglio nel luogo che è “là”. Il diario di viaggio è una forma di sostegno di questo percorso iniziatico, la prova tangibile che si è percorsa quella via. Il viaggio inoltre ha nel proprio corredo cromosomico la volontà di avere un pubblico, qualcuno a cui narrare da Ulisse in poi, quello che si è scoperto, trasfigurandolo. La trasfigurazione diviene concreta nella sua forma fumettistica: il medium autodenuncia questa opera di figurazione soggettiva del ricordo.
Anche se Igort ci tiene a segnalare che la passione documentaria gli proviene dal cinema, e cita Wenders di Tokio Ga e Buena Vista Social Club, Herzog, ma anche Capote e Celati per la letteratura, l'autore che più emerge presente in questa costruzione documentaria che intreccia storie di vita e rapporti appena resi pubblici della polizia segreta, resi sempre dall'autore mediante parole e disegni, è il narratore “semplice” Cechov, il Cechov non ancora simbolista, teso alla sobrietà del racconto e alla purificazione da patetismi di ogni genere.
Il fumetto non è nuovo all'indagine del dopo muro. I primi ad oltrepassare la cortina furono Felipe H. Cava e Raùl, che con due viaggi differenti nel 1990 e nel 1993 si posero con Ventanas a Occidente2 quesiti simili a quelli del disegnatore italiano un anno prima della dissoluzione dell'URSS e pochi anni dopo il putch del 1991. Che cosa rimane del grande sogno sovietico? Quale memoria ricostruita, quali speranze inevase o deluse, tutti quesiti che interessano direttamente anche parte dell'Europa, che a quell'utopico miraggio aveva guardato con interesse o paura.
La necessità di misurarsi con il lavoro in diretta, sul campo fuori dallo studio, abbina questi percorsi di ricerca, anche se nel lavoro del duo spagnolo prevale l'intento interpretativo, mentre in quello di Igort c'è un'evidente urgenza di semplicità narrativa e visiva che avvicina appunto alla prosa cechoviana le storie narrate. Ne emerge Un luogo che non è altro che tempo, per dirla con la filosofa spagnola Zambrano citata da Raùl. E non è nel luogo che si svolge la ricerca documentaria di Igort, ma effettivamente nel tempo. E se è l'incontro, che come la poesia giunge non richiesto, la miccia che fa scaturire le storie di Quaderni Ucraini, è nel metodo di lavoro che sta il cuore del lavoro. Sempre Zambrano, che sul tema della confessione e della narrazione del sé ha scritto pagine importanti, diceva Non si scrive certamente per esigenze letterarie, ma per l’esigenza che ha la vita di esprimersi3,e quindi la scelta di modulare il proprio registro stilistico su quello documentario esprime proprio la percezione di essere un canale, un recettore, attraverso cui “la vita si esprime”. È una confessione indiretta, la porta del parroco che ascolta, ma laica, per cui si può utilizzare uno strumento pericoloso come il disegno. Esso difatti non disambigua. Rende solo percettibile senza ulteriori mediazioni la soggettività dell'autore. E qui il confessore si autodenuncia. Non riporta le parole come se “le avessero dette i testimoni incontrati”, ma disegnando le storie, i volti, trattenendo e dimenticando dettagli, tracciando il proprio segno indiscutibile sulla carta, liberando la confessione dal tempo dell'inizio, da quel momento preciso in cui accade per renderci partecipi e anche noi confessori involontari di questa mappa che altro non è se non l'incontro con la nostra tenerezza.
Perché le storie surreali che la fame e la disgrazia interpellano ci portano irrimediabilmente a far i conti con i nostri nonni affamati, con le storie delle nostre famiglie avvinte da guerre non da loro dichiarate, da tutti i sommersi e salvati che nella nostra ricucita biografia sentimentale tutti recuperiamo nella memoria del cuore. E da questo incontro non può che nascere l'empatia di un'umanità lacerata e dolente, che però non rinuncia a trasferire nel narrare le storie la malinconica speranza che ciò possa non più accadere.
1D. Tottle, Fraud, Famine and Fascism. The Ukrainian Genocide from Hitler to Harvard, Canada 1987.
2H. Cava – Raùl, Ventanas a Occidente, Spagna 1994, tr. fr. 1994 per Amok.
3M. Zambrano, La confessione come genere letterario, Milano 1997 p. 40
Il villaggio del lungo sonno. Un romanzo a fumetti sulla comunità operaia che non c'è più - Davide Reviati
pubblicato in Hamelin 23, 25 settembre 2009

Ogni periferia ha un centro di cui essa costituisce la costola, e allo stesso tempo la periferia non ha un suo centro. Il villaggio invece ha un suo cuore, è una comunità. Il villaggio Anic, il contesto nel quale è ambientato il romanzo a fumetti di Davide Reviati, fa parte di quelle realtà urbane ibride, non più villaggio che nasce in un contesto rurale o costiero, ma neanche periferia di una città.
Il villaggio operaio dell’Anic a Ravenna viene realizzato per volontà di Enrico Mattei alla fine degli anni ’50, in quella strana stagione italiana dell’industrialismo assistenziale statale. Il primo progetto, detto il Piano Unitario, prevedeva un’estensione del Villaggio su 90 ettari, un numero cospicuo di alloggi, otto asili, due scuole elementari, una scuola media, un ambulatorio, otto mercati-cooperative, due centrali termiche, tre auto rimesse, una zona sportiva provvista di un campo sportivo, un campo da pallacanestro, una piscina, quattro campi da tennis ed una zona centrale composta da un teatro, un grande magazzino, un centro sociale pensato come sala riunioni, sala feste e cinema, un complesso parrocchiale, formato dalla chiesa con il battistero e la canonica ed infine un «palazzo civico»1. La morte di Mattei frenò questo progetto di ampio respiro e si passò ad un investimento minore, con meno servizi e soprattutto non collegato alla città.
Questa zona di frontiera, ubicata con un corridoio di tolleranza tra la città sonnolenta e la linea costiera nord, rimarrà un aspetto peculiare di questa parte di Ravenna fino agli inizi degli anni ’90. Per questo il villaggio assunse le caratteristiche di un’entità autonoma con regole proprie (anche edilizie: molta parte degli edifici sono stati condonati in seguito dal Comune…). Il progetto finale effettivamente realizzato e terminato nel 1964 aveva diminuito di circa 80 ettari l’estensione prevista per l’investimento e come servizi furono costruiti un asilo, una scuola elementare, uno spaccio ed una baracca che faceva da chiesa, mentre il centro sociale del Piano Unitario del 1958 si limitò ad alcune stanze al pian terreno di un edificio. La chiesa sarà costruita alla fine degli anni Sessanta e le infrastrutture sportive negli anni Settanta.
Esso ha ora cambiato nome, non volendo essere da meno di Leningrado che è diventata San Pietroburgo, anche il Villaggio ha optato per un’identità che ricorre all’annuario sacro, ovvero quartiere San Giuseppe, un santo falegname e vicino agli operai. Ora sono nate villette a schiera colore confetto, abbinate ad altre con colonnati finto dorici in odore di trash periferico piccolo borghese. Un bel parco lambisce il confine del nuovo/vecchio quartiere, a cui è stata data anche una piazza con ufficio delle poste e palestra benessere
Per circa 40 anni il villaggio ANIC, che portava anche nel nome il segno di una forte identità operaia, è stato sentito come una parte estranea alla città: la generazione di Reviati si definisce come “uno del villaggio”, prima che un ravennate, mostrando, anche nella ritrosia di quanti invece si guardano bene dal denunciare la propria provenienza dal villaggio, la forte vocazione identitaria della crescita tra le mura invisibili di questo quartiere satellite. Non è un caso dunque se Reviati alla sua prima prova di romanzo a fumetti vero e proprio, abbia scelto questo luogo come protagonista muto del racconto. Sono evidenti per chi lo conosce anche molte assonanze autobiografiche, ma esse rimangono un brusio, un elemento che sta in filigrana e non al centro della narrazione. Ciononostante l’impegno massimo dell’autore si è concentrato nel non dare elementi biografici e di dettaglio tali da rendere Morti di sonnoun romanzo autobiografico o il romanzo degli adolescenti del villaggio. Il romanzo al contrario è chiaramente la traduzione di quello che è rimasto nel setaccio della memoria dopo che la propria vita si è slavata dei suoi dettagli e ne è rimasto solo il senso. È quindi un racconto archetipico dell’adolescenza nelle periferie villaggesche urbane, con tutto quello che tale mood narrativo si porta appresso. La crudeltà incantata pasoliniana delle rane esplose nei campi, il calcio come strumento di crescita e formazione, il calcio anche come orologio per la ricostruzione della cronologia privata ancorata alla tempistica dei campionati, le suore di Crumb senza appeal sessuale, i destini incrociati di chi resta e di chi parte, il senso di incontrollabile sparizione che accompagna qualsiasi romanzo di formazione, l’errore di grammatica antiestetista messo nero su bianco. La dinamica tra universale e particolare è la flebile linea sulla quale si muove la bicicletta narrativa di Reviati. Le storie che si susseguono, il cui unico protagonista immancabile è appunto il villaggio, compongono un romanzo polifonico in cui l’adulto riconoscerà un pezzetto di giovinezza nel cortile, al contempo il ragazzino forse si identificherà in qualcuno, con ovvio aggiustamento generazionale, non diversamente da quanto succede a chi legge da adolescente oggi Il giovane Holden. Il ritmo narrativo dato dalla sequenza figure / parole mostra una grande attenzione all’evocatività dei luoghi, alla rarefazione del biografico nel poetico, senza sfuggire al realismo. Un realismo che prevede anche il magico, visto che si tratta di ragazzini, come nell’incontro con Teodorico: si tratta di un magico talmente consapevole che nella percezione degli adolescenti diventa esperienza.
C’è anche molta pudicizia. C’è quello che oggi viene chiamato “rispetto della privacy”, che in Italia fa venire la nausea tanto è ipocrita, tradotto invece nel vero senso etico del rispetto. Come in tutte le periferie del mondo nel villaggio ci fu un’entropia interna che portò alla deflorazione di una generazione, quella di Davide appunto, sconfitta e bruciata dai lapilli provenienti dal male del mondo. Eroina, sconfitta storica e disimpegno, effetti secondari e mortali dell’esposizione alla chimica, e altre amenità hanno ridotto la capienza numerica della classe ’60 e non solo. Di tutto questo c’è un sussurro tenace, un eco impaurita che evita la logica sanguinaria e fenomenalistica che impera in molto narrare (sia letterario che documentario). La periferia di Stato ha pagato un debito da strozzini, senza ricordare neanche quando ha contratto il debito e che cosa abbia dato in pegno. Ad ogni modo ha mantenuto una delle sue caratteristiche peculiari, il bisogno di pudore e silenzio.
Come ci ha insegnato Auerbach2, la realtà e la sua mimesi sono gemelli siamesi. Ciascun autore si porta dietro, anche quando scende negli Inferi come Dante, buona parte del suo mondo fisico, politico e sociale. Reviati, oltre a portare nella storia che racconta parte del suo vissuto, ha inserito il suo mondo pudico nella modalità narrativa operata, nel modo di costruire il testo, in polifonia, con rispetto per l’altro, con grande attenzione ai silenzi, senza pietismo. Probabilmente farà anche libri migliori, ma forse nessuno doppierà l’autenticità e la partecipazione emotiva di questo. Un canto gregoriano per un’Italia che non c’è più, anche se esiste ancora l’adolescenza e il suo sguardo.
1 I dettagli sull’evoluzione del Villaggio ANIC sono tratti dalla tesi di laurea di Angela Longo…
2 E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Torino, Einaudi,1956.
Esorcismo mediante disegno
Testo in “Porto dei santi”, Roma, Purple Press, 2009

Penso sia una forma di esorcismo. Un atto di interdizione alla dispersione del tempo, il disegnare. Lo è per senz’altro il disegno realizzato guardando direttamente un oggetto, mentre disegnare qualcosa a mente può avere un diverso significato. D’altro canto, nell’esorcismo antropologicamente inteso si utilizza in molte culture il disegno.
I libri di viaggio spesso sono anche disegnati e per noi, curiosi viaggiatori di sguardi, i carnet de voyage degli artisti sono una straordinaria testimonianza della loro ossessiva battaglia contro l’inarrestabile corruzione della smemoratezza. Quel che rimane dell’esperienza dello sguardo posato in quell’attimo su quel luogo scomparirebbe senza l’azione della matita sulla carta.
Ed è quello sguardo, quella mano che permangono sul foglio in quel momento irripetibile, risultato ben diverso dallo sguardo ricostruttore della macchina fotografica, meravigliosamente rappresentativo, ma non ermeneutico.
Il disegno racconta il viaggio, la sintesi di tutte le migrazioni dello sguardo dell’artista dalla cosa al foglio, il suo personale riassunto del visibile e la sua interpretazione dello stesso. Oltre ad essere un atto di guerra contro l’abuso del tempo, è anche un atto che ci ricorda che l’apparenza esiste nella singola storia. È un atto di umiltà rispetto alla possibilità di possedere il tutto visibile. Non a caso nell’epoca pioneristica della fotografia essa era sentita come uno strumento capace di contenere il mondo da visionari e idealisti come il banchiere francese Albert Kahn, il quale finanziò, fino al crollo di Wall Street del ’29, un gruppo di fotografi con l’obiettivo di registrare i popoli del mondo. Ma ancora oggi, nei faraonici progetti di fotografi come Salgado, c’è questa utopico obiettivo.
Un disegno di viaggio ci racconta meno la somiglianza e più il viaggio e il viaggiatore. È un racconto visivo di quanto ha ricevuto il disegnatore da quella occasione di guardare.
Chi conosce la malattia del viaggio, sa che il desiderio di cambiare cielo non nasce tanto dalla volontà di cambiare vita, come intendeva Orazio, ma è prima di tutto l’inarrestabile desiderio di vedere che ci spinge a partire. Porto dei santi, che cita nel titolo William Burroughs senza rapporto metaforico, ma per complicità e amore, è un raccolto da vision – teller, ed è ovviamente un altro segno ineludibile della volontà del disegno di raccontare quanto l’artista ha imparato da quella esperienza di visione.
Dionysus in Iraq
Catalogo "Daily Iraq"
LibriAparte, 2009

Sir Patrick Leigh Fermor is regarded as one of the leading travel writers. For the British Army, however, he also coordinated the Cretan resistance against the Nazis in 1944. In this role, he had a rather daring – but ultimately successful – idea. He organized the capture of the Reich Commander, General Kreipe, using Greek resistance fighters dressed as Germans. The prisoner was kept hidden in a cave, where one day the Englishman watched him as, lost in reverie, he gazed at the snow-covered slopes of Mount Ida and began to murmur an ode by Horace, “Vides ut alta stet nive Candidum Soracte”. The future British baronet impulsively continued the Latin poem by memory. The astonished Nazi general replied, “Ach so, Herr Major” and then added, “We have both drunk at the same fountains”.
Fermor recounted this episode to the Italian journalist and writer Paolo Rumiz sixty years later, pondering the fact that today the inestimable Iraqi heritage has been devastated.
He noted how well prepared soldiers once were, pointing out that he had been sent to Greece because he had studied Homer and Kreipe because he had been a classics scholar. It is true that the classicistic background of much of the Reich’s hierarchy did nothing to prevent the Shoah or the incalculable catastrophe of World War II. Nevertheless, it is equally true that in this new world order/disorder we can glimpse a different distinction. While there is no question that World War II unavoidably and definitively brought conflict to the level of civilians, shifting from the battlefields of soldiers, the belligerents of the more recent war – not worldwide but scattered nevertheless – have counted historical legacy among the victims. This does not apply only to the so-called western front: the fallen in this battle of the symbolic include the Buddhist statues of Bamiyan in Afghanistan, which were initially saved to attract tourists but were then destroyed by the bludgeon of visual fundamentalism.
In a certain way, a war that operates on the level of symbolism and identity becomes iconoclastic. If the “other side” can be recognized through the value given to the image of a history, an artistic and cultural path, the simplest way to make people forget it is to annihilate or pillage whatever bears witness to such treasure.
In Costantini’s work, the visual synthesis of this ideological maxim merges with the imperative will to maintain a constant focus on the daily aspects of the conflict. A woman raises her hands, coloured red, in the middle of Polyclitus’ “Doryphorus”, captioned in German (to remind us that the Germans were the ones who gave us the weapon of archaeology). A few words with over-stylized gestures convey the setting: Operation Free Iraq, some of the places that give even the most absent-minded the feeling of guilt swept under the home carpet, Kirkuk, Mosul, a non-cathartic but evocative ritual. The elements of each work are an alphabet of worn-out memory and its gradual fading away. They form a sort of funeral pall of our conscience in the face of injustice committed not by a group of organized terrorists, but by the states of which we are taxpaying citizens. The epiphany of the classical work leads us back to the most sublime interpretation of our democratic culture, which “has drunk at that fountain”. It is a veteran epiphany, one that bears the visible signs of contradictions and dead ends. It is a visual alphabet whose narration is perturbing and it brings us back to an image we would rather not see. In recounting distorted reality, reality itself becomes an analogy and symbol, and thus facts are transformed into recognition. The epiphanic process of these works unquestionably reveals much of the Dionysian and little of the Apollonian of classicistic ideology. And, yes, Sir Fermor is probably right: the new generals are also less cultivated than the old ones.
Elettra Stamboulis
The episode is described in Rumiz’s book Annibale (Milan 2008). It was also made into a film in 1957, Ill Met by Moonlight starring Dirk Bogarde.
Dioniso in Iraq
Catalogo "Daily Iraq"
LibriAparte, 2009

Sir Patrick Leigh Fermor è uno dei più importanti scrittori di letteratura di viaggio. Ma è stato anche coordinatore per l’esercito britannico nel 1944 della resistenza antinazista a Creta. In quella veste egli ebbe un’idea piuttosto ardita, ma che andò a buon fine. Organizzò infatti la cattura del generale del Reich Kreipe, utilizzando partigiani greci travestiti da tedeschi. Il prigioniero fu nascosto in una grotta e fu lì che un giorno l’inglese lo vide, mentre guardava con aria sognante le pendici del monte Ida coperte di neve, mormorando un verso di Orazio “Vides ut alta stet nive Candidum Soracte”. Il futuro baronetto britannico d’impulso proseguì la poesia latina a memoria. Il generale nazista rispose stupito: “Ach so, Herr Major”. E poi concluse: “Vedo che abbiamo bevuto alle stesse fonti”.
Fermor ha raccontato sessant’anni dopo questo episodio al giornalista e scrittore italiano Rumiz , riflettendo su come oggi si sia fatta strage dell’inestimabile patrimonio iracheno: “Pensi a quanto erano preparati i militari di una volta.
Io ero stato mandato in Grecia perché avevo studiato Omero e Kreipe aveva condotto studi classici”. È pur vero che la formazione classicista di tanta parte della gerarchia del Reich non impedì né la Shoah né in generale l’incalcolabile catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia è vero che intravediamo in questo nuovo ordine/disordine mondiale un diverso tratto distintivo. Se è vero che la Seconda Guerra Mondiale ha portato in modo ineludibile e definitivo il conflitto tra i civili, sottraendolo ai campi di battaglia dei militari, i belligeranti di questa guerra forse non mondiale, ma disseminata, hanno inserito anche il patrimonio storico tra le vittime. Questo non vale solo per il cosiddetto fronte occidentale: tra i caduti di questa battaglia del simbolico vanno annoverate anche le statue buddiste di Bamiyan in Afghanistan, inizialmente salvate a fini turistici e poi cadute sotto la clava dell’integralismo visivo.
Una guerra che opera sull’ordine simbolico e identitario diventa in qualche modo iconoclasta. Se l’altro può essere riconosciuto attraverso il valore dato dall’immagine di una storia, di un percorso artistico e culturale, il modo più semplice per farlo dimenticare è annientare o saccheggiare ciò che testimonia tale ricchezza.
Nel lavoro di Costantini la sintesi visiva di tale dettato ideologico si coniuga alla volontà imperativa di mantenere un’attenzione costante sul quotidiano del conflitto. Una donna alza le mani colorate di rosso, al centro il doriforo di Policleto con didascalia in tedesco (a ricordarci che furono loro, i tedeschi, a darci l’arma dell’archeologia), poche parole con gestualità calligrafica ci conducono al contesto. Operazione Liberazione dell’Iraq, alcuni luoghi che riconducono anche i più distratti a un senso di colpa nascosto sotto il tappeto di casa, Kirkuk, Mosul, un rituale non catartico, ma evocativo. Gli elementi di ciascuna opera sono un alfabeto della memoria consunta e del suo sbiadirsi, sono una sorta di lenzuolo funebre della nostra coscienza di fronte all’ingiustizia commessa non più da un gruppo di organizzati terroristi, ma dagli stati di cui siamo cittadini paganti tasse. L’epifania dell’opera classica ci riconduce all’interpretazione più sublime della nostra cultura democratica, che “a quella fonte ha bevuto”. Si tratta di un’epifania reduce, che porta i segni visibili della contraddizione e del vicolo cieco. È un alfabeto visivo, la cui narrazione è perturbante e ci rimanda un’immagine di noi che non vorremmo vedere. Raccontare la realtà deforma, la realtà stessa passa a diventare analogia e simbolo e dunque i fatti si trasformano in riconoscimento. Il procedimento dell’epifania di queste opere porta sicuramente alla luce molto di dionisiaco e poco dell’apollineo dell’ideologia classicista. E, sì, probabilmente ha ragione sir Fermor, i nuovi generali sono anche meno colti di quelli vecchi.
Elettra Stamboulis
L’episodio è narrato nel libro di Paolo Rumiz, Annibale, Milano 2008. Sull’episodio esiste anche un film degli anni ’50 con Dirk Bogarde dal titolo italiano Colpo di mano a Creta (tit. or. Ill Met by Moonlight).
Mappe alternative per città senza memoria
Mappe alternative per città senza memoria, inguineMAH!2009 – anno7 (2009)

Se vogliamo combattere questo mondo, dobbiamo farlo combattendo la sua caratteristica preponderante, la transitorietà. È l’opinione di Kafka, ma anche di chi registra in qualsiasi modo un aspetto della realtà. E la transitorietà delle esperienze che hanno riempito alcuni luoghi delle nostre città è stato il tema di questa sezione di inguine.
Se in tutti i tentativi di presa della transitorietà, vige la menzogna, è il contenuto di verità della menzogna che ci interessa. La sua limitatezza non può frenare lo stimolo naturale della ricerca.
Questi luoghi essenzialmente transitori, occupati, questi spazi che hanno sedimentato più parole e suoni che carte e registrazioni, sono stati spesso rappresentati dalla retorica della menzogna. Oppure dalla sua compare più temibile, l’amnesia. Visto che non si sono mai posti l’obiettivo della memoria della propria esistenza, sempre tesi ad esistere e a pensare ad un orizzonte futuro, al fare immanente, gli spazi occupati non lasciano traccia. Finiscono esclusivamente nella memoria individuale di chi li ha praticati. Non è certo obiettivo di questo numero ovviare alla loro transitorietà, anche perché chi li ha animati e vissuti probabilmente non aveva nella loro sopravvivenza un obiettivo, ma in quello che dicevano e che offrivano in quel momento lì, per quel attimo che dura un millennio.
Ci sono poi altri luoghi che si sono nascosti nelle pieghe. Ogni città è fatta di molte mappe: quelle ufficiali, quelle dei luoghi nascosti, quelle dei posti che non ci sono più, quelle dei luoghi che sono appartenuti a molti e poi sono scomparsi, delle nostre geometrie quotidiane. Attenzione, non vogliamo avventurarci nelle definizioni non luoghiste amate da molta critica contemporanea. Anzi, è semmai vero il contrario. I luoghi di cui si racconta sono proprio quelli densi di esperienza antropologica.
È evidente anche la forte impronta soggettiva del ricordo. Questa ci fornisce quella patina malinconica che avvolge tutte le storie realizzate. Lo sguardo verso se stessi, quel sé che ancora non ha necessità di raccontarsi perché troppo intento a vivere, è sempre vicino all’umore di Saturno, la malinconia. Essa è la porta più vicina al desiderio oscuro, al rapporto interrotto con un oggetto che viene sottratto alla coscienza, come si esprimeva Freud. È quella malinconia che impera nel balbettio odierno di molta politica, che fatica a riappropriarsi dei luoghi e delle vite che li hanno resi possibili, di quelle parole e di quel ideare che hanno sancito anche il proprio accesso al pensare di gruppo. Molti si sono persi, alcuni si sono arresi, altri balbettano. Ovunque questo senso d’inopportuna malinconia, che un po’ di sente anche in queste storie che raccontano dei luoghi sottratti.
Forse la soluzione è negli ultimi versi della Dickinson, nella possibilità “che si alteri la tenebra”. Perché è proprio facile abituarsi al buio. Spesso sento, in questo sottrarre continuamente luoghi comuni alla collettività con la menzogna della restituzione alla comunità di tali spazi (un classico direi della propaganda sgombratoria), che piano piano diventerò cieca, assorbita dal buio della città senza luoghi di incontro.
Ci abituiamo al buio
Quando la luce è spenta;
Dopo che la vicina ha retto il lume
che è testimone del suo addio, ù
per un momento ci muoviamo incerti
perché la notte ci rimane nuova,
ma poi la vista si adatta alla tenebra
e affrontiamo la strada a testa alta.
Così avviene con tenebre più vaste.
Quelle notti dell'anima
In cui nessuna luna ci fa segno,
Nessuna stella interiore si mostra.
Anche il più coraggioso prima brancola
un pò, talvolta urta contro un albero,
ci batte proprio la fronte;
ma imparando a vedere,
o si altera la tenebra
o in qualche modo si abitua la vista
alla notte profonda,
e la vita cammina quasi dritta».
E. DICKINSON, (trad. it. Tutte le Poesie,
Mondadori, Milano, 1997, p. 459).





























































